Il Caso Di Elvira Dones
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Worlds in Translation: European Novels in Albanian Language
552571-CREA-1-2014-1-AL-CULT-LIT1 Generated on: Sep 30, 2021 Subprogramme: Culture Action: Literary translation projects Project Title Worlds in translation: European novels in Albanian language Project Coordinator Organisation TOENA Address RRUGA M GJOLLESHA 1420 , 1001 1028 TIRANA , Albania , AL Project Information Project Number 552571-CREA-1-2014-1-AL-CULT-LIT1 Start Date Oct 1, 2014 End Date Sep 30, 2016 Union Grant 62,927.85 EUR This document has been generated by Creative Europe Project Results Platform Page 1 of 2 552571-CREA-1-2014-1-AL-CULT-LIT1 Generated on: Sep 30, 2021 Project Summary Worlds in translation: European novels in Albanian Language is a literary translation Project made possible by the Creative Europe policy to help and promote the Translation, publication and promotion of a package of nine novels chosen by Toena Publishing House with the aim to translate, distribute and promote a number of contemporary novels in Albania and Albanian Diaspora. Toena has undertaken in order to fulfil the project goals a series of activities and steps that include: 1. The accurate creation of a collection, containing the nine books in the package, connected by the details of a collection like, same format and main colours for all the books included, a name for the collection (in Albanian: Botë në përkthim: Pikëtakim i kulturave evropiane). 2. Participation in different Literary Festivals and Bookfairs, presented in our application and others where we usually participate during the year like: The Art and Book Festival (2015, Tirana), Tirana National Bookfair, International Bookfairs in: Turin, Thessaloniki, Skopje, Geneva, Pristina, local BookFairs in Albania like: Durres, Saranda, Tirana, Vlore, others not included in the Project like Montenegro, etc. -
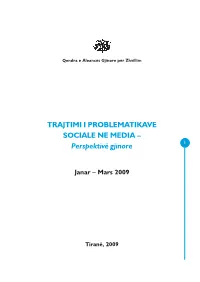
Trajtimi I Problemativave Ne Media.Pmd
Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim TRAJTIMI I PROBLEMATIKAVE SOCIALE NE MEDIA – Perspektivë gjinore 1 Janar – Mars 2009 Tiranë, 2009 Përgatitja dhe botimi i këtij materiali u mundësua nga OSFA – Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, në kuadër të projektit “Trajtimi i problematikave sociale në media – perspektivë gjinore”, zbatuar nga “Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim”. Autoret: Etleva Martiri Linda Mëniku Migena Kapllanaj © 2009. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara për Qendrën e Aleancës Gjinore për Zhvillim”, Tiranë/Shqipëri. 2 Botuar nga: Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim Kutia Postare 2418, Tiranë Tel/Fax: (++355) 42 255 514/5 E-mail: [email protected] Web site: www.gadc-al.org Faqosja & Kopertina: Elvira Osmani PËRMBAJTJA HYRJE.................................................................................... 5 Fokusi i monitorimit......................................................................... 7 Roli i medias në promovimin e barazisë gjinore ............................... 8 Gazetarë apo gazetare?.............................................................. 9 Gratë subjekte apo objekte të medias?..........................................10 GRUAJA NË VENDIMMARRJE DHE POLITIKBËRJE.......13 Analiza e shkrimeve të monitoruar për gratë në vendimmarrje.14 3 1. Fushat e pasqyruara ...........................................................17 2. Shkrimet për përfaqësimin politik të grave...........................19 3. Si pasqyrohen gratë në vendimmarrje?.................................21 3.1. Kur gratë -

CURRICULUM VITAE Prof. Dr. AURELA ANASTASI Adresa E Punës
CURRICULUM VITAE Prof. Dr. AURELA ANASTASI Adresa e punës: Universiteti Tiranës Fakulteti i Drejtësisë Rr. Milto Tutulani Tiranë-Shqipëri Tel: 04/222537 Cel: 0682031447 Tiranë, 2009 ARSIMI Prill, 07.1965 Lindur në Vlorë, Shqipëri Qershor 1983 mbaroj shkollën e mesme të arsimit të përgjithshëm në qytetin e lindjes, me rezultate shumë të larta në mësime (mesatare e përgjithshme e lëndëve 9,99). Shtator 1983-gusht 1987 ndjek studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. 30 Qershor 1987 mbroj diplomën me temë: “Karakteristikat e shtetit dhe të së drejtës shqiptare 1912- 1914” dhe diplomohem Jurist, me rezultate të larta (mesatare e përgjithshme 9,98) . Shtator 1987- shtator 1990 ndjek dhe përfundoj kualifikimin pasuniversitar pranë Katedrës së Teorisë së Shtetit dhe të së Drejtës, duke mbrojtur 2 provime të nivelit universitar dhe 5 provime të nivelit pasuniversitar. KUALIFIKIMI SHKENCOR JASHTË VENDIT (PASUNIVERSITAR) Nëntor 1992- prill 1993 Kurs specializimi pasuniversitar, mbi Historinë e së Drejtës, pranë Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetin e Barit, Itali. 1 shkurt- 15 mars 1994 Specializim (6 javor) në kuadrin e Programit “Tempus”, pranë Universitetit të Trentos, Itali 5-30 Tetor 1994 Kurs azhurnimi për të drejtën, (tri javor) pranë Universitetit të Bolonjës Itali. Shtator-Dhjetor 1995 Specializim pasuniversitar (tre mujor) në fushën e Historisë së Institucioneve, pranë Universitetit “Rene Descartes”, Paris V. 1 Shtator-6 Dhjetor Kurs specializimi për të Drejtën e Zhvillimit, pranë Institutit Ndërkombëtar IDLI, Romë, Itali. 1 -15 Shtator Kurs trajnimi në të drejtën Kushtetuese, pranë Universitetin Kajros, Egjipt 5 -30 Nëntor Kurs kualifikimi trejavor në Universitetin e Athinës (Greqi), të Bordosë (Francë) dhe të Napolit (Itali). -

Revista Euromediterranean Nr. 3
BOTIM I UNIVERSITETIT MESDHETAR TË SHQIPËRISË EUROMEDITERRANEAN Revistë periodike shkencore 3 Dhjetor 2012 Tiranë, Dhjetor 2011 © UMSH PRESS EUROMEDITERRANEAN Revistë shkencore Botim i UNIVERSITETIT MESDHETAR TË SHQIPËRISË Nën Drejtimin e Akad.Asoc. Prof. Dr Anastas ANGJELI Bordi i Nderi Kryeredaktor Prof.Dr.Arben Put MA. Ilir HEBOVIJA Prof.Dr.Artistotel Pano Prof.Dr.Sabah Hilmija Prof.Dr.Ilia Kristo Redaktorë Shkencore Prof.Dr.Emin Riza MA.Nevila RAMA Prof.Dr.Vasil Tole MA.Kriton KUÇI Bordi Drejtues-Shkencor -Editorial Kryetar Prof.Dr.ANASTAS ANGJELI Akademik i Asoc. Anëtarë Prof.Dr.Kosta Bajraba Prof.Dr Ilia Kristo Prof.Dr. Esmeralda Uruçi Prof.Dr. Stefan Çapaliku MA. Ben Blushi Prof.Asoc. Mimoza Manxhari Prof.Dr.Orfea Dhuci Dr. Hysen Çela Dr. Altin Hoti Dr. Fatos Ibrahimi Dr.Skender Demaliaj MA. Gjergj Teneqexhi MA. Ardian Petollari MA. Nevila Rama MA Jona MARASHI MA. Ilr Aliaj MA.Besnik Leskaj MA. Kriton Kuci MA. Etleva Vertopi MA.Merita Myftari MA. Emilio Cika Kopertina Quick Advertise Faqosja: Dafina Stojko © UMSH PRESS Shtypyr: GEER, 2012 PËRMBAJTJA DREJT SHQIPËRISË SË ZHVILLUAR: SKENARË LIGJORE DHE FINANCIARË PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË DHE SISTEMIT BANKAR Anastas ANGJELI Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë Ilir BARJABA Stanford University Kristaq GJYLI Universiteti i Tiranës ........................................................................................................ 7 KOMPANITE BULLGARE PERBALLE KRIZES GLOBALE 2008-2009 Donika ANDREEVA University of National and World Economy, Sofia, Bullgari ................................... -

SYRIZA VICTORY in GREEK PARLIAMENTARY ELECTIONS, JANUARY 2015: Perceptions of Western Balkan Media & Opinion Makers
SYRIZA VICTORY IN GREEK PARLIAMENTARY ELECTIONS, JANUARY 2015: Perceptions of Western Balkan Media & Opinion Makers Maja Maksimović Bledar Feta Katherine Poseidon Ioannis Armakolas Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) South-East Europe Programme Athens 2015 SYRIZA VICTORY IN GREEK PARLIAMENTARY ELECTIONS, JANUARY 2015: Perceptions of Western Balkan Media & Opinion Makers Contents About the Authors .............................................................................................................................................................. 3 About the South-East Europe Programme .............................................................................................................. 5 Preface .................................................................................................................................................................................... 6 Executive Summary........................................................................................................................................................... 7 PART I - The January 2015 Parliamentary Elections in Greece: Perceptions of Western Balkan Media .................................................................................................................................................................................... 12 Introduction ................................................................................................................................................................ -
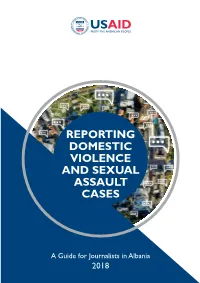
Reporting Domestic Violence and Sexual Assault Cases
REPORTING DOMESTIC VIOLENCE AND SEXUAL ASSAULT CASES A Guide for Journalists in Albania 2018 REPORTING DOMESTIC VIOLENCE AND SEXUAL ASSAULT CASES A Guide for Journalists in Albania 2018 Disclaimer This manual is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this manual are the sole responsibility of the East-West Management Institute and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. 3 Table of Contents WHY A GUIDE FOR JOURNALISTS IN DOMESTICVIOLENCE AND SEXUAL ASSAULT .........................................................................................5 TERMS OF REFERENCE ...........................................................................7 DOMESTICVIOLENCE AND SEXUAL ASSAULT IN ALBANIA ..10 IMPORTANT INTERNATIONAL CONVENTIONS ..........................12 DOMESTICVIOLENCE AND SEXUAL ASSAULT LAWS IN ALBANIA .................................................................................................18 ETHICAL ISSUES ........................................................................................22 VICTIM’S IDENTITY .............................................................................................................22 USING DETAILS IN A STORY ................................................................................................26 USE OF LANGUAGE - WHAT TO AVOID AND WHAT TO USE .............................................27 REPORTING WITH SENSITIVITY ...........................................................................................28 -

Media Në Shqipëri, Përpara Pasqyrës Media Në Shqipëri, Përpara Pasqyrës Media Në Shqipëri, Përpara Pasqyrës
MEDIA NË SHQIPËRI, PËRPARA PASQYRËS MEDIA NË SHQIPËRI, PËRPARA PASQYRËS MEDIA NË SHQIPËRI, PËRPARA PASQYRËS 1 77 Të dashur lexues, Në dt.24 Nëntor 2017, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) me mbështetje të organizatës suedeze Civil Rights Defenders organizoi konferencën “Media në Shqipëri përpara pasqyrës”. Qëllimi i konferencës ishte vendosja e medias para pasqyrës për të diskutuar problematikat dhe sfidat me të cilat po përballet media dhe gazetarët në vendin tonë. Zakonisht gazetarët ndjekin dhe pasqyrojnë aktivitetet e terrenit, ndërkohë që problematikat që ekzistojnë për lirinë e shprehjes në Shqipëri nuk kanë patur vëmendjen e mjaftueshme të komunitetit të gazetarëve dhe rrje- dhimisht edhe të publikut, i cili ka si burim kryesor informimi median. Situata e aktuale e medias në Shqipëri u trajtua në këndvështrime reale dhe kritike në shumë dimensione nga të ftuarit e kësaj kon- ference, mes të cilëve ambasadorë dhe përfaqësues të trupës diplomatike në vendin tonë, drejtues të redaksive të lajmeve, studiues e pedagogë të gazetarisë, juristë e përfaqësues të shoqërisë civile. Me një larmi temash, të ftuarit analizuan problemet më të mëdha me të cilat përballet tregu mediatik sot, duke evidentuar edhe ndikimin e trendit global i cili ka shënuar regres në drejtim të respektimit të fjalës së lirë por gjithashtu edhe ndikimin e zhvillimit të epokës digjitale, të lidhjeve të papërshtatshme të interesave të biznesit dhe politikës me median. Në fokus të kësaj konference ishte edhe nevoja për një respektim më të mirë të të drejtave të gazetarëve, një pjese e të cilëve punon në informalitet, kufizohen për shkak të linjës editoriale dhe ndikimit të pronarëve të medias në transmetimin e fjalës së lirë dhe analizës profesionale. -

Mediat E Shkruara, Menaxhimi Kundër Krizës
REPUBLIKA E SHQIPERISE UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I HISTORISE DHE I FILOLOGJISE Tel/Fax: +355 4 369 987/ www.fhf.edu.al Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë Punim Doktorature Tema: Mediat e shkruara, menaxhimi kundër krizës Sami Nezaj Drejtues shkencor: Prof.Dr. Hamit Boriçi Tiranë, 2013 1 TABELA E LËNDËS HYRJE I PJESA I Kriza e medias së shkruar, tiparet dhe ambienti i krizës Kapitulli i parë Kriza e medias së shkruar 1.1.1 Shfaqja e krizës dhe tiparet e saj në Evropën Perëndimore dhe në SHBA 1.1.2 Shfaqja e krizës dhe tiparet e saj në vendet e rajonit 1.1.3 Shfaqja e krizës dhe tiparet e saj në Shqipëri. 1.1.3.1 Kriza në shtypin shqiptar, tiparet e krizës, 1.1.3.2 Kriza editoriale e gazetave, kryqëzimi mes lirisë së shtypit dhe krizës editoriale 1.1.3.3 Kriza për shkak të pronësisë 1.1.3.4 Censura, autocensura, cilësia e informacionit, kontributi në krizë 1.1.3.5 -Kriza e shtypit si krizë e menaxhimit. Kapitulli i dytë Mediat e tjera dhe teknologjia e komunikimit në Shqipëri, implikimet në krizën e shtypit të shkruar 1.2.1 Gazetaria elektronike si alternativë e shtypit të shkruar 1.2.2 Tregu audioviziv në vend, ndikimi në krizën e shtypit të shkruar 1.2.3 Interneti dhe telefonia celulare një tjetër konkurent në fushën e tregut të informacionit Kapitulli i tretë Analiza PEST, analiza konkuruese dhe analiza e stakeholders për industrinë e medias së shkruar 1.3.1 Analiza PEST për industrinë e medias së shkruar 1.3.1.1 Mjedisi politik 1.3.1.2 Mjedisi ekonomik ne Shqipëri për industrinë e medias së shkruar 1.3.1.3 Mjedisi social ne Shqipëri për industrinë e medias së shkruar. -
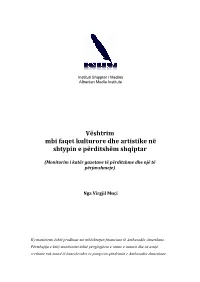
Vështrim Mbi Faqet Kulturore Dhe Artistike Në Shtypin E Përditshëm Shqiptar
Instituti Shqiptar i Medias Albanian Media Institute Vështrim mbi faqet kulturore dhe artistike në shtypin e përditshëm shqiptar (Monitorim i katër gazetave të përditshme dhe një të përjavshmeje) Nga Virgjil Muçi Ky monitorim është prodhuar me mbështetjen financiare të Ambasadës Amerikane. Përmbajtja e këtij monitorimi është përgjegjësia e vetme e autorit dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron qëndrimin e Ambasadës Amerikane. 1. Hyrje. Vështrim i përgjithshëm Me kënaqësi konstatojmë se ndryshe nga katër vjet më parë peizazhi i shtypit kulturor dhe artistik në faqet e të përditshmeve shqiptare ka ndryshuar në mënyrë të ndjeshme. E megjithatë, me keqardhje vëmë re se edhe sot që shkruajmë këto radhë nuk ka një gazetë mirëfilli letrare. Po kështu në tregun mediatik mungojnë revistat e përmuajshme me profil të qartë letrar dhe/ose artistik. Në mënyrë të çrregullt vazhdojnë të dalin revistat “Përpjekja” (e cila është më shumë një revistë e mendimit kritik), “Aleph” dhe “Mehr Licht” (ndërsa këto dy të fundit me profil të qartë letrar e kulturor), ekzistenca e të cilave është gati-gati një heroizëm, duke qenë se e kanë të pamundur të mbajturit prej shitjeve ose prej publikimit të reklamave, ndaj dhe botuesit e tyre, njerëz të letrave, janë të shtrënguar të trokasin në dyert, shpesh të shurdhëta, të sponsorëve të ndryshëm. Mund të themi se deri më sot nuk ka një politikë nga ana e qeverisë për të marrë në mbrojtje këtë specie në zhdukje e sipër. E vërteta është se një organ kulturor e letrar i mirëfilltë duke mos qenë në gjendje të konkurrojë në kushtet e tregut e ka të vështirë, për të mos thënë të pamundur, ekzistencën pa mbështetje financiare të institucioneve ose, të themi kështu, të mecenatëve të ndryshëm. -

European Union and the Modernization of Albania
Of Knights and Squires: European Union and the Modernization of Albania Ermal Frasheri CID Research Fellow and Graduate Student Working Paper No. 81 March 2016 Copyright 2016 Frasheri, Ermal; and the President and Fellows of Harvard College Working Papers Center for International Development at Harvard University Of Knights and Squires: European Union and the Modernization of Albania Ermal Frasheri† I. Introduction ................................................................... 2 II. The Entanglement of the Periphery: European Integration as a Development Strategy? ........................ 8 A. How it all Began ................................................... 12 B. The Knight Enters: European Union and the Politics of Integration and Economic Development ......................................................... 18 C. The Aftermath ....................................................... 25 III. Taming the Beast: The Politics of "Rule of Law" Reforms ....................................................................... 29 A. From Europe’s Tiger to Europe’s Bandit ............. 31 B. Agents of Reforms ................................................ 36 IV. From Communism to Europeanization: A Political Culture of Transition ................................................... 43 † Fellow, Center for International Development, at Harvard University; Adjunct Professor, Sturm College of Law, at Denver University. I would like to thank my mentors, Professors David Kennedy and Duncan Kennedy for teaching me! Words are not enough to express the depth of gratitude I feel towards them. In my European integration studies, I have benefited greatly from the advice and discussions with Professors Daniela Caruso, Glyn Morgan, Hans Helmut Kotz, Philip Genschel, and I would like to take the opportunity to thank them. Professors Joel Trachtman and Robert Lawrence have been generous with their advice and guidance on international trade law and policy, and I am much obliged to them. This paper brings together various arguments that I have explored in my S.J.D. -
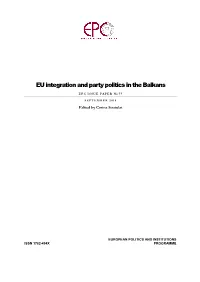
EU Integration and Party Politics in the Balkans
EU integration and party politics in the Balkans EPC ISSUE PAPER NO. 77 SEPTEMBER 2 0 1 4 Edited by Corina Stratulat EUROPEAN POLITICS AND INSTITUTIONS ISSN 1782-494X PROGRAMME The EPC’s Programme on European Politics and Institutions With the entry into force of the Lisbon Treaty, the new focus of this programme is on adapting the EU’s institutional architecture to take account of the changed set-up and on bringing the EU closer to its citizens. Continuing discussion on governance and policymaking in Brussels is essential to ensure that the European project can move forward and respond to the challenges facing the Union in the 21st century in a democratic and effective manner. This debate is closely linked to the key questions of how to involve European citizens in the discussions over its future; how to win their support for European integration and what are the prospects for, and consequences of, further enlargement towards the Balkans and Turkey. This programme focuses on these core themes and brings together all the strands of the debate on a number of key issues, addressing them through various fora, task forces and projects. It also works with other programmes on cross-cutting issues such as the reform of European economic governance or the new EU foreign policy structures. ii Table of Contents About the authors .................................................................................................................................... v List of tables ......................................................................................................................................... -

The Case of Albania and the Region 2 Acknowledgments
Ghost parties and the deformation of democracy: the case of Albania and the Region 2 Acknowledgments This paper was made possible through the financial support of the Alumni Program Grant awarded to the author by the Open Society Institute. The author wishes to express its gratitude to the donor as well as to the mentors, contributors and editors of her work. 3 4 Table of contents: GHOST PARTIES AND THE DEFORMATION OF DEMOCRACY: THE CASE OF ALBANIA Alba Çela............................................................................. 7 INVISIBLE PARTIES FOR A CLEAR VICTORY? EXPLAINING THE ROLE OF THE GHOST PARTIES IN THE MACEDONIAN POLITICAL SYSTEM Mišo Dokmanović, PhD .................................................... 45 SMALL AND GHOST POLITICAL PaRTIES IN KOSOVA Adnan Ahmeti.................................................................... 65 5 6 Ghost parties and the deformation of democracy: the case of Albania Alba Çela Tirana June 2012 7 Table of contents: 1. Introduction .................................................................. 9 2. Chasing ghosts in the political arena .............................12 3. The state of Albanian democracy ..................................20 4. Legal provisions .............................................................24 5. Implications for democracy and representativeness ....27 6. Alternate Views ............................................................31 7. Conclusion .................................................................. 33 8. Recommendations .......................................................36