Sa Lilla (Via Dell’Argento 2 Parte)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Maria Gabriella Mallica
MARIA GABRIELLA MALLICA CURRICULUM CULTURALE Anno 1981 - Unitamente ad altri soci ho fondato la cooperativa “Curatoria Bonorzuli”, i cui scopi sociali erano incentrati sulla ricerca, studio, sviluppo e diffusione della Storia della Sardegna, nei diversi periodi storici, in ambito archeologico, monumentale, archivistico, etnografico; Insieme al dott. Giovanni Battista Mallica, presidente della cooperativa, e ai soci della stessa cooperativa: - ho organizzato e realizzato la pulizia ed il restauro delle travature lignee del chiostro di S. Lucia, convento francescano in San Gavino Monreale; - ho organizzato e realizzato a San Gavino Monreale, un corso estivo di Storia della Sardegna, aperto agli studenti delle scuole Medie Inferiori e Superiori; - ho coordinato e insegnato Educazione Civica e Storia della Sardegna, in un corso per ceramisti finanziato dalla Regione Sarda tenutosi a San Gavino Monreale. Anno 1982 - Ho coadiuvato nella organizzazione e realizzazione, nei Comuni di Sardara, Pabillonis, Masullas, San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini, la Mostra Etnografica Itinerante “I nostri tesori”, che ricostruiva gli ambienti domestici e di lavoro della civiltà contadina in quei territori. La Mostra era preceduta da un accurato lavoro di ricerca e attività di “prestito” degli oggetti esposti; Negli stessi Comuni, la Mostra Itinerante era aperta e inaugurata da conferenze tenute da docenti universitari (proff. F. C. Casula, L. Orrù, G. Sorgia ) e da Responsabili delle Soprintendenze Archivistica, Archeologica e ai B. A.A.A.S. (G .Todde, R. Porrà, F. Barreca, V. Santoni, G. Ugas, A. Ingegno ). Unitamente al Dott. G. B. Mallica ne ho curato l’impostazione e la realizzazione; - ho partecipato con altri autori (G. B. Mallica, G. -

03Bis News Concorsi 19
Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del Centro Servizi per l’inserimento lavorativo Comune di San Basilio Telefono/Fax 070/9816015 - E-mail: [email protected] INFORMAZIONI Newsletter aggiornata al 19/11/2012 Interventi per lo sviluppo del servizio civico volontario: avviso Dal giorno 13/11/2012 al giorno 03/12/2012 sono aperti i termini di presentazione delle domande nell’ambito degli Interventi per lo sviluppo del servizio civico volontario - anno 2012, “Avviso pubblico per la selezione di progetti di utilità sociale” da parte di Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, Organizzazioni non governative, senza finalità di lucro, operanti nei settori relativi all’Assistenza/Sociale e Socio- Sanitaria, Educazione e Promozione culturale, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente e altri campi di interesse sociale, ambientale e culturale. I progetti presentati dagli Organismi dovranno coinvolgere soggetti residenti in Sardegna, privi di occupazione, a partire dai 18 anni di età ed in età lavorativa. L’avviso integrale è disponibile anche all’indirizzo www.regione.sardegna.it (percorso: Assessorati – Assessorato del lavoro – Servizi – Bandi e gare; oppure nella sezione “Consulta procedimenti” dedicata al Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione, raggiungibile attraverso il link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9003&na=1&n=10. Le candidature dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 3 dicembre 2012 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e della Formazione, Via Caravaggio snc - 09121 Cagliari. -

Cagliari ARMUNGIA X X BALLAO X X X ESCALAPLANO X X X
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il COMMISSARIO DELEGATO ex OCDPC n. 122 DEL 20 PRESIDENTZIA NOVEMBRE 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PRESIDENZA PROTEZIONE CIVILE PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI NOVEMBRE 2013 NELLA REGIONE Il Commissario delegato per l'emergenza AUTONOMA DELLA SARDEGNA Tabella A – Allegata all'Ordinanza n. 16 del 10/12/2013 come modificata dalle Ordinanze n. 17 e n. 18 del 12/12/2013 Interventi di Interventi di Interventi Danni al soccorso e Provincia COMUNI somma provvisionali patrimonio assistenza alla urgenza urgenti pubblico popolazione ARMUNGIA XX BALLAO XXX ESCALAPLANO XXX ESTERZILI XXX Cagliari SEULO X SILIQUA XXX VILLAPUTZU X VILLASALTO X VILLASOR XX BITTI XXX DESULO XX DORGALI XXX GALTELLI' XXXX IRGOLI XXX LOCULI XXX LODE' XXX LULA XXX MACOMER XX Nuoro NUORO XXX OLIENA XX ONANI' XXX ONIFAI XXX ORGOSOLO XX OROSEI XXX POSADA XX SINISCOLA XX TORPE' XXXX BAULADU X GONNOSTRAMATZA X MARRUBIU XXX MASULLAS XX MOGORO XXX MORGONGIORI XX Oristano ORISTANO XX PALMAS ARBOREA XXXX SAN NICOLO' D'ARCIDANO XX SIRIS X SOLARUSSA XXX TERRALBA XXXX URAS XX ALA' DEI SARDI XX ARZACHENA XXXX BERCHIDDA XX BUDDUSO' X BUDONI XX Olbia-Tempio LOIRI PORTO SAN PAOLO XXX MONTI XX OLBIA XXXX PADRU XXX SANT'ANTONIO DI GALLURA XX TELTI XX PABILLONIS XX SAN GAVINO MONREALE XXX Medio SANLURI XXX Campidano SARDARA X VILLACIDRO XX ARZANA XX GAIRO XXX JERZU XX SEUI XXX Ogliastra TALANA XX URZULEI XX USSASSAI X VILLAGRANDE STRISAILI XX COMUNI INTERESSATI E DATI PLUVIOMETRICI 84,4 PRESIDÈNTZIA 89,6 55,4 PRESIDENZA 60,6 ARZACHENA Il -
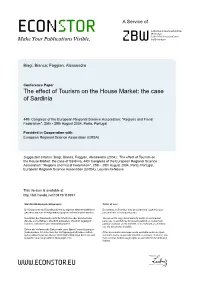
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Calendario Seconda Categoria Girone C 2017/2018
Calendario Seconda Categoria Girone C 2017/2018 GIORNATA 1 GIORNATA 2 GIORNATA 3 Andata: 08/10/2017 16:00 Ritorno: 04/02/2018 15:00 Andata: 15/10/2017 16:00 Ritorno: 11/02/2018 15:00 Andata: 22/10/2017 16:00 Ritorno: 18/02/2018 15:00 Armungia Calcio - Accademia Dolianova Accademia Dolianova - Gialeto 1909 Armungia Calcio - Serramanna Calcio Atletico Sanluri - Ussana Calcio Calcio Decimoputzu - Armungia Calcio Atletico Sanluri - Pabillonis 97 Gerrei - Cribbio 78 Cribbio 78 - Havana San Basilio Gialeto 1909 - Calcio Decimoputzu Gialeto 1909 - Pabillonis 97 Furtei - San Giorgio Donori Havana San Basilio - Gerrei Havana San Basilio - Furtei Pabillonis 97 - Segariu 1936 Monreale San - Furtei 1936 Monreale San - Calcio Decimoputzu Arixi Santa Lucia - Atletico Sanluri Gavino Gavino Serramanna Calcio - 1936 Monreale San San Giorgio Donori - Cribbio 78 San Giorgio Donori - Serramanna Calcio Gavino Segariu - Accademia Dolianova Segariu - Arixi Santa Lucia Ussana Calcio - Gerrei Ussana Calcio - Arixi Santa Lucia GIORNATA 4 GIORNATA 5 GIORNATA 6 Andata: 29/10/2017 15:00 Ritorno: 25/02/2018 15:00 Andata: 05/11/2017 15:00 Ritorno: 04/03/2018 15:00 Andata: 12/11/2017 15:00 Ritorno: 11/03/2018 15:00 Accademia Dolianova - Atletico Sanluri Armungia Calcio - Cribbio 78 Accademia Dolianova - Pabillonis 97 Calcio Decimoputzu - Segariu Atletico Sanluri - Calcio Decimoputzu Calcio Decimoputzu - Arixi Santa Lucia Cribbio 78 - 1936 Monreale San Gialeto 1909 - Furtei Cribbio 78 - Gialeto 1909 Gavino 1936 Monreale San - Gerrei Furtei - Segariu Furtei - Armungia -

La Sardegna Cresce Con L'europa
La Sardegna cresce con l’Europa Cagliaritano Territory Basilica of Archaeological area Project jointly funded by the European Union San Saturnino of Sant’Eulalia Operational programme ERDF 2007 – 2013 Cagliari Cagliari EUROPEAN UNION ERDF - European Regional Development Fund - Axis I, Activity line 1.2.3.a. REPUBBLICA ITALIANA P.O.R. ERDF Sardinia 2007-2013, Line 1 “Information Society”, Specific Goal 1.2. “Promoting and developing the information society with a particular attention to those key aspects that will sustain the development of the territory and the quality of life, as health, education and the promotion of culture”, Operational Goal 1.2.3. “Increasing the production of the digital contents”, Action Line of 1.2.3.a. “Actions for the production, publication and sharing on the web and on new media (DTV, mobile T, etc.) of digital contents concerning Sardinia’s culture, literature, music, territory and images for a social fruition”. Cultural heritage Cagliaritano We thank the Superintendence for the Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-An - thropological Heritage for the metropolitan city of Cagliari and for the provinces of Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias and Ogliastra, for the kind cooperation. Territory Basilica of San Saturnino | Cagliari Archaeological area of Sant’Eulalia | Cagliari Cultural heritage Unicity Srl: Sardegna Virtual Archaeology Coordination and Production 3D and 3D Render Reconstruction Cagliaritano and Production Virtual Guided Territory Visits and Virtual Views Production Communication and Multimedia Basilica of San Saturnino Testaluna Srl: Text: Mrs. Lucia Mura 3D Planning and Interactivity Mrs. Rossana Martorelli Polonord Adeste Srl: Archeological area USB Pendrive Production of Sant’Eulalia Text: Mrs. -

Orografia D O T T
TAV. 15 TAV. 16 TAV. 17 TAV. 18 TAV. 19 GAIRO GAIRO GAIRO SEULO GAIRO LOCERI LACONI SEULO GAIRO LOCERI NURALLAO GADONI SEULO LOCERI NURALLAO GADONI SEULO LOCERI NURALLAO GADONI SEULO LOCERI NURALLAO GADONI NURALLAO GADONI OSINI OSINI OSINI OSINI OSINI GAIRO LANUSEI GAIRO LANUSEI GAIRO LANUSEI GAIRO LANUSEI GAIRO LANUSEI BARISARDO BARISARDO BARISARDO BARISARDO BARISARDO SADALI SADALI SADALI SADALI SADALI USSASSAI OSINI USSASSAI OSINI USSASSAI OSINI USSASSAI OSINI USSASSAI OSINI SEUI SEUI SEUI SEUI SEUI VILLANOVATULO VILLANOVATULO VILLANOVATULO VILLANOVATULO VILLANOVATULO IERZU CARDEDU IERZU CARDEDU IERZU CARDEDU IERZU CARDEDU IERZU CARDEDU ISILI ISILI ISILI ISILI ISILI ULASSAI ULASSAI ULASSAI OSINI OSINI OSINI ULASSAI OSINI ULASSAI OSINI ESTERZILI GAIRO ESTERZILI GAIRO ESTERZILI GAIRO ESTERZILI GAIRO ESTERZILI GAIRO GERGEI NURRI 11 km NURRI 11 km GERGEI NURRI 11 km GERGEI NURRI 11 km GERGEI NURRI 11 km GERGEI SERRI SERRI SERRI SERRI SERRI SEUI SEUI SEUI SEUI (! SEUI ESCOLCA ESCOLCA ESCOLCA ESCOLCA ESCOLCA TERTENIA TERTENIA TERTENIA TERTENIA (! TERTENIA GERGEI GERGEI GERGEI GERGEI PERDASDEFOGU PERDASDEFOGU PERDASDEFOGU PERDASDEFOGU PERDASDEFOGU ORROLI ORROLI ORROLI ORROLI ORROLI MANDAS MANDAS MANDAS MANDAS MANDAS LOCERI LOCERI LOCERI LOCERI LOCERI ESCALAPLANO ESCALAPLANO LOCERI ESCALAPLANO LOCERI LOCERI LOCERI LOCERI ESCALAPLANO ESCALAPLANO OSINI OSINI OSINI OSINI OSINI LANUSEI LANUSEI (! LANUSEI LANUSEI LANUSEI GESICO GESICO GESICO GESICO GESICO (! SIURGUS IERZU SIURGUS IERZU SIURGUS IERZU SIURGUS -

<P> ARMUNGIA, IL FUTURO DIFFICILE DEL PAESE DI LUSSU
ARMUNGIA, IL FUTURO DIFFICILE DEL PAESE DI LUSSU (UNIONE SARDA) Armungia, 5 mar 2010 (L'Unione Sarda) - Sotto il nuraghe di pietra che domina il paese, nei vicoli del centro storico, si muovono poche persone, anziani soprattutto. Sono rimasti in pochi, cinquecento o poco più, a percorrere le strade che videro crescere nei primi del Novecento il leggendario Emilio Lussu, il capitano della Grande Guerra, il fondatore del Partito sardo d'azione, il ministro, il politico che per tutta la vita si batté per un popolo al quale rimproverava spesso un eccesso di subalternità ai potenti di turno. Nel bosco di Murdega, sulle colline del Gerrei e nelle valle del Flumendosa pochi caprari e rari pastori di pecore e maiali, una decina di greggi in tutto, vivono isolati, nel silenzio rotto da rare voci, nel quale i più romantici riescono ancora a sentire gli zoccoli di Stella e Regina, i cavalli sui quali Lussu partiva dalla casa di via Marconi per recarsi nella foresta. AI PIEDI DEL NURAGHE Sotto la torre di pietra, intorno alle case minime, nel cuore del paese sono tante le abitazioni abbandonate. «Eravamo 1.314 nel 1951, da allora l'emigrazione ha via via ridotto il numero di abitanti, 584 nel 2001 e oggi appena 500», dice Marilena Cabboi, sardista rossomora come Lussu, assessore comunale alla Sanità. Coordinatrice dei tecnici di Radiologia all'ospedale Brotzu di Cagliari, è l'esempio vivente dei tanti che lasciano il paese ma non spezzano le radici. «Nei fine settimane e d'estate, ad agosto - racconta - Armungia si riempie, torna ad avere mille abitanti, perché tornano gli emigrati». -

Bruncos E Cuccuros, Picchi Di Sardegna
Bruncu Arbariu = cima presso Siurgus Donigala Bruncu Arbis = cima presso Musei Bruncu Arbu = cima presso Urzulei Bruncu Arbutza = cima presso Jerzu Bruncu Arbutzu = cima presso Arzana Bruncu Arcaxu = cima presso Serrenti Bruncu Arcu = cima presso Arbus Bruncu Arcu Mannu = cima presso Sinnai 2.124 Bruncu Arcu Sa Porta = cima presso Gairo Bruncu Arcuenta = cima presso Pimentel Bruncu Arenàrgiu = cima presso Usellus Bruncu Arenas = cima presso Villagrande Strisaili Bruncu Arenus = cima presso Talana Bruncu Argidassini = cima presso Villagrande Strisaili Bruncu Argiola = cima presso Villamar Bruncu Abba Vittània = cima presso Tertenia Bruncu Argiola Piu = cima presso Collinas Bruncu Abbrusàdulu = cima presso San Vito Bruncu Argioledda = cima presso Villasalto Bruncu Abes = cima presso Talana Bruncu Arrallas = cima presso Villaputzu Bruncu Abi = cima presso Nuraminis Bruncu Arrascialei = cima presso Seui Bruncu Abiois = cima presso Neoneli Bruncu Arriola = cima presso Villasalto Bruncu Abrutzedu1 = cima presso Meana Sardo 2 Bruncu Arroccu = cima presso San Vito Bruncu Abrutzedu = cima presso Samugheo Bruncu Arruaxu = cima presso Villaverde Bruncu ‘Accu Seda = cima presso Sinnai Bruncu Arrùbia = cima presso Morgongiori Bruncu Àcua Sa Murta1 = cima presso Villaurbana 1 2 Bruncu Arrùbiu = cima presso Monastir Bruncu Àcua Sa Murta = cima presso Villaverde Bruncu Arrùbiu2 = cima presso Serramanna Bruncu Àcua Sàlixi = cima presso Arbus Bruncu Arrùbiu3 = cima presso Sinnai Bruncu Acutzu = cima presso Ussassai Bruncu Arrùbiu4 = cima presso Ussana -

Nuovo Impianto Per La Produzione Di Energia Da Fonte Eolica Nei Comuni
Nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica nei comuni di Ballao e Armungia (SU) Committente: ECONERGY PROJECT 2 S.R.L. via Alessandro Manzoni 30 20121 (MI) C. F. e P. IVA: 10982660960 PEC: [email protected] RELAZIONE RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO Incaricato: Queequeg Renewables, ltd Unit 3.21, 1110 Great West Road Rev. 0.0 Data: 9 novembre 2020 TW80GP London (UK) Company number: 111780524 email: [email protected] VIA-WIND001.REL033 Relazione rischio incedio boschivo Progetto eolico “Bruncu ‘e Niada” WIND001.REL033 2 Relazione rischio incedio boschivo Progetto eolico “Bruncu ‘e Niada” PIANO ANTINCENDIO PER UN IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI BALLAO 1. Premessa ......................................................................................................... 4 2. Descrizione del progetto e dello stato attuale dell’area di intervento .............. 4 3. Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi................................................................................................................ 15 3.1 Il rischio incendio ................................................................................................................................... 15 3.2 Risorse idriche ....................................................................................................................................... 25 4. Prevenzione degli incendi. ............................................................................. 37 WIND001.REL033 3 Relazione rischio incedio -

Comitato * Figc
* COMITATO * F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * SARDEGNA * ************************************************************************ * * * TERZA CATEGORIA CAGLIARI GIRONE: G * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 27/10/13 | | RITORNO: 2/02/14 | | ANDATA: 8/12/13 | | RITORNO: 23/03/14 | | ORE...: 15:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ACQUACADDA NUXIS - DOMUSNOVAS JUNIOR SANTOS | | ACQUACADDA NUXIS - GIOVENTU SPORTIVA SAMASSI | | ATLETICO MASAINAS - ATLETICO BACU ABIS | | ATLETICO BACU ABIS - 1932 VILLACIDRO | | CALCIO SAN SPERATE - NUOVA SANLURESE | | ATLETICO MASAINAS - CALCIO SAN SPERATE | | GIOVENTU SPORTIVA SAMASSI - DECIMOPUTZU | | DOMUSNOVAS JUNIOR SANTOS - NUOVA SANLURESE | | SANTA BARBARA BACU ABIS - VIRTUS S.SPERATE 2002 | | SANTA BARBARA BACU ABIS - ITALPIOMBO SANTA TERESA | | 1932 VILLACIDRO - ITALPIOMBO SANTA TERESA | | VIRTUS S.SPERATE 2002 - DECIMOPUTZU | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 3/11/13 | | RITORNO: 9/02/14 | | ANDATA: 15/12/13 | | RITORNO: 30/03/14 | | ORE...: 15:00 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 8 G I O R N