Il Regionalismo Quarant'anni Dopo: Il Caso Dell'emilia-Romagna (*) SAGGI E ARTICOLI
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Horizontal Mergers with Capital Adjustments: Workers' Cooperatives and the Merger Paradox
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Delbono, Flavio; Lambertini, Luca Working Paper Horizontal Mergers with Capital Adjustments: Workers' Cooperatives and the Merger Paradox Quaderni - Working Paper DSE, No. 962 Provided in Cooperation with: University of Bologna, Department of Economics Suggested Citation: Delbono, Flavio; Lambertini, Luca (2014) : Horizontal Mergers with Capital Adjustments: Workers' Cooperatives and the Merger Paradox, Quaderni - Working Paper DSE, No. 962, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche (DSE), Bologna, http://dx.doi.org/10.6092/unibo/amsacta/4073 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/159801 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, -
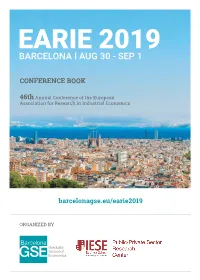
Program Book and List of Participants EARIE
EARIE 2019 BARCELONA I AUG 30 - SEP 1 CONFERENCE BOOK 46th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics barcelonagse.eu/earie2019 ORGANIZED BY PROGRAM OVERVIEW FRIDAY, AUGUST 30 11:15 - 13:00 Registration / Brunch 13:00 - 13:15 Opening and welcome address 13:15 - 14:30 Keynote address I: Kate Ho (Princeton University), "Key Questions in Health Insurance Market Design" 14:45 - 16:15 Parallel sessions I & Invited session I 16:15 - 16:45 Coffee break 16:45 - 18:15 Parallel sessions II & Invited session II 20:00 Welcome reception at the Born Cultural Center SATURDAY, AUGUST 31 09:30 - 11:00 Parallel sessions III & Invited session III 11:00 - 11:30 Coffee break 11:30 - 13:00 Parallel sessions IV 13:00 - 14:30 Lunch 14:30 - 16:00 Parallel sessions V & Invited session IV 16:00 - 16:30 Coffee break 16:30 - 18:00 Plenary panel: “Market Power: Technology and Labor Markets” Jan De Loecker (KU Leuven, moderator) John Sutton (London School of Economics) John Van Reenen (MIT and MIT Sloan School of Management) 18:00 - 18:30 EARIE General Assembly 21:00 Conference buffet dinner at MNAC SUNDAY, SEPTEMBER 1 09:00 - 10:30 Parallel sessions VI & Invited session V 10:30 - 11:00 Coffee break 11:00 - 12:15 Keynote address II: Alessandro Gavazza (LSE) "Industrial Organization and Household Finance” 12:15 - 13:45 Lunch 13:45 - 15:15 Parallel sessions VII & Invited session VI 15:15 - 15:30 Short coffee break 15:30 - 17:00 Parallel sessions VIII 17:00 Conference closure INDEX OF CONTENTS Welcome to EARIE 2019 in Barcelona 01 -

Centro Pedonalizzato: Avanti Piano
L’INFORMAZIONE il Doman Edizione di BOLOGNA MERCOLEDÌ 2 MARZO 2011 ANNO XII NUMERO 60 E 1,20 CULTURA IL BOLOGNA Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA Coop lancia la sfida ai blogger Di Vaio: è fatta per il rinnovo «Raccontateci l’Italia unita» Morandi in festa con la squadra Anche l’edizione 2011 del premio Coop for Words sarà dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia. A Manca solo la firma. L’accordo tra il Bologna e Marco Di Vaio è cosa fatta: due anni questa importante ricorrenza il concorso per scrittori e disegnatori di fumetti dai 15 ai 36 anni dedica da giocatore e due da dirigente. Un modo per poter spalmare l’ingaggio. Ieri intanto infatti una intera sezione: “post it”. È la più giovane, è appena nata ed è indirizzata alle scritture festa a Casteldebole con gli azionisti, capeggiati da Morandi, che si sono co m p l i m e nt at i per blog, però affianca da subito le sezioni decane “poesia”, “racconti brevi”, “f u m etto ”. con la squadra per l’impresa di Torino. ROTINO A PAGINA 23 MERLINI E FRASSINELLA A PAGINA 20 Dopo il nuovo allarme di Boschi sui rischi per le Torri, la politica si interroga sullo stop al traffico SAN LAZZARO Il dibattito sull’edilizia Centro pedonalizzato: avanti piano diventa processo altra sera un di- battito sull’edi- Tutti d’accordo sull’idea ma la strada della “chiusura” è ancora molto lunga L’ lizia si è trasfor- mato in un processo al idea di avere un cen- LE PROPOSTE Comune e alle coop. -

Fifth Annual Meeting of HEPA Europe (Bologna, Italy, 2009)
The WHO Regional 5TH ANNUAL MEETING OF HEPA EUROPE Office for Europe The World Health Organization (WHO) is a specialized agency of the United Nations created in 1948 with the primary responsibility for international health matters and public health. The WHO Regional Office for Europe is one of six regional offices throughout the world, each with its own programme geared to the particular health conditions of the The 5th annual meeting of HEPA Europe, the European network countries it serves. for the promotion of Health-Enhancing Physical Activity (HEPA) Member States was kindly hosted by the Public Health Service, Emilia-Romagna Region, Italy. It was attended by 151 participants from 22 Albania Andorra European countries and from Canada and a representative of the Armenia European Commission. The event was opened with a symposium Austria Azerbaijan on “Perceptions of the urban environment and physical activity”, Belarus followed by meetings of four HEPA Europe working groups. At Belgium Bosnia and Herzegovina the annual meeting, progress made in HEPA Europe’s work Bulgaria programme for the previous year was discussed. Participants Croatia Cyprus discussed and adopted the activity report 2008 / 2009, the work Czech Republic programme 2009/ 2010 and amended Terms of Reference for Denmark HEPA Europe and its Steering Committee. Estonia Finland France In addition, 14 new membership applications and 2 applications Georgia Germany for observer status were confirmed and the Steering Committee Greece was elected, as well as a new chairman. Finally, activities to be Hungary Iceland continued and future projects to be undertaken by HEPA Europe Fifth annual meeting Ireland were discussed including new activities on socially disadvantaged Israel Italy groups and on occupational physical activity. -

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae Vincenzo Denicolò Personal: Born 2 August 1959. Married, two daughters. Addresses: (Home) Via Agnesi 5 40138 Bologna (Bo) Italy Tel.: + 39 051 7165000 (Office) Piazza Scaravilli 2 40125 Bologna (Bo) Italy Tel.: +39 051 2098484 (email) [email protected] Education: Laurea in Economia e Commercio, Università di Bologna Dissertation Title: Dynamic equilibria with exhaustible resources (supervisor prof. Guido Candela) Current positions: Professor of Economics, University of Bologna, Italy Previous positions: Ricercatore (Assistant Professor), University of Bologna, 1983-1988; Associate Professor, University of Bologna, 1988-1990; Professor of Economics, University of Parma, 1990-1993; Visiting Fellow, University of Cambridge, U.K., 1996-97; Visiting Professor, European University Institute, 1998 and 2003; Visiting Professor, University of Paris II, 2006, 2007, 2009, 2010 and 2015; Visiting Scholar, University of Berkeley, 2010; Professor of Economics, University of Leicester, UK 2010-2016 Editorship: Co-Editor, International Journal of Industrial Organization, 2000-2003 Economic Policy panel, 2015-2016 Co-Editor, Journal of Economics Management and Strategy, 2015- Administrative duties: Over the years he has had several administrative duties at the University of Bologna. He was Director of the Undergraduate Program in Economics from 1998 to 1999, Director of the Ph. D. Program in Economics from 1999 to 2002, Head of the Graduate School of Economics and Statistics from 2005 to 2007, and Director of the Bologna Centre for Law and Economics from 2008 to 2010, Research Director at the Department of Economics of the University of Leicester from 2012 to 2015. Currently he is again Director of the PhD program at the University of Bologna. -

Cooperative Firms and the Crisis: Evidence from Some Italian Mixed Oligopolies
Annals of Public and Cooperative Economics 84:4 2013 pp. 383–397 COOPERATIVE FIRMS AND THE CRISIS: EVIDENCE FROM SOME ITALIAN MIXED OLIGOPOLIES by Flavio DELBONO* University of Bologna, Italy and Carlo REGGIANI University of Manchester, UK ABSTRACT: We investigate how cooperative firms reacted to the current crisis. This allows us to compare the behaviour of cooperative and conventional firms facing exogenous shifts in demand. After a short survey of a stream of theoretical literature, we analyze a large group of Italian production cooperatives in the periods 2003–2010 and 1994–2011 and we contrast co-ops behaviour with the overall trend in the in- dustries in which they operate. Our sample’s evidence suggests that the cooperative’s behaviour has a stabilizing effect on employment with respect to shocks in output de- mand. Unlike profit-maximizers, cooperative firms seem to be adjusting pay more than employment when facing shocks. Production co-ops look better equipped than their profit-maximizing counterparts in tackling the long recession also because they have been very cautious in their profit policies over time. Unlike conventional firms, they have significantly increased their own equity during ‘good’ years instead of distributing large dividends to their members. Genossenschaftliche Unternehmen und die Krise: Evidenz von einigen italienischen Oligopolen aus genossenschaftlichen und konventionellen Unternehmen Wir untersuchen, wie genossenschaftliche Unternehmen auf die gegenw¨artige Krise reagiert haben. Dies versetzt uns in die Lage, das -

Vent'anni Di Elezione Diretta Del Sindaco a Bologna
VENT’ANNI DI ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO A BOLOGNA di MARTA REGALIA e MARCO VALBRUZZI Quaderni dell’Osservatorio elettorale n. 76, dicembre 2016, pp. 49-84 Twenty years of direct mayoral election in Bologna Abstract - The article retraces the last 20 years of direct mayoral election in Bologna. It shows how the changes in institutional and electoral settings influenced both the party system and voters’ electoral responses. By analysing the electoral history of the city, we also show that personalization raised, electoral competition became more (bi)polarized, electoral turnout gradually decreased, voting results became less and less predictable at- tenuating Bologna past exceptionalism. This article fills a gap in a literature that has not yet offered a longitudinal study of electoral changes in Bologna since the 1990s. More precisely, the article gives an analysis of both the political supply and the electoral flows to understand how party system has changed and if and how voters have become more mobile. Keywords: Bologna, elections, Mayor, electoral flows, personalization 1. Bologna “normalizzata” Da un punto di vista politico ed elettorale, Bologna non è una città come le altre. Per molti anni è stata considerata come la capitale della “subcultura politica rossa”, e cioè il cuore di quella tradizione elettorale che poneva stabilmente i partiti di sinistra, a cominciare da quello comunista, al centro di un vasto tessuto di relazioni politiche, sociali e professionali (Galli 1968; Ramella 2005). Il ruolo predominante del PCI in città ha condizionato, per almeno un cinquantennio, l’intera politica bolognese, garantendo stabilità governativa, continuità nelle politiche pubbliche e un livello decisamente elevato di prevedibilità elettorale, sia dal lato dei cittadini che da quello dei partiti. -

Cooperative Movement and Prosperity Across Italian Regions
ISSN 2282-6483 Cooperative Movement and Prosperity across Italian Regions Michele Costa Flavio Delbono Francesco Linguiti Quaderni - Working Paper DSE N°1161 Cooperative Movement and Prosperity across Italian Regions Michele Costaa) Flavio Delbonoa) Francesco Linguitib) a) Department of Economics, University of Bologna, P.za Scaravilli 2, 40126, Bologna, Italy ([email protected]; [email protected]) b) Area Studi, Legacoop, Via Guattani 9, 00161 Rome, Italy ([email protected]) Abstract Our main objective is exploring the association between widespread prosperity and the presence of the cooperative movement at the regional level in Italy between 2010 and 2019. We summarize the widespread prosperity through an index originally proposed by Sen (1976) and we then perform a panel regression showing that there is a positive and significant association between such an index and the presence of the cooperative movement as captured by the relative size of cooperative employees. We also detect that the cooperative movement contributes to the regional prosperity more through its employment than in terms of the added value it generates. Moreover, the size of the cooperative presence significantly concurs to explain some large differentials among Italian regions. JEL Codes: I31, J54 Keywords: social cohesion, regional well-being, income inequality, resilience ° We thank Giovanni Angelini, Elena Bontempi, Daniele Brusha, Guido Caselli, Giuseppe Cavaliere, Luca De Angelis, Luca Fanelli, Marco Mira d’Ercole, Sergio Pastorello, Stefano Zamagni, Vera Zamagni and participants in seminars held in (or run from) Bologna (Muec, Vancity, St. Mary University) for comments and suggestions. The usual disclaimer applies. 1 NON-TECHNICAL SUMMARY Starting from the very fuzzy notion of “social cohesion”, we recognize that the “well- being” dimension is needed to establish a multidimensional index of social cohesion. -

Primarie a Bologna Vince Delbono Ma Resta Sotto Il 50 Per Cento
CIFRE DA... mila 688 elettori votarono, mila circa i simpatizzanti Le scorse 21 nel 1999, per le primarie dell’Ulivo 45 bolognesi del Pd che, nel 7 C LUNEDÌ primarie a Bologna. Vinse Silvia Bartolini, poi 2007, hanno votato per il segretario 15 DICEMBRE sconfitta alle amministrative. nazionale e regionale del Pd 2008 p Scelto dagli elettori il candidato sindaco del Pd per il 2009 sotto le Due Torri p Il vicepresidente della Regione ha raccolto il 49,7% delle preferenze Vasco Errani. Sarà Delbono, quindi, il candidato a succedere Sergio Coffe- L’economista Primarie a Bologna rati, che ha rinunciato al secondo che preferisce mandato per stare vicino alla compa- gna Raffaella e al figlio Edoardo, con la concretezza Vince Delbono i quali ieri si è recato al voto. «Quanti sono i partiti che fanno scegliere i pro- alla polemica pri candidati? - chiede rispondendo al cronista che gli chiede come si sen- ma resta sotto ta il Pd - Solo uno, il Pd. Quindi sta Da favoriti non conviene mai bene». Nello stesso seggio del Barac- alzare i toni. Una regola che, per cano ha votato Forlani, il più critico tutta la campagna elettorale, Fla- il 50 per cento verso il comportamento del Pd alle vio Delbono - vincitore delle prima- primarie: «I vertici hanno fatto di tut- rie con un risultato che sfiora il to perché l’informazione fosse diret- 50% dei voti - ha saputo seguire. ta dentro al partito». Dal seggio di via Mantenendo un profilo basso ri- Foto di Stefano Santi/Emblema Paglietta, dove ha appena votato Pro- spetto ai suoi «aggressivi» avversa- di esce una coppia, Carlo e Adriana, ri e puntando molto sulla sua espe- simpatizzanti «di sinistra moderata». -

Introduction: Managing Uncertainty 43 As Their Primary Concern
INTRODUCT I ON : MANAG I NG UNCERTA I NTY Marco Giuliani and Erik Jones The year 2009 was a period of uncertainty, during which the Italian political world appeared to be floundering and in need of a compass. As evidenced by the chronological overview, many events continued to beleaguer the political and social life in Italy. Some, such as the result of the European elections and the escalation of the economic crisis and its repercussions, were foreseen or, in any case, predict- able. Others, including the numerous scandals and irregularities that tarnished the political year, continuously feeding the mass media with distractions and nurturing the public debate with less then edifying themes, were less expected. The government that was formed after the spring 2008 elections should have been able to count on its unprecedented numerical strength in order to rule the country in an equable manner. After all, the coalition supporting Prime Minister Silvio Berlusconi was more compact than the previous fragmented coalition of Romano Prodi and even Berlusconi’s own 2001–2006 coalitions (which included the UDC). Furthermore, the government did not seem to suffer from a decisive loss of popular support, and it was able to contrast itself with an opposition that showed little indication of having a clear and consistent strategy. Nevertheless, for various reasons the year 2009 was characterized by repeated threats of crisis and early elections. The Northern League (LN) raised this possibility before the electoral referendum took place, Notes for this section begin on page 56. 42 Marco Giuliani and Erik Jones and the president of the Senate, Renato Schifani—while proclaim- ing the necessity of having “a united majority or else we will have elections”— repeatedly cautioned against political and personal con- flicts within the government.1 Prime Minister Berlusconi had to reaf- firm what, in abstract, he should have been able to take for granted, namely, that his competence is a legislative one that nothing and no one should be able to hamper, given his political strength. -

Flavio Delbono, Nuovo Sindaco: “Commercio Di Vicinato, È Il Tessuto Sociale Vivo Di Bologna” Roberto Manzoni Eletto Nuovo P
ImpMercurio-02-09 27-07-2009 10:34 Pagina 1 2/09 LUGLIO 8,00 compreso nella quota associativa - Rivista inviata ai soci della Confesercenti di Bologna. € FLAVIO DELBONO, NUOVO SINDACO: “COMMERCIO DI VICINAVICINATO,TO, È IL TESSUTO SOCIALE VIVO DI BOLOGNA” ROBERTO MANZONI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DI CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SCOPERTA DA 100 TOUR OPERATOR PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO SUCCESSIONE, PRATICHE PIÙ FACILI CON CONFESERCENTI L MERCURIO - n. 2, luglio 2009 Spedizione in a.p. 45%, art. 2 comma 20/b Filiale di Bologna Prezzo abbonamento I OPERATIVI I BUONI LAVORO INPS ImpMercurio-02-09 27-07-2009 10:34 Pagina 2 Conto ZeroNet il conto corrente on-line di BPER nalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni fi liale della Banca o sul sito web www.bper.it - maggio 2008 liale della Banca o sul sito web www.bper.it ogni fi Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso nalità promozionali. Messaggio pubblicitario con fi il tuo conto è ovunque gratuito, veloce, semplice www.bper.it ImpMercurio-02-09 ok 28-07-2009 14:46 Pagina 3 IN COPERTINA: SEDI CONFESERCENTI EDITORIALE Torri e campanili nel centro DI BOLOGNA E PROVINCIA di Bologna. Sindaco Delbono, presidente Draghetti: BOLOGNA contate su Confesercenti Bologna, di Sergio Ferrari 5 Direzione provinciale: Via del Commercio Associato 30 tel. 051/6339911 [email protected] BOLOGNA PARLA Bologna - Centro storico: Commercio di vicinato, è il tessuto sociale vivo di Bologna, Via Galliera 87/e di Nicodemo Mele 6 tel. -

L'uomo Dei Conti Affondato Da Una Love Story
PARLANDO Lapresidenza della cnadi Bologna, alla lucedelle dimissionidel sindaco FlavioDelbo- DI... 9 P no, «esprime la massima preoccupazione per la situazione che si trova a vivere la città». Bologna Perché, si legge in una nota dell'associazione artigiana, «una fase di stallo troppo lunga può MARTEDÌ 26 GENNAIO essere di grave danno per Bologna». 2010 Le parole di Cinzia ieri Il consiglio comunale Le accuse dell’ex amante «Umanamente mi dispiace molto, è una sua All’unanimità, chiede l’intervento del ministro degli «Delbono mi ha incontrato più volte. decisione ma forse in questo momento è il Interni perché il governo approvi al più presto Mi ha offerto consulenze del Comune bene della città». il decreto per consentire le elezioni anticipate. un’auto nuova, per il mio silenzio». richiesta nella conferenza stampa griffato e tacchi vertiginosi. sottoti- convocata per le due. E Delbono sce- Su Facebook spunta tolo: le donne al potere. Gli iscritti glie di giocare d’anticipo. Nel suo uf- al gruppo, al momento, sono soltan- ficio sfilano i massimi dirigenti del to 11 (tra loro ci sono almeno un Comune (molti nominati da lui), un gruppo per Cinzia paio di studenti dell'università di quindi i capigruppo di maggioranza Bologna) e sulla bacheca c'è un solo a cui anticipa la svolta. messaggio, per ora, postato dal fon- A meno di tre ore dall’annun- descrive il gruppo è: «nulla di più datore circa un'ora fa: «ipotesi di re- «SOLO UNA LEGGEREZZA» cio delle dimissioni di Delbono sul pericoloso per un nuovo sindaco di ato contestate a delbono: peculato, In aula comunque Delbono porta web è nato il «Cinzia Cracchi fan una ex con il dente avvelenato».