"Banditi a Orgosolo", Di Franco Cagnetta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum in Stile Elegante
CLAUDIO FURCAS DOTTORE RAGIONIERE COMMERCIALISTA Via Petrarca n.2 cap 08040 Girasole tel. 0782.620042 p.iva 01120190911 codice fiscale FRCCLD65C22F979A TITOLI PROFESSIONALI 1998 Abilitazione per Revisore dei conti e iscrizione all’albo nazionale n. registro 80479 2000 Abilitazione per Ragioniere Commercialista 2001 Iscrizione all’albo Unico dei Dottori Commercialisti e esperti contabili N. 22A di Cagliari della Circoscrizione del Tribunale di Lanusei ESPERIENZE PROFESSIONALI 1991-1994 Dott.Prof.Giovanni Sabbagh Cagliari Tirocinio Dottore Commercialista e revisore dei conti 1995-1997 Rag. Mauro Bargellini Cagliari Tirocinio Ragioniere Commercialista 1996-1997 S.I.S.A srl Capoterra Amministratore unico delegato . Coordinamento attività di elaborazione dati . Adempimenti fiscali . Redazione e controllo bilanci d’esercizio società di persone, di capitali ed enti. Contrattualistica commerciale e societaria. Consulenza e adempimenti connessi. studio in via Petrarca n. 2 cap 08040 Girasole (Og) tel./ fax- 0782.620042 e-mail: [email protected] – [email protected] CLAUDIO FURCAS DOTTORE RAGIONIERE COMMERCIALISTA 1997-1998 Comune di Budoni Budoni Responsabile dell’ufficio finanziario con contratto privato 1999-2009 Comune di Budoni Budoni Responsabile dell’ufficio finanziario con contratto pubblico a tempo determinato 2009-oggi Comune di Budoni Budoni Responsabile dell’ufficio finanziario con contratto pubblico a tempo parziale e indeterminato 2001-oggi Studio Professionale Attività professionale di commercialista . Consulenza a Società di capitali per gli adempimenti civili e fiscali; . Consulenza a Società di persone, professionisti e ditte per gli adempimenti civili e fiscali; . Consulenza ad enti pubblici per adempimenti amministrativi e contabili; . Consulenza e predisposizione business plan per pratiche di finanziamento; 2003-2005 Ministero dell’Istruzione Pubblica Revisore dei Conti nelle seguenti Istituzioni Scolastiche: . -

Scuole Elementari Codici
C.S.A. DI NUORO - SCUOLE ELEMENTARI - Codici meccanografici I codici delle Scuole Elementari, esprimibili dal personale della Scuola per i trasferimenti. N.B. : Un unico codice è comprensivo di tutte le scuole appartenenti a quell'Istituto principale. Scuole ordinate per Istituto Principale. Prima le Direzioni Didattiche, seguono gli Istituti Comprensivi. ESPRIMIBILE ESPRIMIBILE DAL DAL PERSONALE TIPOLOGIA FRAZIONE - LOCALITA' - COMUNE DENOMINAZIONE AGGREGATA A: PERSONALE ATA e SCUOLA RIONE DOCENTE DI DOCENTE RUOLO NON DI RUOLO FONNI ELEMENTARE DELEDDA I.C.G. FONNI . NUEE844011 NUIC84400V FONNI ELEMENTARE . I.C.G. FONNI LOGOTZA " " " " SEDE BOSA . D.D. BOSA . NUEE007013 NUEE007002 DIREZIONE MONTRESTA ELEMENTARE . D.D. BOSA . " " " " SEDE DORGALI G.M. GISELLU D.D. DORGALI . NUEE00901P NUEE00900N DIREZIONE DORGALI ELEMENTARE F.LLI CERVI D.D. DORGALI . " " " " DORGALI ELEMENTARE . D.D. DORGALI FRAZ. GONONE " " " " BIRORI ELEMENTARE . D.D. MACOMER . NUEE01801D NUEE01800C SEDE MACOMER . D.D. MACOMER . " " " " DIREZIONE RIONE PADRU E MACOMER ELEMENTARE . D.D. MACOMER " " " " LAMPADAS MACOMER ELEMENTARE . D.D. MACOMER RIONE SANTA MARIA " " " " MACOMER ELEMENTARE . D.D. MACOMER LOC. SERTINU " " " " SEDE F. PODDA - 1° NUORO D.D. NUORO 1 . NUEE019019 NUEE019008 DIREZIONE CIRCOLO NUORO ELEMENTARE SAN PIETRO D.D. NUORO 1 . " " " " SEDE R.CALAMIDA - 3° NUORO D.D. NUORO 3 . NUEE021019 NUEE021008 DIREZIONE CIRCOLO NUORO ELEMENTARE . D.D. NUORO 3 RIONE ITALIA " " " " SEDE NUORO 4° CIRCOLO D.D. NUORO 4 RIONE FURREDDU NUEE03701V NUEE03700T DIREZIONE SEDE NUORO 5° CIRCOLO D.D. NUORO 5 RIONE MONTE GURTEI NUEE04701D NUEE04700C DIREZIONE NUORO ELEMENTARE . D.D. NUORO 5 LOC. BISCOLLAI " " " " SEDE OLIENA . D.D. OLIENA RIONE S. MARIA NUEE02401R NUEE02400Q DIREZIONE OLIENA ELEMENTARE . D.D. OLIENA PREDU MURTA " " " " ONIFAI ELEMENTARE . -
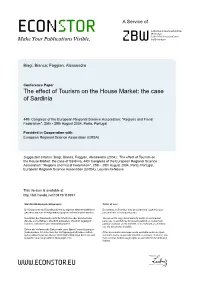
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Comitato Regionale Sardegna Calendari Gare Stagione Sportiva 2015/2016
Comitato Regionale Sardegna Calendari Gare Stagione Sportiva 2015/2016 Campionato Juniores – Prima Fase Delegazione Ogliastra: gironi “D”; ************************************************************************ * * * JUNIORES TORTOLI-OGLIASTRA GIRONE: D * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 10/10/15 | | RITORNO: 12/12/15 | | ANDATA: 14/11/15 | | RITORNO: 23/01/16 | | ORE...: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | | ORE...: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | BARISARDO - TORTOLI CALCIO 1953 | | BARISARDO - GIRASOLE | | BAUNESE - VILLAGRANDE | | CANNONAU JERZU PICCHI - GAIRO | | GAIRO - CARDEDU | | TERTENIA - BAUNESE | | GIRASOLE - SEUI ARCUERI | | TORTOLI CALCIO 1953 - SEUI ARCUERI | | TERTENIA - CANNONAU JERZU PICCHI | | VILLAGRANDE - CARDEDU | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 17/10/15 | | RITORNO: 19/12/15 | | ANDATA: 21/11/15 | | RITORNO: 30/01/16 | | ORE...: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | | ORE...: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 15:30 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | CANNONAU JERZU PICCHI -

B COMMISSION DECISION of 2 May 2005 Approving the Plan
2005D0362 — EN — 12.01.2007 — 001.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COMMISSION DECISION of 2 May 2005 approving the plan for the eradication of African swine fever in feral pigs in Sardinia, Italy (notified under document number C(2005) 1255) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance) (2005/362/EC) (OJ L 118, 5.5.2005, p. 37) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Commission Decision 2007/11/EC of 20 December 2006 L 7 19 12.1.2007 2005D0362 — EN — 12.01.2007 — 001.001 — 2 ▼B COMMISSION DECISION of 2 May 2005 approving the plan for the eradication of African swine fever in feral pigs in Sardinia, Italy (notified under document number C(2005) 1255) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance) (2005/362/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever (1) and in particular Article 16(1) thereof, Whereas: (1) African swine fever is present in feral pigs in the province of Nuoro, Sardinia, Italy. (2) In 2004 a serious recrudescence of the disease has occurred in Sardinia. Italy has in relation with this recrudescence reviewed the measures so far taken to eradicate the disease, in the frame work of Directive 2002/60/EC. -

Tabelle Viciniorità
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PROVINCIA DI: NUORO TABELLA DI VICINIORITA' COMUNE ARITZO 1 BELVI 2 GADONI 3 TONARA 4 DESULO 5 ATZARA 6 MEANA SARDO 7 SORGONO 8 TIANA 9 LACONI 10 SEULO 11 OVODDA 12 TETI 13 AUSTIS 14 VILLANOVATULOO 15 NURALLAO 16 SADALI 17 GENONI 18 NURAGUS 19 ORTUERI 20 FONNI 21 GAVOI 22 LODINE 23 ISILI 24 OLZAI 25 SEUI 26 NURRI 27 OLLOLAI 28 ESTERZILI 29 ORROLI 30 SERRI 31 ESCOLCA 32 MAMOIADA 33 SARULE 34 GERGEI 35 OTTANA 36 ORANI 37 USSASSAI 38 ONIFERI 39 ORGOSOLO 40 ESCALAPLANO 41 NUORO 42 NORAGUGUME 43 OROTELLI 44 BOLOTANA 45 BORORE 46 DUALCHI 47 LEI 48 GAIRO 49 SILANUS 50 MACOMER 51 OSINI 52 BIRORI 53 OLIENA 54 VILLAGRANDE STRISAILI 55 ULASSAI 56 BORTIGALI 57 JERZU 58 PERDASDEFOGU 59 ARZANA 60 LANUSEI 61 CARDEDU 62 ILBONO 63 SINDIA 64 ELINI 65 ORUNE 66 LOCERI 67 TERTENIA 68 SUNI 69 DORGALI 70 GALTELLI 71 BARI SARDO 72 FLUSSIO 73 TINNURA 74 MODOLO 75 BITTI 76 MAGOMADAS 77 LULA 78 ONIFAI 79 SAGAMA 80 BOSA 81 TORTOLI' 82 IRGOLI 83 GIRASOLE 84 LOCULI 85 OROSEI 86 LOTZORAI 87 ONANI 88 SINISCOLA 89 MONTRESTA 90 BAUNEI 91 OSIDDA 92 POSADA 93 TRIEI 94 TORPE' 95 URZULEI 96 TALANA 97 LODE' 98 BUDONI 99 SAN TEODORO SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PROVINCIA DI: NUORO TABELLA DI VICINIORITA' COMUNE ARZANA 1 ELINI 2 ILBONO 3 LANUSEI 4 VILLAGRANDE STRISAILI 5 LOCERI 6 GAIRO 7 OSINI 8 TORTOLI' 9 GIRASOLE 10 BARI SARDO 11 LOTZORAI 12 ULASSAI 13 CARDEDU 14 JERZU 15 BAUNEI 16 USSASSAI 17 TRIEI 18 TERTENIA 19 TALANA 20 PERDASDEFOGU 21 SEUI 22 FONNI 23 URZULEI 24 MAMOIADA 25 SADALI -

La Maddalena La Maddalena
LA MADDALENA LA MADDALENA LA MADDALENA LA MADDALENA LA MADDALENA LA MADDALENA S. TERESA GALLURA LA MADDALENA PALAU TEMPIO PAUSANIA AGLIENTU ARZ ACHENA PORTO TORRES LUOGOSANTO TRINITA' D'AGULTU LURAS S.ANTONIO DI GALLURA GOLFO ARANCI AGGIU S BA DESI OLBIA VALLEDORIA VIDDALBA CALANGIANUS OLBIA TEMPIO PAUSANIA TELTI CASTELSARDO S.MARIA COGHINAS STINTINO BO RT IG IA D A S OLBIA SEDINI TERGU BULZI PERFUGAS LOIRI PORTO S.PAOLO PORTO TORRES SORSO LAERRU SENNORI NULVI MONTI BERCHIDDA MA RTI S OLBIA ERULA S. TEODORO OSILO SASSARI TULA CHIARAMONTI PADRU SASSARI OSCHIRI BUDONI MUROS CARGEGHE PLOAGH E ALA' DEI SARDI TISSI USINI CODRONGIANUS OSSI OLMEDO TORPE ' POSADA ALGHERO URI OZIERI FLORI NA S ARDARA BUDDUSO SILIGO ITTIRI PATTA DA LODE' BANARI PUTIFIGARI MORES BESSUDE BONNANARO BITTI SINISCOLA ITTIREDDU ONANI' BORUTTA NUGHEDU S.NICOLO ' THIESI OSIDDA CHEREMULE TORRALBA ROMANA CHEREMULE BULTEI NULE VILLANOVA MONTELEONE MONTELEONE ROCCA DORIA LULA IRGOLI COSSOINE GIAVE ANELA COSSOINE MA RA ONIFAI BONORVA BENETUTTI LOCULI ORUNE BON O OROSEI PADRIA BURGOS MACOMER MONTRESTA BOTTI DA GALT ELLI' ESPORLATU SEMESTENE POZZOMAGGIORE ILLORAI NUORO BOSA BOLOTA N A OROTELLI LEI SUN I BORTIGALI ONIFERI DORGALI OLIENA SILANUS MODOLO SINDIA MACOMER TINNURA MAGOMADAS SAGA M A FLUSSI O BIRORI ORANI DUALCHI TRESNURAGHES NORAGUGUME OTTA NA SCANO DI MONTIFERRO SARULE SENNARIOLO BORORE MAMOIADA AI D OM AG GI OR E SE D IL O OLLOLAI NUORO ORGOSOLO OLZAI GAVOI SANTU LUSSURGIU CUGLIERI NORBELLO SORRADI LE LODINE ABBASANTA SO D D I' GHILARZ A BIDONI' URZULEI TETI BORONEDDU -

SEZIONE "B" STRUTTURE RESIDENZIALI a CARATTERE COMUNITARIO (Art
PROVINCIA DI NUORO Settore Affari Istituzionali e Programmazione - Allegato alla Determinazione "Approvazione registro soggetti autorizzati esercizio attività - D.P.G.R. n. 4/2008" - 1° Sem. 2018 REGISTRO SOGGETTI AUTORIZZATI ESERCIZIO ATTIVITA' D.P.G.R. 22/07/2008 n° 4 PERIODO: 1° SEMESTRE 2019 SEZIONE "B" STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE COMUNITARIO (art. 7 e seg.) a) comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino. b) residenze comunitarie diffuse per anziani. c) comunità residenziali per persone con disabilità e per il "Dopo di Noi". d) comunità di accoglienza per minori. e) comunità alloggio per anziani. f) comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Recapiti Capacità N. COMUNE CODICE tipologia Denominazione Sede Indirizzo Indirizzo email Proprietà struttura Soggetto Gestore Estremi autorizzazioni al funzionamento Telefonici ricettiva 15 piano Comunità Alloggio per anziani - terra, 15 Villa delle Ginestre -Verde piano Via Antonio Maxia, 0784-629201 1 ARITZO e- comunità alloggio per anziani Aritzo [email protected] piano 2° e 6 Privato Privato Autorizzazione SUAP del Comune di Aritzo Prot. N. 4168 del 17.09.2013 primo - Azzurra piano secondo - 76 - 08031 Aritzo 0784-629124 piano 3° Pronto Intervento piano terzo. Tot.36 Via Guglielmo 0784 629716 Vela Blu -coop Onlus- Via 2 ARITZO Vela Blu Aritzo [email protected] [email protected] 14 Duaap 133/2016 del Comune di Aritzo Marconi snc 070 7567062 Dexart 18 09126 – Cagliari Comune Aritzo ex d -comunità accoglienza minori Ipab 3 BARI SARDO e- comunità alloggio per anziani Il Cantuccio Bari Sardo Via Mare 1 0782450678 16 3881679112 Atto del responsabile servizi sociali Unione Comuni d'Ogliastra prot. -

Ogliastra. I Camping & Bungalow
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA Assessorato al Turismo Ogliastra.Ogliastra I Camping & Bungalow. [ Barisardo ] Urzulei Talana Triei Baunei CAMPING Villagrande S. Maria Navarrese Strisaili Lotzorai MARINA Girasole Arbatax Via della Pineta 29 Arzana Elini Tortolì Ilbono località Torre di Barì Lanusei Tel 0782 29969 Seui Gairo Loceri Osini Barisardo Fax 0782 29969 Ulassai Cardedu Jerzu www.campingmarina.it [email protected] GPS: 39°Tertenia 50’ 03.10’’ N 9° 40’ 45.21’’E Perdasdefogu Nella costa meridionale della nuova provincia d’Ogliastra, a partire dalla Torre Saracena di Bari Sardo, si stende uno dei più bei litorali della Sardegna orientale. Qui sorge il Camping Marina, totalmente alberato da eucalyptus ed olmi, che si affaccia diretta- mente su una immensa spiaggia incontaminata e su un’ombrosa pineta. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web. Along the southern coast of the new province of Ogliastra, starting from the Saracen Tower at Bari Sardo, lies one of the most beautiful stretches of coastline to be found in eastern Sardinia. Here you will find Marina campsite, lined by eucalyptus and elm trees, directly overlooking a vast expanse of unspoilt beach and a shady pine forest. For more information, visit our web site. Sur la côte sud de la nouvelle province de l’Ogliastra, à partir de la Tour sarrasine de Bari Sardo, s’étend l’un des plus beaux littoraux du sud de la Sardaigne. C’est là que se trouve le Camping Marina, à l’ombre des eucalyptus et des ormes, de plein pied sur une immense plage sauvage et sur une fraiche pinède. -

Dup 2019 / 2021
[UNIONE COMUNI NORD OGLIASTRA] D.U.P. 2019 / 2021 La nuova programmazione di Bilancio Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta una delle innovazioni più importanti della nuova programmazione degli enti locali. Con il DUP l’Ente affronterà in maniera strategica la programmazione economico- finanziaria del triennio successivo. INTRODUZIONE L’unione Comuni Nord Ogliastra è stata costituita il 20/05/2010 con la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da parte dei Sindaci di otto Comuni facenti parte della zona Nord Ogliastra: Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzuei, VillagrandeStrisaili. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono e vi hanno aderito: Delibere di Consiglio Comunale con all'oggetto: "Adesione e Approvazione Atto Costitutivo e Statuto " n. 35 DEL 19/12/2008……………………………….. COMUNE DI GIRASOLE n. 1 DEL 14/01/2009………………………………… COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI n. 2 DEL 06/02/2009………………………………… COMUNE TORTOLI n. 6 DEL 17/02/2009………………………………… COMUNE DI TALANA n. 5 DEL 26/02/2009………………………………… COMUNE DI TRIEI n. 16 DEL 27/05/2009………………………………… COMUNE DI URZULEI n. 39 DEL 28/09/2009………………………………… COMUNE DI BAUNEI n. 5 DEL 22/03/2010………………………………… COMUNE DI LOTZORAI Lo Statuto determina le norme fondamentali dell’organizzazione e dell’attività dell’Unione che è chiamata a svolgere una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. L'Unione ha il compito fondamentale di promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i Comuni aderenti e garantire un coordinamento delle politiche di programma e sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. -

PROV. ELENCO COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA LUOGO DI RESIDENZA INDIRIZZO RESIDENZA CODICE FISCALE Data Iscrizione N
PROV. ELENCO COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA LUOGO DI RESIDENZA INDIRIZZO RESIDENZA CODICE FISCALE Data iscrizione N. ISCRIZIONE RESIDENZA SPECIALE 1 ABELTINO ANDREA CAGLIARI 16/12/1967 CAGLIARI VIA DELL'ABBAZIA 33 CA BLTNDR67T16B354G 17/06/2004 603 2 ACCA ALESSANDRO CARBONIA 09/08/1978 NUXIS VIA S'ACQUACALLENTI 9 CI CCALSN78M09B745N 25/07/2007 681 3 AGUS VITTORIO CAGLIARI 10/06/1958 MONSERRATO VIA CASSIODORO, 9/int. 6 CA GSAVTR58H10B354S 05/04/2006 92 ES 4 AIME MANLIO CAGLIARI 30/05/1965 CAGLIARI VIA MANZONI, 7 CA MAIMNL65E30B354F 31/03/1994 259 5 ALTEA LUIGI SASSARI 19/09/1953 ALGHERO Via Banyoles 15 SS LTALGU53P19I452I 10/05/1983 60 6 ANARDU VENERIO GIUSEPPE BAUNEI 05/11/1972 SETTIMO SAN PIETRO VIA FILIPPO TURATI, 3 CA NRDVRG72S05A722R 08/09/2003 574 7 ANDRISSI GIOVANNI STEFANO MILANO 13/06/1963 CAGLIARI VIA CONTE BIANCAMANO, 19 CA NDRGNN63H13F205G 16/06/1993 248 8 ANEDDA MARIA GRAZIA CAGLIARI 21/05/1965 GERGEI VIA G. MARCONI 5 CA NDDMGR65E61B354B 24/04/1998 385 9 ANGIUS ANTONELLO CAGLIARI 07/06/1961 CAGLIARI VIA ITALIA 143 CA NGSNNL61H07B354Y 10/06/1990 144 10 ANGIUS GISELLA ILBONO 23/01/1966 TORTOLI' VIA DEL PESCATORE .S.N OG NGSGLL66A63E283O 21/03/1995 299 11 ANGOTZI SALVATORE ENRICO CUGLIERI 20/04/1961 CUGLIERI VIA GARIBALDI 16 OR NGTSVT61D20D200S 23/09/1996 347 12 ANOLFO ALESSANDRO IGLESIAS 23/07/1979 IGLESIAS VIA ADA NEGRI 16 CI NLFLSN79L23E281G 29/10/2010 3 13 ANTONICELLI STEFANO CAGLIARI 06/06/1967 QUARTU SANT'ELENA VIA ROSAS 12 CA NTNSFN67H06B354X 05/04/2006 651 14 ANTONINI MARIO ALBERTO ADDIS ABEBA 27/09/1969 SASSARI VIA AMENDOLA 51 SS NTNMLB69P27Z315M 26/03/2004 745 15 ARDAU CARLA CAGLIARI 06/07/1967 CAGLIARI VIA DEI COLOMBI 1 CA RDACRL67L46B354W 05/03/2008 687 16 ARESU ALBERTO CAGLIARI 25/02/1964 QUARTU SANT'ELENA VIA A. -
![Deliberazione 7/49 Del 12 Febbraio 2019 [File.Pdf]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9951/deliberazione-7-49-del-12-febbraio-2019-file-pdf-6029951.webp)
Deliberazione 7/49 Del 12 Febbraio 2019 [File.Pdf]
DELIBERAZIONE N. 7/49 DEL 12.02.2019 ————— Oggetto: Classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon - Azione P-8.2.4 del Programma P-8.2 del Piano Regionale di Prevenzione. L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama preliminarmente, che nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (approvato con l'Intesa Stato/Regioni Rep. n. 156/CSR del 13.11.2014, recepita dalla Giunta regionale con Delib.G.R. n. 53/28 del 29.12.2014) figura, nell'ambito del Macro Obiettivo 8, relativo alla riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, l'Obiettivo Centrale “Promuovere le buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon”, il cui Indicatore Centrale è “Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile”. Precisa l'Assessore che, nel Documento di valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione, facente parte integrante dell'Accordo Stato/Regioni n. 56/CSR sancito in data 25.5.2015, è stabilita al riguardo, l'adozione di indirizzi specifici in ogni Regione. L'Assessore rammenta che, in ottemperanza al predetto Piano Nazionale della Prevenzione, nel Programma P-8.2 (recante “Supporto alle Politiche Ambientali”) del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015 e rimodulato e prorogato al 31.12.2019 con Delib.G.R. n. 33/9 del 26. 6.2018, è stata inserita l'Azione P-8.2.4 “Promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ ristrutturazione di edifici per il miglioramento della qualità dell'aria indoor”.