Arte a Servizio Dell'incontro Con Gesù Cristo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rome: a Pilgrim’S Guide to the Eternal City James L
Rome: A Pilgrim’s Guide to the Eternal City James L. Papandrea, Ph.D. Checklist of Things to See at the Sites Capitoline Museums Building 1 Pieces of the Colossal Statue of Constantine Statue of Mars Bronze She-wolf with Twins Romulus and Remus Bernini’s Head of Medusa Statue of the Emperor Commodus dressed as Hercules Marcus Aurelius Equestrian Statue Statue of Hercules Foundation of the Temple of Jupiter Optimus Maximus In the Tunnel Grave Markers, Some with Christian Symbols Tabularium Balconies with View of the Forum Building 2 Hall of the Philosophers Hall of the Emperors National Museum @ Baths of Diocletian (Therme) Early Roman Empire Wall Paintings Roman Mosaic Floors Statue of Augustus as Pontifex Maximus (main floor atrium) Ancient Coins and Jewelry (in the basement) Vatican Museums Christian Sarcophagi (Early Christian Room) Painting of the Battle at the Milvian Bridge (Constantine Room) Painting of Pope Leo meeting Attila the Hun (Raphael Rooms) Raphael’s School of Athens (Raphael Rooms) The painting Fire in the Borgo, showing old St. Peter’s (Fire Room) Sistine Chapel San Clemente In the Current Church Seams in the schola cantorum Where it was Cut to Fit the Smaller Basilica The Bishop’s Chair is Made from the Tomb Marker of a Martyr Apse Mosaic with “Tree of Life” Cross In the Scavi Fourth Century Basilica with Ninth/Tenth Century Frescos Mithraeum Alleyway between Warehouse and Public Building/Roman House Santa Croce in Gerusalemme Find the Original Fourth Century Columns (look for the seams in the bases) Altar Tomb: St. Caesarius of Arles, Presider at the Council of Orange, 529 Titulus Crucis Brick, Found in 1492 In the St. -

Pestilence and Prayer: Saints and the Art of The
PESTILENCE AND PRAYER: SAINTS AND THE ART OF THE PLAGUE IN ITALY FROM 1370 - 1600 by JESSICA MARIE ORTEGA A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Honors in the Major Program in Art History in the College of Arts and Humanities and in The Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, Florida Fall Term 2012 Thesis Chair: Dr. Margaret Zaho ABSTRACT Stemming from a lack of scholarship on minor plague saints, this study focuses on the saints that were invoked against the plague but did not receive the honorary title of plague patron. Patron saints are believed to transcend geographic limitations and are charged as the sole reliever of a human aliment or worry. Modern scholarship focuses on St. Sebastian and St. Roch, the two universal plague saints, but neglects other important saints invoked during the late Medieval and early Renaissance periods. After analyzing the reasons why St. Sebastian and St. Roch became the primary plague saints I noticed that other “minor” saints fell directly in line with the particular plague associations of either Sebastian or Roch. I categorized these saints as “second-tier” saints. This categorization, however, did not cover all the saints that periodically reoccurred in plague-themed artwork, I grouped them into one more category: the “third-tier” plague saints. This tier encompasses the saints that were invoked against the plague but do not have a direct association to the arrow and healing patterns seen in Sts. Sebastian and Roch iconographies. This thesis is highly interdisciplinary; literature, art, and history accounts were all used to determine plague saint status and grouping, but art was my foundation. -

Best Tours in Rome"
"Best Tours in Rome" Created by: Cityseeker 9 Locations Bookmarked Colosseum "Symbol of Rome" The magnanimous proportions of the Colosseum have long been a source of wonder. Originally envisioned in 70 CE, the construction of this grand structure was completed in 80 CE. At that time, it is believed that this vast amphitheater could seat upwards of 50,000 spectators at once. The Colosseum also features on the Italian version of the five-cent Euro. by TreptowerAlex Deemed as one of the Seven Wonders of the World, the Colosseum was designed to be a horse racing circuit and arena for animal fighting and gladiatorial battles, although it has also hosted significant religious ceremonies in its early days. It is a symmetrical wonder set in the historic landscape of Rome's heart. The enormous ruin is a UNESCO World Heritage Site and is considered by many to be an iconic symbol of Italy. +39 06 699841 parcocolosseo.it/area/colosseo/ Piazza del Colosseo 1, Rome Basilica di San Clemente al Laterano "Basilica on Three Levels" A visit to Basilica di San Clemente al Laterano is a fascinating journey through time. From the upper basilica, which dates from the beginning of the 12th Century and whose apse boasts the mosaic The Triumph of the Cross, one passes into the 4th-century lower basilica, and, via a stairway, by Nicholas Hartmann down to the Roman constructions and the mitreo, a 3rd-century temple dedicated to the God Mithra. Of particular interest are the frescoes in the chapel of St Catherine, painted between 1428 and 1431 by Masolino da Panicale, possibly with the collaboration of Masaccio. -

St Benedict's Parish, Narrabundah
16 DAYS ST BENEDICT’S PARISH, NARRABUNDAH COMMENCES MON 14TH SEPT 2020 • 16 DAYS / 12 NIGHTS Rome (3 Nights) • Vicocaro • Subiaco • Montecassino (2) • Pompeii • Cava Di Tireni • Pietrelcina • Monte Sant’Angelo • San Giovanni Rotondo (2) • Norcia • Assisi (2) • Ravenna • Padua (3) • Venice Accompanied by FR DANIEL BENEDETTI MGL PP St Peter’s Square, Rome SYMBOLS informative exploration. Our guided tour will soon found his rule so unpleasantly strict that (B) = Breakfast (L) = Lunch (D) = Dinner feature among other highlights Michelangelo’s they tried to poison him. Benedict returned to = Time Out - Planned site for extended stunning Pieta, the tomb of Pope St John Paul II, his cave, but by then had attracted so many opportunity for prayer & reflection the great Confessional and the Crypt containing followers that he could no longer pursue the the tombs of several Popes. solitary life. DAY 1: MONDAY 14TH SEPTEMBER – DEPART Journey this afternoon out to the majestic We journey south this afternoon to Cassino AUSTRALIA Basilica of St Paul Outside the Walls. and wind our way up the mountain, DAY 2: TUESDAY 15TH SEPTEMBER - ARRIVE Originally consecrated in 324, the saint’s tomb enjoying the view of the spectacular Abbey ROME is visible now under the Papal Altar. We will of Montecassino, founded in 529 by St Benedict, patron saint of Europe and the Welcome to Rome. Join with pilgrims this spend some time here as a special tribute to founder of Western Monasticism. The Abbey evening for a Welcome Dinner. the Church’s greatest evangelist. was carefully rebuilt after the epic battle of Rome overnight (D) Continue then to the ancient Catacombs for a memorable guided tour to marvel at these 1944 and still dominates the surrounding DAY 3: WEDNESDAY 16TH SEPTEMBER – underground burial tunnels for Christians and countryside from its mountaintop setting. -

3 Architects, Antiquarians, and the Rise of the Image in Renaissance Guidebooks to Ancient Rome
Anna Bortolozzi 3 Architects, Antiquarians, and the Rise of the Image in Renaissance Guidebooks to Ancient Rome Rome fut tout le monde, & tout le monde est Rome1 Drawing in the past, drawing in the present: Two attitudes towards the study of Roman antiquity In the early 1530s, the Sienese architect Baldassare Peruzzi drew a section along the principal axis of the Pantheon on a sheet now preserved in the municipal library in Ferrara (Fig. 3.1).2 In the sixteenth century, the Pantheon was generally considered the most notable example of ancient architecture in Rome, and the drawing is among the finest of Peruzzi’s surviving architectural drawings after the antique. The section is shown in orthogonal projection, complemented by detailed mea- surements in Florentine braccia, subdivided into minuti, and by a number of expla- natory notes on the construction elements and building materials. By choosing this particular drawing convention, Peruzzi avoided the use of foreshortening and per- spective, allowing measurements to be taken from the drawing. Though no scale is indicated, the representation of the building and its main elements are perfectly to scale. Peruzzi’s analytical representation of the Pantheon served as the model for several later authors – Serlio’s illustrations of the section of the portico (Fig. 3.2)3 and the roof girders (Fig. 3.3) in his Il Terzo Libro (1540) were very probably derived from the Ferrara drawing.4 In an article from 1966, Howard Burns analysed Peruzzi’s drawing in detail, and suggested that the architect and antiquarian Pirro Ligorio took the sheet to Ferrara in 1569. -

Sacred Image, Civic Spectacle, and Ritual Space: Tivoli’S Inchinata Procession and Icons in Urban Liturgical Theater in Late Medieval Italy
SACRED IMAGE, CIVIC SPECTACLE, AND RITUAL SPACE: TIVOLI’S INCHINATA PROCESSION AND ICONS IN URBAN LITURGICAL THEATER IN LATE MEDIEVAL ITALY by Rebekah Perry BA, Brigham Young University, 1996 MA, University of Massachusetts Amherst, 2006 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts & Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2011 UNIVERSITY OF PITTSBURGH Kenneth P. Dietrich School of Arts & Sciences This dissertation was presented by Rebekah Perry It was defended on October 28, 2011 and approved by Franklin Toker, Professor, History of Art and Architecture Anne Weis, Professor, History of Art and Architecture Bruce Venarde, Professor, History Alison Stones, Professor, History of Art and Architecture ii Copyright © by Rebekah Perry 2011 iii SACRED IMAGE, CIVIC SPECTACLE, AND RITUAL SPACE: TIVOLI’S INCHINATA PROCESSION AND ICONS IN URBAN LITURGICAL THEATER IN LATE MEDIEVAL ITALY Rebekah Perry, PhD University of Pittsburgh, 2011 This dissertation examines the socio-politics of urban performance and ceremonial imagery in the nascent independent communes of late medieval Lazio. It explores the complex manner in which these central Italian cities both emulated and rejected the political and cultural hegemony of Rome through the ideological and performative reinvention of its cult icons. In the twelfth century the powerful urban center of Tivoli adopted Rome’s grandest annual public event, the nocturnal Assumption procession of August 14-15, and transformed it into a potent civic expression that incorporated all sectors of the social fabric. Tivoli’s cult of the Trittico del Salvatore and the Inchinata procession in which the icon of the enthroned Christ was carried at the feast of the Assumption and made to perform in symbolic liturgical ceremonies were both modeled on Roman, papal exemplars. -

2016 Le Icone Romane
J2e icone romane Con il Calendario 2016 il 3ondo [difici di Culto vuole valorillare una parte poco conosciuta del proprio patrimonio artistico: re icone romane. Delle icone medioevali dipinte o realillate a mosaico su tavola, custodite nelle Chiese di Roma e del C.a.2io, il 3ondo [difici di Culto è proprietario di una parte consistente. tra le più venerate e famose per la concessione di speciali gra.2ie,databili tra il V1 e il X1V secolo. Il termine "icona" deriva dal greco-bi.cantino e significa "immagine". ma la sua radice rimanda alla forma verbale "sembrare". "essere simile" e per questo, in senso cristiano. identifi('ò la "raffigura.2ione di un personaggio sacro" per eccelle11.2a: Cristo, la Sua Santa Madre, gli f\postoli e i Santi o episodi della Coro vita inseriti in un contesto liturgico o devozionale. Intesa esse11.2ialmente come pannello ligneo dipinto. la parola icona entrerà nel linguaggio storico-artistico moderno con l'accezione di pitturasacra su tavola di origine. tradi.cioneo ispira.2ione greco-bi.cantina. Roma custodisce alcune delle icone più antiche finora conosciute. al pari del Monastero di Santa Caterina d'Alessandria sul Sinai. 11 gruppo romano. però, non va contrapposto alle più antiche icone di 6isa11.2io ma neanche considerato una loro filia.2ione in quanto pone problemi interpretativi differenti e si inserisce, con una propria peculiarità. nel contesto della for mula.2ione artistica dell'Impero bi.cantino, trovando a volte paragoni e confronti anche con aree eterodosse a Costantinopoli e a volte imponendosi per specificità di stile e di significato. -

Denominazione Codice Discrizione Scopo Sedeente OPERA
Denominazione Codice DIscrizione Scopo SedeEnte OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI 1 15/01/1940 EDUCAZIONE FIGLI DEGLI AVIATORI (ORFANI) ROMA - VIALE DELL'UNIVERSITA' N°4 FONDAZIONE DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA' - ONLUS 1 21/01/1995 ASSISTENZA SOCIALE ROMA - VIA NAZIONALE N°91 FONDAZIONE TERZO PILASTRO - ITALIA E MEDITERRANEO (scissa in: Fondazione terzo pilastro Internazionale iscritta CULTURALE PER PROMUOVERE SOSTENERE E 1 04/01/1996 ROMA - VIA MARCO MINGHETTI N°17 al n.1275/2018 e nella Fondazione Cultura ed Arte iscritta DIFFONDERE L'IDEA DI IMPRESA SOCIALE ECC. al n.1276/2018) CASSA UFFICIALI 1 07/01/1998 SOVVENZIONE PENSIONI INTEGRATIVE ROMA - VIA MARSALA N°104 PARROCCHIA S. ENRICO 1 13/01/1999 RELIGIONE E CULTO ROMA - VIALE RATTO DELLE SABINE N°7 CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN 1 10/01/2000 RELIGIONE E CULTO ROMA - VIA GABRIELE ROSSETTI N°17 MAESTRO FINALITA' EDUCAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE ROMA - CIRCONVALLAZIONE CLODIA MISSIONE EDUCATIVA CONDIVISA (M.E.C.) 1 19/04/2001 BAMBINI RAGAZZI ADULTI SENZA N°163/171 INT.2 DISCRIMINAZIONI FONDAZIONE EDOARDO AGNELLI 2 15/01/1940 BORSE DI STUDIO A FIGLI DI AVIATORI ROMA - VIALE UNIVERSITA' N. 4 FONDAZIONE "ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE" PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA ECONOMICA PROMUOVERE E DIFFONDERE LA CULTURA 2 23/01/1995 ROMA - VIA NERVA N.1 (trasformata in S.r.l.) (CANCELLATA IN DATA 4 GIUGNO ECONOMICA 2019) FONDO NAZIONALE DI GARANZIA 2 05/01/1996 TUTELA AGENTI DI CAMBIO ROMA - VIA GIACOMO PUCCINI, N°9 PROMUOVERE E FAVORIRE LA RICERCA TECNICO- SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL'UROLOGIA LO SOCIETA' ITALIANA DI UROLOGIA 2 16/01/1998 ROMA - VIA GIOVANNI AMENDOLA N°46 SVILUPPO ED IL CORRETTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE UROLOGICA FONDAZIONE LEONE CAETANI 2 15/01/1999 CONOSCENZA DEL MONDO MUSULMANO ROMA - VIA DELLA LUNGARA N.10 LOGOS INC. -

SOMMARIO L. Le Storie Di San Pietro E San Paolo Nell'oratorio Di Giovanni VII in San Pietro in Vaticano, K. Quezjo 2. Il Perduto
SOMMARIO INTRODUZIONE 13 ScHEDE l. Le Storie di san Pietro e san Paolo nell'oratorio di Giovanni VII in San Pietro in Vaticano, K. Quezjo 51 2. Il perduto medaglione Paparoni nel pavimento di Santa Maria Maggiore, K. Queijo 54 3. Gli affreschi staccati dall'abside di San Basilio ai Pantani. L'Ascensione, I. Quadri e K. Queijo 56 4. L'affresco con la Vergine, il Bambino e santi in San Bartolomeo all'Isola, I. Quadri 59 5. Il mosaico absidale di San Pietro in Vaticano, K. Queijo 62 6. La Leggenda di Ansedonia sull'Arco di Carlomagno all'abbazia delle T re Fontane, I. Quadri 67 7. Il mosaico con la Virgo lactam e le vergini sagge e folli sulla facciata di Santa Maria in T rastevere, K. Queijo 72 7a. Prima fase: gruppo centrale e vergini S2, Sl, D l e D2 73 7b. Seconda fase: vergini D3 e D4 75 8. Il mosaico absidale di San Paolo fuori le mura, K. Queijo 77 9. L'icona musiva con la Vergine e il Bambino in San Paolo fuori le Mura, K. Queijo 88 10. Il mosaico dell'ingresso monumentale di San Tommaso in Formis, K. Quezjo 90 11. Il fregio a mosaico sull'architrave del portico di San Lorenzo fuori le mura, K. Quezjo 92 12. La decorazione a finti mattoni nel portico di San Lorenzo fuori le mura, K. Quezjo 94 13. La perduta Croa/issione con Onorio III e Iacobus penitentiarius al Laterano (?), K. Queijo 95 14. Il volto duecentesco dell'icona di Santa Maria Nova, K. -

Catechesi Con Arte Nelle Chiese Di Roma, Roma, Di Chiese Nelle Arte Con Catechesi Di Itinerari Nostri Nei
Programma Divina Rivelazione Divina Missionarie della della Missionarie 2018-2019 a cura delle cura a CATECHESI CON ARTE CON CATECHESI Imparare Roma: la Bellezza tra Cielo e terra. terra. e Cielo tra Bellezza la Roma: Imparare Carissimi amici, MISSIONARIE DELLA DIVINA RIVELAZIONE nei nostri itinerari di Catechesi con Arte nelle chiese di Roma, Via delle Vigne Nuove, 459 - 00139 Roma vogliamo sentirci pellegrini nella vita di ogni giorno; il pellegrino ha la certezza che la morte non è un muro da abbattere, ma la porta che Tel/Fax 06 87130963 si apre sull’Eternità. I luoghi sacri ci ricordano che in Cristo cielo e terra non sono separati, ma che tutti i credenti in Lui formano un solo Per sostenere la nostra missione: corpo e il bene degli uni è comunicato agli altri. “Noi crediamo alla Banca Prossima comunione di tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini su IT59K0335901600100000103420 questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che in questa comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi santi [email protected] ascolta costantemente le nostre preghiere” [Beato Paolo VI, Credo del www.divinarivelazione.org popolo di Dio, 30]. Dio ci benedica E la Vergine ci protegga Guide ufficiali della Basilica di San Pietro e dei Musei Vaticani per Le Missionarie della Divina Rivelazione itinerari di Arte e Fede IT59K0335901600100000103420 missione: Banca Prossima Prossima Banca missione: Per sostenere la nostra nostra la sostenere -
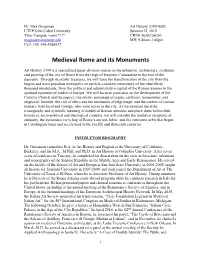
Medieval Rome and Its Monuments
Dr. Max Grossman Art History 3399/4383 UTEP/John Cabot University Summer II, 2019 Tiber Campus, room ???? CRN# 36302/36303 [email protected] MW 9:00am-1:00pm Cell: (39) 340-4586937 Medieval Rome and its Monuments Art History 3399 is a specialized upper-division course on the urbanism, architecture, sculpture and painting of the city of Rome from the reign of Emperor Constantine to the end of the duecento. Through its artistic treasures, we will trace the transformation of the city from the largest and most populous metropolis on earth to a modest community of less than thirty thousand inhabitants, from the political and administrative capital of the Roman Empire to the spiritual epicenter of medieval Europe. We will focus in particular on the development of the Catholic Church and the papacy; the artistic patronage of popes, cardinals, monasteries, and seignorial families; the cult of relics and the institution of pilgrimage; and the careers of various masters, both local and foreign, who were active in the city. As we examine the style, iconography and symbolic meaning of medieval Roman artworks and place them within their historical, socio-political and theological contexts, we will consider the medieval reception of antiquity, the systematic recycling of Rome’s ancient fabric, and the renovatio urbis that began in Carolingian times and accelerated in the twelfth and thirteenth centuries. INSTRUCTOR BIOGRAPHY Dr. Grossman earned his B.A. in Art History and English at the University of California- Berkeley, and his M.A., M.Phil. and Ph.D. in Art History at Columbia University. After seven years of residence in Tuscany, he completed his dissertation on the civic architecture, urbanism and iconography of the Sienese Republic in the Middle Ages and Early Renaissance. -

Favorite Places in Rome Provided by Marie Lorenz, December 2017
Favorite Places in Rome provided by Marie Lorenz, December 2017 Marie lived in Rome during her third year at the Rhode Island School of Design. She returned for a second year as a Fellow at the American Academy in Rome. http://www.aarome.org/ She mapped out each of the spots listed below here. 1) THE TRASTEVERE CHURCHES These churches are only a 15 minute walk from Campo de Fiori and a bit off the tourist path, so they present a rare opportunity to sit quietly with some of the most beautiful artwork in Rome, for free! San Francesco a Ripa Piazza di S. Francesco d'Assisi, 88, 00153 Roma This early Franciscan convent holds Bernini’s masterpiece, Beata Ludovica Albertoni. "The sculpture and surrounding chapel honors a Roman noble woman who entered the Order of St. Francis following the death of her husband. The day before her own death from fever, Ludovica received the eucharist and then ordered everyone out of her room. When her servants were finally recalled, “they found her face aflame, but so cheerful that she seemed to have returned from Paradise.” (paraphrased from wikipedia) By representing this decisive moment, and like many of his other sculptures, Bernini seems to mingle the idea of physical ecstasy and religious martyrdom. In its day, this sculpture would have scandalized the recently reformed protestant church which considered any representation of a divine figure blasphemous. Bernini finished the sculpture in 1674 when he was seventy one years old. Santa Cecilia in Trastevere Piazza di Santa Cecilia, 22, 00153 Roma 5th-century church devoted to the Roman martyr Saint Cecilia.