SINTESI NON TECNICA Rev
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verbale N. 3 08.06.2020
Regione Siciliana Libero Consorzio Comunale di Trapani Città di Castelvetrano Selinunte VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunali di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi). CIG: 828703559E VERBALE N. 3 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2562543 SUL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA L’anno Duemilaventi il giorno Otto del mese di Giugno alle ore 9:15 in Castelvetrano, presso gli Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”, siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, il Responsabile Unico del Procedimento assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 96 del 26.05.2020, così composta: R.U.P. – Geom. Giuseppe Aggiato; Dott. Vincenzo Caime, testimone; Sig.ra Dorotea Santospirito, testimone; Sig.ra Anna Rubino, verbalizzante Premesso che: - con verbale n. 2 del 28.05.2020, a seguito della verifica di documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate dalle ditte interessate alla procedura in epigrafe, risultava che la ditta “Delfino Edmondo”, con sede in Porto Empedocle (AG), via Marsala n. 2, P.iva 01973510843, in associazione temporanea di imprese ATI con la ditta “Euro Ambiente Soc. Coop”, con sede in Serradifalco (CL), via Crucillà n. 200/B, P.iva 01330670850, aveva offerto il ribasso del 27,3100% sull’importo posto a base di gara di €. 126.202,00, risultando il più vantaggioso per l’amministrazione; - il verbale di cui sopra è stato pubblicato sul portale MEPA, all’albo pretorio online e nel sito telematico dell’Ente (sezione amministrazione trasparente); - con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. -

Copertina Sicilia Montaggio2020.Indd 1 24/02/20 18:38 La Vacanza È Un' Esperienza Unica Che Passa Attraverso Il Tempo Per Trasformarsi in Un Ricordo Indelebile
La qualità... il vero valore della tua vacanza 2020/2021 NOVITÀ 2020 40 TOURS ESCLUSIVI 2020/2021 per farti scoprire le unicità di luoghi ESCLUSIVI ricchi di storia e tradizione MISURA SU E PRIVATI TOURS ESCLUSIVI ESCLUSIVI TOURS • Partenze garantite CAMPANIA SICILIA ISOLE MINORI SARDEGNA 1 Marzo 2020 | 1 marzo 2021 marzo 1 | 2020 Marzo 1 PUGLIA • Speciali tours privati BASILICATA CALABRIA con itinerari costruiti su misura 2020 - 2021 10/12/19 17:02 Imperatore Travel World Travel Imperatore www.imperatore.it SICILIA montaggio copertina.indd 1 TAORMINA - GIARDINI NAXOS SIRACUSA MODICA - RAGUSA CATANIA - NOTO - MESSINA CEFALÙ - PALERMO 1 Marzo 2020 | 28 Febbraio 2021 2020 | 28 Febbraio 1 Marzo TRAPANI - SAN VITO LO CAPO LICATA - SCIACCA - AGRIGENTO - SELINUNTE www.imperatore.it www.imperatore.it World Travel Imperatore copertina sicilia montaggio2020.indd 1 24/02/20 18:38 La vacanza è un' esperienza unica che passa attraverso il tempo per trasformarsi in un ricordo indelebile. Sogna la destinazione che più ti ispira e affidati ai nostri esperti per costruire il viaggio dei tuoi desideri. Ti accompagneremo nella scelta dell'eccellenza alberghiera, del trasporto più conveniente e delle attività più interessanti per il tuo tempo libero. Da 30 anni Imperatore Travel World lavora con passione alla costruzione di viaggi su misura selezionando strutture e partner di qualità, assicurandoti la nostra assistenza, prima, durante e dopo il viaggio. Ti offriamo sempre la proposta adatta alle tue esigenze. Il team Imperatore Travel World augura una felice e serena vacanza SICILIA SOMMARIO 33. Sicilia Orientale Taormina, Letojanni, Giardini Naxos, Calatabiano, Riposto, Sant'Alessio, USTICA ISOLE EOLIE Linguaglossa, Aci Trezza, Catania, Brucoli, MESSINA Siracusa, Noto, Portopalo di Capo Passero, S. -

Schede Paesaggi Locali 2
Piano Paesaggistico REPUBBLICA ITALIANA ii iitt Regione Siciliana bb Assessorato dei Beni Culturali mm 33 e dell'Identità Siciliana AA -- ii Dipartimento dei Beni Culturali 2 n e dell'Identità Siciliana 2 aan pp Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali rraa di Trapani TT Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA Il Dirigente Generale dott. Gaetano Pennino SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA Il Dirigente Responsabile dott. Michele Buffa SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO arch. Paola Misuraca i n COLLABORATORI a arch. Girolama Fontana arch. Roberto Monticciolo i p l a a CONSULENZA SCIENTIFICA r c Coordinamento generale T 3 o prof. Domenico Costantino arch. Gaetano Renda i L e d Sottosistema abiotico Sottosistema insediativo i Geologia, geomorfologia ed Archeologia 2 a g i idrogeologia dott.ssa Cecilia Buccellato i g l c dott. Angelo La Rosa S.A.P. - Società Archeologica 2 dott. Roberto De Domenico Padana a a n i s n o Sottosistema biotico Sistema Informativo Territoriale v t e o Rete ecologica Ing. Salvatore Cerami i i o a Prof. Renato Massa Dott.ssa Claudia Spinnato b r g P Sottosistema agricolo-forestale Collaborazioni p e m Aspetti agronomici, forestali i Nino De Gaetano r e vegetazionali a Daniela Federico a e i l Prof. Giovanni Curatolo Silvia Scerrino l t d i e b e n d i m t e A n h e c Il Responsabile Unità Operativa VII Il Soprintendente d (arch. -

Campobello Di Mazara Castelvetrano Contessa Entellina Gibellina
Campobello di Mazara Mazara del Vallo Piazza Vittorio Emanuele III, Menfi ca, i particolari vasi del Campaniforme ta, nel centro storico e a San Miceli. Gianbecchina esposte nella omonima grammi, documenti, citazioni letterarie, coordinato dalla Rete dei Musei l’esposizione di industrie litiche di lun/ven: 9.00/13.00 e dello stile Partanna-Naro e, con • La sezione Museo della Mafia e pinacoteca. Il sistema museale include dipinti e filmati guidano il visitatore Siciliani dell’Emigrazione, con il preciso grande interesse risalenti alle epoche T 092570215- 70217 essi, il cranio di un individuo che subì Officina della legalità racconta in un anche l’Ottocentesco Teatro Comunale in una affascinante scoperta dei paesi ruolo di rappresentare in particolare preistoriche (paleolitico); il percorso si www.istituzionefedericosecondo.it con successo un delicato intervento percorso espositivo emozionale ed l’Idea in stile neoclassico, simbolo del della Valle del Belìce prima e dopo l’emigrazione dall’area trapanese e, completa con spazi dedicati alla pale- di trapanazione cranica, al quale è evocativo il fenomeno criminale in fermento culturale e letterario della quella tragica notte del 15 gennaio in generale, dalla Sicilia, per ragioni ontologia e alle epoche protostoriche, certamente sopravvissuto. Completa- modo provocatorio attraverso articoli società sambucese dell’epoca e ancora 1968. Dalle immagini di quei luoghi di politiche. romane e arabe. no il percorso espositivo interessanti pubblicati sui giornali, opere letterarie oggi accogliente e produttiva fucina straordinaria bellezza, si evidenzia la Campobello pannelli didattico-esplicativi, validissimi e cinematografiche. di attività non solo esclusivamente fragilità delle cose umane, si racconta- Piazza A. Moro, Santa Ninfa per comprendere le conoscenze e le • L’Ecomuseo del Grano e del Pane “teatrali”. -
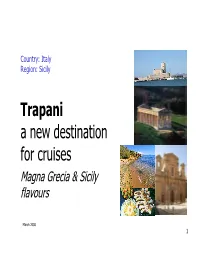
Microsoft Powerpoint
Country: Italy Region: Sicily Trapani a new destination for cruises Magna Grecia & Sicily flavours March 2008 1 Index • The port of Trapani p. 3 – Location p. 3 – Territorial context p. 4 – Infrastructures and port services p. 5 • Trapani as embarkation port p. 7 • Trapani as tourist port: a new destination for cruises p. 7 – 1. Trapani , a town between 2 seas p. 9 – 2. Erice, Punic and Medieval with beautiful view p. 10 – 3. Segesta, the mystery of Elimians p. 11 – 4. Selinunte, once a poweful State p. 12 – 5. Mozia, Phoenician corner in the Stagnone lagoon p. 13 – 6. Marsala, history and wine p. 14 – 7. Mazara del Vallo, the town of “The Satiro” p. 15 – 8. Gibellina and Salemi, art and culture after the earthquake p. 16 – 9. The Nature reserve of “Lo Zingaro” p. 17 – 10. The Nature reserve of “Salt-Pans of Trapani and Paceco” p. 18 – 11. Beaches p. 19 – 12. The Aegades Islands p. 20 – 13. Tuna “factories” p. 22 – 14. The Agrigento Temples Valley p. 23 – 15. Food and wines p. 24 • Province Map p. 26 • References p. 27 2 The port of Trapani: location It is located in the middle of the Mediterranean routes latitude 38° 01' 36" N - longitude 12° 30' 49" E Trapani is a town on the west coast of Sicily, capital of the province of Trapani. His position is baricentric in the Mediterranean sea, thanks to its equidistance from the Suez channel and the Straits of Gibraltar: 665 marine miles from Heraklion 526 marine miles from Barcelona 490 marine miles from Palma de Mallorca 472 marine miles from Marseille 248 marine miles from Civitavecchia 191 -

Diapositiva 1
EUROPA DIREZIONESUD GOVERNO, PROFESSIONI E IMPRESE INSIEME PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO Un nuovo approccio alla Programmazione 2014-2020 Caltanissetta 20/21 Marzo 2015 AGRIGENTO & TRAPANI per una strategia di sviluppo sostenibile e coordinata STRUTTURA DEL LAVORO ANALISI COMPLETA DEL TERRITORIO PER EVIDENZIARE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI GENERICI E AFFRONTARE LE TEMATICHE STRATEGICHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI TEMATICI COMUNITARI A - Sviluppare un ambiente favorevole all’innovazione delle imprese B - Realizzare infrastrutture e assicurare la gestione delle risorse naturali C - Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e inclusione sociale D - Favorire qualità e efficacia dell’azione pubblica gli interventi sono stati organizzati in 4 CATEGORIE 1 Interventi a strategia generale e intercomunali 2 Interventi per città con oltre 30.000 abitanti 3 Interventi per città al di sotto dei 30.000 abitanti 4 Interventi per le isole complessa strategia territoriale d’iniziative economiche d’investimento in infrastrutture regime di sviluppo sostenibile da un punto di vista sia territoriale che ambientale attuabile secondo una scala di priorità in sinergia con le amministrazioni comunali 1.ANALISI Superficie Kmq comuni (43 Agrigento; 24 Trapani) 3 comuni > 50.000 abitanti 7 comuni tra i 30.000 e i 50.000 abitanti 57 comuni< 30.000 abitanti abitanti Erosione costiera Rischio idrogeologico, sismico ATTRATTORI ECONOMICI AMBIENTALI CHE POTREBBERO COSTITUIRE DA SOLE IL VOLANO DI RIPRESA ECONOMICA DELL’INTERA REGIONE fascia costiera da Castellamare -

Routes4u Grant | Phoenicians' Route for EUSAIR Report on Activities Carried Out
Routes4U Grant | Phoenicians' Route for EUSAIR Report on activities carried out 1 Phoenicians' Route EUSAIR Smart Way The objectives of the project “Phoenicians’ Route EUSAIR Smart Way” was: - strengthening the trans-national and inter-regional co-operation, increase the knowledge of the tangible and intangible cultural heritage of the areas involved, in particular Italy, Croatia and Greece by working together with the cultural sector; - increase the knowledge of the tangible and intangible cultural heritage of the areas involved, in particular Italy, Croatia and Greece; - revitalizing tourism attractions and destinations, and diversifying transnational tourism experiences; - working on transnational products linked to cultural and tourist thematic itineraries which, due to their nature, cross national borders and respond better to the needs of the market and the trade. This means becoming part of a wider context, as we are on a path of excellence that guarantees the modern traveler standard and quality, hospitality and sense of belonging, according to a view which is more sensitive to the immaterial offers of tourism and consequently bringing the most satisfaction and fulfillment to the traveler. Putting together cultural and tourist realities of the Eusair area countries involved in the Phoenicians' Route, it will give life to an Adriatic Smart Way very competitive on the market and of great charm and attraction especially for tour operators, travel decision makers and travelers. The project will contribute to the objectives of the -

Piano Di Gestione Locale Dell'unità Gestionale Comprendente Il
FEP 2007-2013 MISURA 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m - Piani di gestione locali) Reg. (CE) n. 1198/2006 Piano di Gestione Locale dell’Unità Gestionale comprendente il Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo Co.Ge.P.A. di Mazara del Vallo 1 INDICE Introduzione 3 1. Caratterizzazione dell‟area d‟azione del PdGL 5 1.1 Descrizione ambientale e geografica dell‟area d‟azione del PdGL 5 1.1.1 Il sistema portuale 6 1.1.2 Climatologia e correnti 6 1.2 Descrizione degli habitat e dello stato delle risorse 7 1.2.1 Lo stato delle principali risorse da pesca 9 1.2.2 Andamento delle catture per unità di sforzo specifico per le principali specie 12 pescate 1.3 Descrizione delle attività di pesca esistenti e della distribuzione spaziale dello 17 sforzo di pesca 1.3.1 Flotta da pesca 17 1.3.2 Segmenti di pesca: catture, composizione per specie e problematiche 20 1.3.3 Commercializzazione e prezzo di prima vendita del prodotto pescato 23 1.3.4 Pesca ricreativa 24 1.3.5 Altre problematiche dell‟area 25 1.4 Descrizione del quadro normativo e gestionale esistente 27 1.5 Analisi dei punti di forza e di debolezza 33 2. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità biologica e socio-economica 35 2.1 Individuazione dell‟obiettivo globale e degli obiettivi specifici 35 2.2 Quantificazione degli obiettivi specifici 36 3 Misure gestionali del Piano di Gestione Siciliano sullo strascico e gli altri mestieri 37 4. Misure gestionali previste per il Piano di Gestione Locale 38 5. -

Com St 06 08 03Calicistelle2006 ENG.Pdf
PRESS RELEASE Calici di Stelle 2006 at Donnafugata Time once again for the great festival of quality wines: visits and guided tastings on the magical night of San Lorenzo. Marsala: August 3, 2006 - The Tenuta di Donnafugata wine estate at Contessa Entellina will again be staging the intriguing “Calici di Stelle” (“Goblets of Stars”) event on August 10. This traditional program of the Wine Tourism Movement is an occasion not to be missed for an encounter between Donnafugata and its admirers. It is a time to communicate the values in which the estate believes: production of quality wines, respect for the environment and exploitation of the territory. Numerous wine lovers, coming from all parts of Italy and from abroad, will have the opportunity to learn about the places and the phases of production that make the wines of Donnafugata great. The visit will begin among the illuminated vineyards where it will be possible to taste some Chardonnay berries to appreciate their intense aroma and to learn about them from the members of the estate staff, who will explain the choice of cultivation methods that make these vineyards an example of modern viticulture. After the presentation of the photovoltaic installation, which satisfies 30% of the estate’s energy needs, visitors will tour the winery in which the estate uses simple technologies that are increasingly respectful of the intrinsic quality of the grapes and musts to obtain wines that respond more completely to the potential of the territory. The educational tour will conclude with the showing of a video that focuses on some of the estate’s most important initiatives and images of the harvest and vinification on the properties at Contessa Entellina and Pantelleria, the island where the passito (raisin) wine Ben Ryé is made. -
Am Biti Am Biti Trapani
Piano Paesaggistico REPUBBLICA ITALIANA ii iitt Regione Siciliana bb Assessorato dei Beni Culturali mm 33 e dell'Identità Siciliana A Dipartimento dei Beni Culturali A -- ii nn e dell'Identità Siciliana 22 aa p ap Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali rra di Trapani TT Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA Il Dirigente Generale dott. Gaetano Pennino SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA Il Dirigente Responsabile dott. Michele Buffa SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO arch. Paola Misuraca COLLABORATORI arch. Girolama Fontana arch. Roberto Monticciolo CONSULENZA SCIENTIFICA Coordinamento generale prof. Domenico Costantino arch. Gaetano Renda Sottosistema abiotico Sottosistema insediativo Geologia, geomorfologia ed Archeologia idrogeologia dott.ssa Cecilia Buccellato dott. Angelo La Rosa S.A.P. - Società Archeologica dott. Roberto De Domenico Padana Sottosistema biotico Sistema Informativo Territoriale Rete ecologica Ing. Salvatore Cerami Prof. Renato Massa Dott.ssa Claudia Spinnato Sottosistema agricolo-forestale Collaborazioni Aspetti agronomici, forestali Nino De Gaetano e vegetazionali Daniela Federico ambito 2 Prof. Giovanni Curatolo Silvia Scerrino Ambiti regionali2 e3 Il Responsabile Unità Operativa VII Il Soprintendente (arch. Girolama Fontana) (arch. Paola Misuraca) Schede dei Paesaggi Locali ricadentinella provincia di Trapani PAESAGGI LOCALI Le identità dei paesaggi Per Paesaggi Locali s'intendono ambiti territoriali relativamente coesi, aperti e interagenti individuati in relazione ai beni paesaggistici e alle componenti prevalenti e alla loro rilevanza ed integrità, attraverso un processo di conoscenza e interpretazione. I Paesaggi Locali sono definiti e individuati in base ai fattori naturali, antropici e culturali che li costituiscono e alle loro relazioni che li caratterizzano e ne determinano l’identità morfologica, paesaggistica, ambientale e storico-culturale, definita e riconoscibile. -

Atto Costitutivo Del Distretto Turistico Selinunte, Il Belice E Sciacca Terme I Sottoscritti Rappresentanti Degli Enti Locali
Atto costitutivo del Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca Terme I sottoscritti rappresentanti degli Enti Locali: 1 - Comune di Sciacca, P. IVA 00220950844, con sede in via Roma 1, nel presente atto rappresentato dall’Assessore Alberto Sabella, nato a Sciacca il 25 giugno 1959, giusta delega del Sindaco dell’8/11/2010; 2 - Comune di Castelvetrano, C.F. 81001210814 e P. IVA 00296480817, con sede in Piazza Umberto I n. 5, nel presente atto rappresentato dal Sindaco Giovanni Pompeo, nato a Castelvetrano il 24 marzo 1952; 3 - Comune di Calamonaci, C.F 83001470844 e P. IVA 02176750848, con sede in Piazza S. Vincenzo Ferreri n. 1, nel presente atto rappresentato dall’Assessore Giuseppe Miceli, nato a Sciacca il 13 marzo 1969, giusta delega del Sindaco dell’8/11/2010; 4 - Comune di Caltabellotta, C.F. 83001070842 e P. IVA 02272200847, con sede in Piazza Umberto n. 7, nel presente atto rappresentato dall’Assessore Angela Intermaggio, nata a Sciacca il 5 agosto 1971, giusta delega del Sindaco dell’8/11/2010; 5 - Comune di Cattolica Eraclea, C.F. 80003990845 e P. IVA 01787060845, con sede in via Rosario n. 1, nel presente atto rappresentato dal Sindaco Cosimo Piro, nato a Cattolica Eraclea il 21 gennaio 1953; Pag. 1 6 - Comune di Menfi, P.IVA 00233230846, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, nel presente atto rappresentato dal Sindaco Michele Botta, nato a Palermo il 4 settembre 1955; 7 - Comune di Montallegro, C.F 80005270840 e P.IVA 02489910840, con sede in Via Vittorio Emanuele n. 70, nel presente atto rappresentato dal Vice Sindaco Signor Antonino Bonifacio, nato a Montallegro il 25 maggio 1966, giusta delega del Sindaco dell’8/11/2010; 8 - il Comune di Montevago, C.F. -

RAPPORTO PRELIMINARE (Ex Art. 13 Comma 1 Del
ALLEGATO A REGIONE SICILIANA A.R.T.A. COMUNE DI MENFI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO Piano di Recupero “Porto Palo di Menfi – Foce Mirabile” (PP1) RAPPORTO PRELIMINARE (ex art. 13 comma 1 del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) UTC/Ufficio di Piano F.to Arch. Calcagno Domenico Lì, 14 dicembre 2017 Rapporto Preliminare – “P.d.R. MENFI” 1 ALLEGATO A Il presente lavoro riguarda la redazione del rapporto preliminare, ex art. 13 comma 1 del D.L.vo n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (D.L.vo n.4/08 - D.L.vo n.128/10), del processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Recupero di “Porto Palo di Menfi – Foce Mirabile” (PP1), interessante l’agglomerato urbano sviluppatosi negli anni settanta, lungo la Foce del vallone Mirabile ed in prossimità della borgata di Porto Palo, frazione del Comune di MENFI. Detto rapporto preliminare è stato redatto dall’ arch. Calcagno Domenico, iscritto al n. 174 dell’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Agrigento, nella qualità di capo del Settore Progettazione del Comune di Menfi e nella specie responsabile del procedimento. Per la redazione del presente documento si è fatto riferimento agli studi, piani e carte tematiche in possesso del Comune e/o fornite dall’ ARTA Sicilia nonché dal Ministero dell’Ambiente e dalla Commissione Europea. ELENCO ACRONIMI Acronimo Definizione AC Autorità Competente (Comune di MENFI) AP Autorità Procedente APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici ARPA Agenzia