Quaderni Di Archeologia Del Piemonte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Borehole Thermal Energy Storage) Y = 0.0137X + 15.873 23 to 160 Days)
Ground Heat Storage Systems: perspective in Mediterranean environments Jessica Maria Chicco,1* Nicolò Giordano2, Giuseppe Mandrone1 1Department of Earth Sciences, University of Turin, Via Valperga Caluso 35, 10125 Italy 2Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre Environnement, 490 Rue de la Couronne, Québec, QC G1K 9A9, Canada * [email protected] 1. Introduction and state of the art Geothermal energy is one of the more environmentally friendly energy source, continuously expanding between the renewable energies, and is expected to more than triple until 2050 (International Energy Agency, 2018). In particular, cooling down is catching on. As a result of populations and incomes growth the use of air conditioners is becoming increasingly common, especially in commercial buildings and high-density residences of the hottest world regions, like Mediterranean areas. A new frontier is covered by ground heat storage systems such as Underground Thermal Energy Storage (UTES). These systems contribute to a large-scale energy efficiency and a long-term storage of thermal energy, significantly reducing environmental impacts, increasing the potential uptake and recovering heat flows that are otherwise lost. They are commonly used in Northern Europe (e.g. Norway, The Netherlands, Germany, Sweden) and in Northern America (e.g. Canada). Focusing on Mediterranean Countries, cooling demand is especially higher than the heating one. It is usually covered through refrigeration systems such as vapor compression devices, which employs electrically driven compressors to transfer energy (Jakubcionis and Carlsson 2018). One of the objective of this project, is then to implement the current studies, such as monitoring thermal underground thermal behavior and modelling of potential UTES resources, transferring this model to other hydro-geological contexts as well. -

ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE, Materiali Per Una Guida, II
206 Archivi di famiglie e persone 2083. NEGRI AS Novara. Vèrsamento. Dati complessivi: bb. 11 (1537-1931 con docc. in copia dal 1167). Elenco. Carte patrimoniali della famiglia Negri, conservate nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità, riguardanti case di Novara e tenute agricole che Giuseppe Negri, nel 1900, lasciò in eredità all'ospedale stesso. BIBi., Guida, III, p. 183. 2084. NEGRONI Giovanni AS Novara. Deposito. Dati complessivi: bb. 3 (1812-1843). La documentazione è costitnita da carte professionali e personali del magistrato e awocato Giovanni Negroni. È conservata in Raccolte. e miscellanee, Mano scritti. 2085. NEGROTTO Biella, Fondazione Sella. Dati complessivi: scatole 6 (XIX-XX). Carte della famiglia Negrotto di Genova; si segualano quelle relative a Pericle f N egrotto, tenente colonnello dei bersaglier� irredentista e nazionalista. 2086. NIBBIA AS Novara. Versamento. Dati complessivi: b. 1 (1561-1780). Elenco. I! piccolo fondo, conservato nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità, contiene carte patrimoniali della famiglia, pervenute all'ente insieme con le pro prietà lasciate in eredità da Carlo Nibbia, chirurgo. BIBi., Guida, III, p. 183. ' , 2087. NICOLIS ,AS Novara. Versamento. Dati complessivi: pergg. 68 (1386-1492). Regesto; in ventario 1457. Le pergamene sono conservate nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità. Con testamento dell'anno 1401 Giovannino Nicolis destinò i propri beni alla fon dazione, in Novara, dell'Ospedale di S. Antonio, poi concentrato (1482) nell'Ospedale della carità. Un piccolo nucleo dell'archivio Nicolis (23 pergame ne) si trova nella raccolta Canetta (vedi scheda relativa). BIBe., Guida, III, p. 183. l. Codicetto contenente privilegi della famiglia Ponzone. Secolo XVI in. -

SWE PIEDMONT Vs TUSCANY BACKGROUNDER
SWE PIEDMONT vs TUSCANY BACKGROUNDER ITALY Italy is a spirited, thriving, ancient enigma that unveils, yet hides, many faces. Invading Phoenicians, Greeks, Cathaginians, as well as native Etruscans and Romans left their imprints as did the Saracens, Visigoths, Normans, Austrian and Germans who succeeded them. As one of the world's top industrial nations, Italy offers a unique marriage of past and present, tradition blended with modern technology -- as exemplified by the Banfi winery and vineyard estate in Montalcino. Italy is 760 miles long and approximately 100 miles wide (150 at its widest point), an area of 116,303 square miles -- the combined area of Georgia and Florida. It is subdivided into 20 regions, and inhabited by more than 60 million people. Italy's climate is temperate, as it is surrounded on three sides by the sea, and protected from icy northern winds by the majestic sweep of alpine ranges. Winters are fairly mild, and summers are pleasant and enjoyable. NORTHWESTERN ITALY The northwest sector of Italy includes the greater part of the arc of the Alps and Apennines, from which the land slopes toward the Po River. The area is divided into five regions: Valle d'Aosta, Piedmont, Liguria, Lombardy and Emilia-Romagna. Like the topography, soil and climate, the types of wine produced in these areas vary considerably from one region to another. This part of Italy is extremely prosperous, since it includes the so-called industrial triangle, made up of the cities of Milan, Turin and Genoa, as well as the rich agricultural lands of the Po River and its tributaries. -

Ivrea and the Moraine Amphitheatre Visitami CONTENTS
VisitAMI VisitAMIIvrea and the Moraine Amphitheatre VisitAMI CONTENTS 1. Moraine Amphitheatre of Ivrea - AMI 7 Great care and attention have been put into preparing this guide to ensure its reliability and the accuracy of the information. However, Turismo Torino e Provincia would urge you to always check on timetables, prices, 2. Ivrea 8 addresses and accessibility of the sites, products and services mentioned. 3. MaAM 14 4. Things to see at AMI 18 5. Via Francigena Morenico-Canavesana 40 6. Nature in AMI 42 7. Flavours and fragrances 50 8. Events 52 Project: City of Ivrea. Creativity and design: Turismo Torino e Provincia. Thanks for their help: Ines Bisi, Brunella Bovo, Giuliano Canavese, Alessandro Chiesi, Cristiana Ferraro, Gabriella Gianotti, Laura Lancerotto, Mariangela Michieletto, Sara Rizzi, Francesca Tapparo, Norma Torrisi, Fabrizio Zanotti. Sent to press: 2016. This guide is the outcome of the work begun in 2013, VisitAMIcommissioned by the City of Ivrea, in which institutes and associations worked jointly as part of the ongoing project for promoting the Moraine Amphitheatre of Ivrea-AMI (Anfiteatro Morenico di Ivrea). The AMI is described page after page, making the guide a useful way for visitors to discover the many artistic resources and all the natural scenery made even more attractive when combined with the many outdoor activities available. And then there are details about the extensive offer of wine and food and the many events that, during the year, are able to offer a unique, delightful experience. AMI is all this and much more, whose hidden nooks and marvels can be discovered by tourists in the many routes proposed. -

Chemical and Volatile Composition of Three Italian Sweet White Passito Wines
5-luca 28/09/09 18:04 Page 159 CHEMICAL AND VOLATILE COMPOSITION OF THREE ITALIAN SWEET WHITE PASSITO WINES Manuela GIORDANO, L. ROLLE*, G. ZEPPA and V. GERBI Dipartimento di Valorizzazione e Protezione Risorse Agroforestali, Settore Tecnologie Alimentari, Università degli Studi di Torino, Via L. da Vinci 44, 10095 Grugliasco (TO), Italy Abstract Résumé Aims: This study was designed to gain knowledge of three Controlled Objectifs : Cette étude a pour but d’améliorer la connaissance de trois vins Denomination of Origin (DOC) Italian sweet white Passito wines (Caluso doux italiens Passito d’Appellation d'Origine Contrôlée (DOC) : Caluso Passito DOC, Cinque Terre Sciacchetrà DOC and Passito di Pantelleria Passito DOC, Cinque Terre Sciacchetrà DOC et Passito di Pantelleria DOC) produced in several areas of Italy from grapes dried with different DOC. Ces vins produits dans trois régions italiennes sont issus de raisins systems and vinification techniques. séchés par différentes techniques de passerillage et de vinification. Methods and results: Physico-chemical and chromatic characteristics, Méthodes et résultats : Les caractéristiques physico-chimiques et sodium, potassium, gluconic acid, glucono-γ-lactone, acetaldehyde, sorbitol, chromatiques, la teneur en sodium, en potassium, en acide gluconique, en laccase, organic acids and semi-quantitative free volatile profile were gluco-γ-lactone, en acétaldéhyde, en sorbitol, en laccase, en acides determined on these wines. organiques ainsi que le profil semi-quantitatif des composés volatils libres Caluso Passito DOC wines presented higher contents of organic acids ont été déterminés dans les vins étudiés. (above all, malic acid), main metabolites from noble Botrytis cinerea Les vins de l’appellation Caluso Passito ont présenté la plus forte teneur (laccase, glycerol, gluconic acid and benzaldehyde) and low contents of en acides organiques (en particulier en acide malique), des métabolites total polyphenols. -

20173003Pieghevole Maestri-Del
Botteghe artigiane, negozi del centro, aziende agricole, laboratori in- pasticcerie - cakes & confectionery salumifici - pork butchers & charcuterie • Ugetti Bardonecchia, Via Medail 80 - [email protected] • Nadia Caluso, Frazione Arè di Caluso Via Pasubio 50 novativi ed empori di paese: tutto il gusto e l’eccellenza enogastrono- • Di Claudio Carmagnola, Via Giolitti 36 [email protected] - www.salumificionadia.com mica torinese sono raccolti in questo elenco di 182 Maestri, rigorosa- [email protected] - www.pasticceriadiclaudio.com • Salumificio del Castello Moncalieri, Via Fossano 3 mente selezionati e verificati dalla Camera di commercio di Torino, dal • Molineris Carmagnola, Piazza Sant’Agostino 14 [email protected] - www.salumificiodelcastello.it suo Laboratorio Chimico e da Slow Food per il biennio 2017-2018. [email protected] - www.molineris.it • Pitti Cascinette d’Ivrea, Via Pietro Crotta 134 - [email protected] torrefazioni - coffee roasters & coffee shops Dal 2002 il progetto dei Maestri del Gusto offre un ventaglio di pro- www.pasticceriaivrea.com • Castelli Caselle Torinese, Via • Giuliano Caffè Caluso, Via Vittorio Veneto 140 poste per gustare con la mente, gli occhi e il palato quanto di imper- Cravero 34 - [email protected] • Avidano Chieri, Via Vittorio [email protected] - www.giulianocaffe.it • Antica Torrefazione del Centro Carmagnola, Via Valobra Emanuele II 46 - [email protected] - www.avidano.it • Buttiglieri dibile si crea e si produce a Torino e in provincia. -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome NICOLETTA BLENCIO Indirizzo E-mail [email protected] Nazionalità ITALIANA ESPERIENZA LAVORATIVA 2016 - 2019 Segretario Generale del Comune di Piossasco (TO) – Classe I B 2014 - 2016 Segretario Generale del Comune di Leini (TO) – Classe II 2013 - 2014 Segretario Generale del Comune di Sanremo (IM) – Classe I B 2008 – 2013 Segretario Generale del Comune di Caluso (TO) – Classe II 2006 - 2007 Segretario Generale del Comune di Mondovì (CN) – Classe I B 1999 - 2006 Segretario Comunale del Comune di San Giusto Canavese (TO) 1998 Segretario Generale Reggente del Comune di Caluso 1994 - 1999 Segretario Comunale Consorzio di Segreteria tra i Comuni di Borgiallo e Castelnuovo Nigra (TO) 1998 - 2006 Segretario del C.I.S.S-A.C. (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Caluso) 1998 - 2003 Segretario dell’Azienda dell’Acqua del Comprensorio di Caluso (già Consorzio Acque Reflue) 1991 - 1994 Istruttore Direttivo – Capo Settore Amministrativo – VIII° q.f. – Comune di Cuorgnè (TO) 1991 - 1994 Cancelliere di Conciliatura presso la Conciliatura di Cuorgnè (TO) – Comune di Cuorgnè (TO) 1990 - 1991 Incarico di supplenza in discipline giuridiche presso Istituto d’Arte “Faccio” di Castellamonte (TO) ABILITAZIONI E NOMINE 1992 Compiuta pratica legale e superamento delle prove scritte nell’esame per l’abilitazione alla professione di Procuratore Legale presso il Tribunale di Torino – Sessione 1992 – Ordine Avvocati e Procuratori di Ivrea (TO) 1993 Vincitrice -

Strutture Che Effettuano Tampone Rapido E Test Sierologico Elenco Delle Strutture Private Autorizzate
Strutture che effettuano tampone rapido e test sierologico Elenco delle strutture private autorizzate ultimo aggiornamento 18 novembre 2020 Denominazione Classificazione Settori Accreditato SSN Santa Croce S.R.L. - Poliambulatorio laboratorio generale di base microbiologia e sieroimmunologia si Statuto Via Saluzzo 50 - 10122 Torino Clinica Pinna Pintor laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia no Via Amerigo Vespucci 61 citoistopatologia 10129 Torino microbiologia e sieroimmunologia Studio Medico Mirafiori S.R.L. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Strada Basse Del Lingotto 19/A ematologia 10127 Torino citoistopatologia Laboratorio Analisi Mediche Raffaello laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Corso Raffaello 17/G microbiologia e sieroimmunologia 10125 Torino Unilabs IMT - Medil S.P.A. laboratorio specialistico di Sospensione temporanea Via Valperga Caluso 32 citoistopatologia accreditamento dic 2019 DD 10148 Torino 964 del 23/12/2019 ultimo aggiornamento 18 novembre 2020 A.N.S.A. S.R.L. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Via Santorre Di Santarosa 18 microbiologia e sieroimmunologia 10131 - Torino C.D.C. S.P.A. (prima Fiat Se.P.In S.C.P.A.) laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia no C.So Massimo D'Azeglio, 25 - Torino Cellini S.P.A. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Via Cellini 5 - 10126 Torino ematologia microbiologia e sieroimmunologia citoistopatologia Promea S.P.A. laboratorio di genetica medica si Via Menabrea 14 - 10126 Torino Pro Infantia Ospedale Koelliker S.P.A. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Corso G. Ferraris 255 - 10134 Torino ematologia microbiologia e sieroimmunologia citoistopatologia C.D.C. -

Erbaluce Di Caluso “Macaria” DOCG
Erbaluce di Caluso “Macaria” DOCG Grape variety: 100% Erbaluce (native grape variety) Production area: Settimo Rottaro and Piverone, situated among the hills of Ivrea morainic amphitheatre, in Canavese (TO), Northern Piedmont; it is the typical area of Erbaluce grape variety, obtaining here its best quality expression Soil: Hilly, with sweet ups and down, made of clay sand and relevant cobblestones Slope: Hilly soil, medium slope Growing method: Canavese traditional pergola and, partially, with guyot pruning Defense method: Low-environmental impact integrated insecticide method Grape harvest period: September, second or last decade, after grape ripeness systematic control Harvest method: Accurate choice of perfectly healthy and highly matured grapes; hand collection in 20 kg. perforated crates Winemaking: Grapes are delicately destemmed and left in maceration with skins for about 12-18 hours, in order to better extract all scents; the obtained grape juice is clarified by spontaneous settling, and subsequently brought to 16°C temperature in order to start the alcoholic fermentation Refinement and bottling: In the middle of the alcoholic fermentation, 90% of the must goes to barrels to end the fermentation and acquire malolactic fermentation while 10% matures in stainless steel tanks; in both cases weekly batonnages take place. Assemblage is made after minimum 10 months. After bottling, the wine rests 6 months before commercialization Sensory notes: Color: brilliant straw yellow with light gold reflex Scent: complex, intense, long, with -

14-Sandrone Et Al
Per. Mineral. (2004), 73, 211-226 http://go.to/permin SPECIAL ISSUE 3: A showcase of the Italian research in applied petrology An International Journal of MINERALOGY, CRYSTALLOGRAPHY, GEOCHEMISTRY, ORE DEPOSITS, PETROLOGY, VOLCANOLOGY and applied topics on Environment, Archaeometry and Cultural Heritage Contemporary natural stones from the Italian western Alps (Piedmont and Aosta Valley Regions) RICCARDO SANDRONE1*, ANNITA COLOMBO2, LAURA FIORA3, MAURO FORNARO4, ENRICO LOVERA1, ANNALISA TUNESI2 and ALESSANDRO CAVALLO5 1 Dip. Georisorse e Territorio, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy 2 Dip. Scienze Geologiche e Geotecnologie, Università di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 4, 20126 Milano, Italy 3 Dip. Scienze Mineralogiche e Petrologiche, Università degli Studi di Torino, Via Valperga Caluso 35, 10125 Torino, Italy 4 Dip. Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, Via Valperga Caluso 35, 10125 Torino, Italy 5 Dip. Scienze della Terra “Ardito Desio”, Università degli Studi di Milano, Via Mangiagalli 34, 20133 Milano, Italy ABSTRACT. — At present about 60 different INTRODUCTION kinds of stones are quarried in the Italian Western Alps, most of which are metamorphic In the Italian Western Alps a great deal of rocks (gneiss, ophicalcite, marble and quartzite) and, to a lesser extent, magmatic (granite, syenite different varieties of stones were quarried in . and diorite), with an overall production of 380 000 the past and can be considered historical stones m3 in the year 2002. This work synthetically because of their diffusion or use in monumental illustrates their geologic and petrographic works (see, for example, Barelli, 1835; Jervis, characteristics, gives essential historical information 1889; Salmoiraghi, 1892; Blangino, 1895; and examines the technical, environmental and economic aspects of their extraction and Sacco, 1907; Peretti, 1938). -
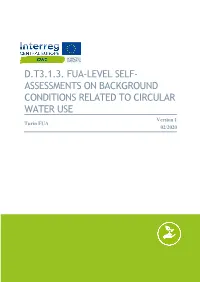
D.T3.1.3. Fua-Level Self- Assessments on Background Conditions Related To
D.T3.1.3. FUA-LEVEL SELF- ASSESSMENTS ON BACKGROUND CONDITIONS RELATED TO CIRCULAR WATER USE Version 1 Turin FUA 02/2020 Sommario A.CLIMATE,ENVIRONMENT AND POPULATION ............................................... 3 A1) POPULATION ........................................................................................ 3 A2) CLIMATE ............................................................................................. 4 A3) SEALING SOIL ...................................................................................... 6 A4) GREEN SPACES IN URBANIZED AREAS ...................................................... 9 B. WATER RESOURCES ............................................................................ 11 B1) ANNUAL PRECIPITATION ...................................................................... 11 B2) RIVER, CHANNELS AND LAKES ............................................................... 13 B3) GROUND WATER .................................................................................. 15 C. INFRASTRUCTURES ............................................................................. 17 C1) WATER DISTRIBUTION SYSTEM - POPULATION WITH ACCESS TO FRESH WATER .................................................................................................... 17 C2) WATER DISTRIBUTION SYSTEM LOSS ..................................................... 18 C3) DUAL WATER DISTRIBUTION SYSTEM ..................................................... 18 C4) FIRST FLUSH RAINWATER COLLECTION ................................................ -

SERIES Basement and Mesozoic Cover, Are Known by Different Local Names (E.G
GEOSCIENCE CANADA Volume 43 2016 13 SERIES basement and Mesozoic cover, are known by different local names (e.g. Luserna Stone, Borgone and Vaie Stone, Perosa Stone, Bargiolina Quartzite, Foresto and Chianocco Marble). These stones were largely employed during the 17th and 18th centuries for some of the most famous and important monuments in Turin (capital of Piedmont region, northwestern Italy), as well as in the countryside, since Roman times. Some of the materials exploited in the Dora-Maira Unit were also exported to foreign countries: Borgone and Vaie Stone were used for the paving of the Louvre Museum, and Perosa Stone was employed for the construction of the monument of Independence in Lagos, Nigeria. Consequently, the Dora-Maira Unit can be designated as a Global Heritage Stone Province. RÉSUMÉ L’Unité Dora-Maira est une unité géologique affleurant dans la Heritage Stone 2. partie interne des Alpes Cottiennes; elle appartient au Domai- ne Penninique des Alpes occidentales (Italie du Nord-Ouest). The Dora-Maira Unit (Italian Cottian Alps): A Elle se compose d’une croûte continentale d’âge Paléozoïque Reservoir of Ornamental Stones Since supérieur et de sa couverture carbonatique Mésozoïque, méta- morphosées en faciès éclogite pendant le Cénozoïque. En rai- Roman Times* son de la complexité des associations lithologiques et des transformations métamorphiques et structurelles, l’Unité + Alessandro Borghi , Paola Cadoppi and Giovanna Dora-Maira a été une source de pierres ornementales au cours Antonella Dino des siècles, et encore il représente un réservoir de matériau employé localement pour des bâtiments contemporains et his- Department of Earth Sciences, University of Turin toriques.