*Chiusdino 07
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geothermal Energy Use, Country Update for Italy
European Geothermal Congress 2019 Den Haag, The Netherlands, 11-14 June 2019 Geothermal Energy Use, Country Update for Italy Adele Manzella1, Davide Serra2, Gabriele Cesari3, Eleonora Bargiacchi1, Maurizio Cei2, Paolo Cerutti3, Paolo Conti1, Geoffrey Giudetti2, Mirco Lupi2, Maurizio Vaccaro1, 1 UGI – Italian Geothermal Union, c/o University of Pisa-DESTEC, Largo Lazzarino 2, 56122 Pisa, Italy 2 Enel Green Power, via Andrea Pisano, 120, 56122 Pisa, Italy 3ANIGHP – National Association of Geothermal Heat Pump, via Quintino Sella 23, 00187, Roma, Italy [email protected] Keywords: Electricity generation, Thermal uses, temperature systems tend to be in tectonically active District heating, Geothermal heat pumps, Thermal regions either in volcanic and intrusive or fault- balneology, Agricultural applications, Fish farming, controlled systems (Santilano et al., 2015 and ref. Industrial processes, Development, Market, Support therein). measures. Electricity from geothermal resources nowadays is ABSTRACT produced in the Tuscany region, central Italy. Many direct applications of geothermal heat are also located This paper presents an overview on the development of in Tuscany, however thermal uses are widespread in the geothermal energy applications in Italy for the year national territory, with district heating systems (DHs) 2018 for both electricity generation and thermal uses. mostly localised in the north and other direct uses and Geothermal power plants are located in Tuscany, in the ground source heat pumps (GSHPs) distributing on a two “historical” areas of Larderello-Travale and Mount much larger territory. Amiata. Thermal energy applications are widespread over the whole Italian territory. To date, Enel Green The first part of this paper (sections 2-5) deals with geo- Power is the only geo-electricity producer in Italy. -

Passion for Cycling Tourism
TUSCANY if not HERE, where? PASSION FOR CYCLING TOURISM Tuscany offers you • Unique landscapes and climate • A journey into history and art: from Etruscans to Renaissance down to the present day • An extensive network of cycle paths, unpaved and paved roads with hardly any traffic • Unforgettable cuisine, superb wines and much more ... if not HERE, where? Tuscany is the ideal place for a relaxing cycling holiday: the routes are endless, from the paved roads of Chianti to trails through the forests of the Apennines and the Apuan Alps, from the coast to the historic routes and the eco-paths in nature photo: Enrico Borgogni reserves and through the Val d’Orcia. This guide has been designed to be an excellent travel companion as you ride from one valley, bike trail or cultural site to another, sometimes using the train, all according to the experiences reported by other cyclists. But that’s not all: in the guide you will find tips on where to eat and suggestions for exploring the various areas without overlooking small gems or important sites, with the added benefit of taking advantage of special conditions reserved for the owners of this guide. Therefore, this book is suitable not only for families and those who like easy routes, but can also be helpful to those who want to plan multiple-day excursions with higher levels of difficulty or across uscanyT for longer tours The suggested itineraries are only a part of the rich cycling opportunities that make Tuscany one of the paradises for this kind of activity, and have been selected giving priority to low-traffic roads, white roads or paths always in close contact with nature, trying to reach and show some of our region’s most interesting destinations. -

Südlich Von Siena Das an Siena Südlich Angrenzende Gebiet Ist Sehr Vielseitig
Wanderung durch den Montagnola-Wald zur Ponte della Pia 67 Südlich von Siena Ponte della Pia bei Rosia Südlich von Siena Das an Siena südlich angrenzende Gebiet ist sehr vielseitig. In der Montag- nola und den Colline Metallifere nach Westen ist es waldig und wenig besie- delt. Bergbau war hier für lange Zeit der wichtigste Wirtschaftsfaktor, für eine landwirtschaftliche Nutzung war das Gebiet zu hügelig und zu wenig fruchtbar. Hier finden sich ausgedehnte Eichenwälder, in denen sich nicht nur Wildschweine wohl fühlen. Das oft schwer zu durchdringende Buschwerk, die macchia mediterranea, bietet vielen Tieren Schutz und macht die Gegend zwischen Siena, Murlo und Roccastra- da bzw. zwischen den Flüssen Farma und Merse nicht nur im heißen Sommer zu einem interessanten Erkundungsgebiet. Einen starken Kontrast bilden die südli- chen Crete, die bis nach Montepulciano und in das Val di Chiana reichen. Bis zur Getreideernte versteht man, weshalb die riesigen Flächen bereits in römischen Zei- ten als Kornkammer betrachtet wurden. Wenig später, bis zum Frühjahr, gleicht das Meer aus Erde – insbesondere bei Nacht – einer Mondlandschaft. Dann werden die eigentümlichen geologischen Formationen mit ihren Schluchten noch plastischer. Von Siena durchziehen alte Pilger- und Handelswege das Gebiet Richtung Süden. Die mittelalterliche Massetana führt von der Porta San Marco in Siena an der Ab- tei San Galgano vorbei bis an die Küste der Maremma, und die Frankenstraße, die ihren Anfang in Canterbury hat, führt von Siena fast schnurgerade über Viterbo nach Rom. An dieser Strecke entstanden zahlreiche Klöster und Einsiedeleien. Ganz im Süden der Toscana, fast an der Grenze zum Latium, wird das Landschafts- bild vom kegelförmigen Monte Amiata dominiert, an dessen Hängen einige be- schauliche und bisher wenig besuchte Orte liegen. -

*Chiusdino 01-02
I - IL CONTESTO TERRITORIALE 1. CARATTERI GEOMORFOLOGICI tre nelle tabelle verranno mantenute le informazioni di dettaglio (fig. 2) 2. Il comprensorio comunale di Chiusdino, situato a sud-ovest di Siena, occupa il settore centro-occidentale della Toscana meridio- Litotipo % nale, per un’estensione complessiva di 141,85 kmq. Confina a nord- ovest e nord-est rispettivamente con Radicondoli e Sovicille, a sud- Detriti e discariche 5,6% Depositi alluvionali 17% ovest con Montieri, a sud-est e sud con Monticiano e Roccastrada. Travertini e calcari organogeni 1,6% I limiti amministrativi non definiscono un ambito geografico- Argille 16% morfologico omogeneo e unitario. Argille e argille sabbiose con intercalazione 5,2% Sabbia con intercalazioni di argille e ciottoli 7,2% La porzione centrorientale del comune, a carattere prevalentemente Conglomerati poligenici con intercalazione 12% pianeggiante e basso collinare, rappresenta la zona medio-alta del ba- Flysh prevalentemente arenacei 0,04% cino idrografico del fiume Merse e del Feccia (affluenti dell’Om- Flysh prevalentemente argillitici 17,4% Rocce carbonatiche massicce 0,36% brone rispettivamente di destra e di sinistra); un lungo tratto del con- Rocce carbonatiche brecciate 7,2% fine orientale del comprensorio è demarcato proprio dal primo dei Rocce silicee 8,8% due fiumi. Ofioliti 1,5% Il paesaggio si modifica progressivamente fino ad assumere un ca- Tabella riassuntiva della distribuzione percentuale delle diverse formazioni geologiche pre- rattere più prettamente alto collinare e montuoso, procedendo senti nel comprensorio (le percentuali sono relative alla superficie totale del comprensorio) verso le porzioni estreme del comune; i versanti nord-est e sud- ovest coincidono infatti, l’uno con le ultimi propaggini della Mon- L’incrocio fra le caratteristiche morfologiche e quelle geo-litologiche tagnola Senese e l’altro con il sistema dei rilievi collinari delle Col- permette di individuare quattro unità paesaggistiche (descritte nella line Metallifere. -
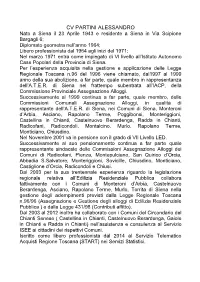
Cv Partini Alessandro
CV PARTINI ALESSANDRO Nato a Siena il 23 Aprile 1943 e residente a Siena in Via Scipione Bargagli 6; Diplomato geometra nell’anno 1964; Libero professionista dal 1964 agli inizi del 1971; Nel marzo 1971 entra come impiegato di VI livello all’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siena. Per l’esperienza acquisita nella gestione e applicazione delle Legge Regionale Toscana n.96 del 1996 viene chiamato, dal1997 al 1999 anno della sua abolizione, a far parte, quale membro in rappresentanza dell’A.T.E.R. di Siena nel frattempo subentrata all’IACP, della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi. Successivamente al 1999 continua a far parte, quale membro, delle Commissioni Comunali Assegnazione Alloggi, in qualità di rappresentante dell’A.T.E.R. di Siena, nei Comuni di Siena, Monteroni d’Arbia, Asciano, Rapolano Terme, Poggibonsi, Monteriggioni, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Montalcino, Murlo, Rapolano Terme, Monticiano, Chiusdino. Nel Novembre 2001 va in pensione con il grado di VII Livello LED. Successivamente al suo pensionamento continua a far parte quale rappresentante sindacale delle Commissioni Assegnazione Alloggi dei Comuni di Radicofani, Pienza, Montepulciano, San Quirico d’Orcia, Abbadia S.Salvatore, Monteriggioni, Sovicille, Chiusdino, Monticiano, Castiglione d’Orcia, Radicondoli e Chiusi. Dal 2003 per la sua trentennale esperienza riguardo la legislazione regionale relativa all’Edilizia Residenziale Pubblica collabora fattivamente con i Comuni di Monteroni d’Arbia, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Rapolano Terme, Murlo, Torrita di Siena nella gestione degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale Toscana n.96/96 (Assegnazione e Gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ) e dalla Legge 431/98 (Contributi affitto). -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -

CHIUSDINO, MONTICIANO, SOVICILLE: Analisi Dei Contesti Territoriali
SIIC80700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010762 - 05/12/2018 - C/17 accesso atti amm.vi, - E CHIUSDINO, MONTICIANO, SOVICILLE: analisi dei contesti territoriali L’Istituto A. Lorenzetti è situato al centro di un territorio variegato e ricco di storia, di cultura, di arte, di attività economiche e umane, che si è arricchito negli ultimi decenni di nuove risorse umane e etniche. I tre comuni di Chiusdino, di Monticiano e di Sovicille rappresentano tre realtà che in parte sono differenti per conformazione fisica del territorio, ma che nel tempo hanno interagito e hanno comunicato, arricchendosi a vicenda, dal punto di vista socio-culturale ed economico. Situate alle https://www.google.it/search?q=chiusdino+monticiano+boschi&espv=2&biw=1122&bih=407&source pendici della Montagnola =lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx5_ry6LHKAhXG9w4KHdrHC4EQ_AUICCgD#imgrc=04u3aovvJ Senese, Chiusdino e PLK_M%3A Monticiano si trovano immersi in un’area boschiva di grande pregio naturalistico, mentre Sovicille è caratterizzata dalla presenza della Piana di Rosia, che porta le tracce di antichi insediamenti etruschi. Tutti e tre, con le loro diversità, sono accomunati dall’importante SIIC80700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010762 - 05/12/2018 - C/17 accesso atti amm.vi, - E presenza del fiume Merse e sono collocati nella valle che dal fiume prende il nome. Il paesaggio vario – con colline, zone agricole, radure, boschi – è interessato da quattro Riserve Naturali, finalizzate alla conservazione degli ecosistemi, alla promozione e alla incentivazione delle attività produttive e del tempo libero. Tali aree sono compatibili con lo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca e della promozione e incentivazione delle attività coordinate di informazione e di educazione ambientale. -

I. Indice Cronologico Delle Filze II
I. Indice cronologico delle filze II. Indice dei mittenti III. Indice dei destinatari IV. Indice toponomastico V. Repertorio dei documenti In neretto il numero della filza, in tondo il numero della carte. In parentesi e in corsivo sono segnate le varianti riscontrate nei documenti. In corpo minore si danno indicazioni essenziali atte ad una migliore identificazione e riferite, in generale, all’arco cronologico nel quale la voce stessa figura in questo volume. Per imperatori, papi, regnanti su stati sovrani e loro consorti , il richiamo è al nome di battesimo. Per le donne il richiamo è al cognome da nubile, quando conosciuto. Nel Repertorio dei documenti diversi, il richiamo è al termine concettualmente più vicino ai contenuti espressi dalla voce come questa figura nel testo dell’Inventario. In ogni categoria di indici è stato fatto il più ampio uso di rinvii onde facilitare il reperimento delle voci. Al termine dei rispettivi indici sono stati segnalati lettere e documenti privi di mittente, di destinatario, di riferimento toponomastico e cronologico. La voce Cosimo I, nell’indice dei destinatari, porta la dizione passim. I luoghi di destinazione non sono contemplati. I. INDICE CRONOLOGICO DELLE FILZE 1545 Febbraio 443 1547 Settembre 442 1557 Gennaio 439 1564 Gennaio 442 1584 Dicembre 436 1552 Marzo 438 Agosto 433 Dicembre 438 1553 Gennaio 438 ; 442 Febbraio 442 Marzo 438 Giugno 442 Settembre 438 Dicembre 438 1554 Gennaio 438 ; 439 ; 440 ; 442 ; 443 Febbraio 438 ; 439 ; 440 ; 442 ; 443 Marzo 433 ; 436 ; 438 ; 441 ; 442 ; 443 ; 444 ; -

Leadership and Community in the Arts: a Case Study of Legend and Culture in Chiusdino, Italy
Kutztown University Research Commons at Kutztown University Arts Administration Masters Theses Art Education Spring 4-2019 Leadership and Community in the Arts: A Case Study of Legend and Culture in Chiusdino, Italy Amanda Svetlak Kutztown University, [email protected] Follow this and additional works at: https://research.library.kutztown.edu/artadministration Part of the Arts Management Commons, Leadership Studies Commons, Marketing Commons, Museum Studies Commons, Nonprofit Administration and Management Commons, Organizational Behavior and Theory Commons, Organization Development Commons, and the Tourism and Travel Commons Recommended Citation Svetlak, Amanda, "Leadership and Community in the Arts: A Case Study of Legend and Culture in Chiusdino, Italy" (2019). Arts Administration Masters Theses. 1. https://research.library.kutztown.edu/artadministration/1 This Thesis is brought to you for free and open access by the Art Education at Research Commons at Kutztown University. It has been accepted for inclusion in Arts Administration Masters Theses by an authorized administrator of Research Commons at Kutztown University. For more information, please contact [email protected],. LEADERSHIP AND COMMUNITY IN THE ARTS: A CASE STUDY OF LEGEND AND CULTURE IN CHIUSDINO, ITALY A Thesis Presented to the Faculty of the Department of Art Education & Crafts Arts Administration Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, Pennsylvania In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts by Amanda Svetlak April 2019 Abstract The complexity of culture goes beyond artistic expression, nationality, race, and religion. Culture shapes our communications, interactions, and our perceptions of the world around us (Hall, 1989). Studies show that self-awareness of our own culture through exposure to the unfamiliar leads to intercultural competences (Herlo, 2015; Crossman, 2011; Hermond 2018; Hall 1989). -

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE Comuni Di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Chiusdino (Provincia Di Siena)
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Chiusdino (Provincia di Siena) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 31.01.2018 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN GALGANO IN CHIUSDINO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E ALLEGATI A CORREDO DELL’OFFERTA – NUOVA INDIZIONE. CUP I29D17000490004 CIG 73699757C3 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTA la Convenzione stipulata il 02 aprile 2013 tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Chiusdino e l’Unione dei Comuni della Val di Merse, con la quale è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture con corrispondente delega all’esercizio delle attività in parola all’Unione dei Comuni della Val di Merse; VISTO il Decreto n. 35 del 16/10/2017 del Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, di conferimento della posizione organizzativa di Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza; VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; RICHIAMATA la propria determinazione n. 26 del 30.01.2018 con la quale è stata determinata l’indizione della gara in oggetto e sono stati approvati il bando/disciplinare di gara e gli allegati per la presentazione dell’offerta; RICORDATO che il bando/disciplinare e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 30.01.2018 all’albo on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Chiusdino, ove si svolgeranno i lavori, e del sito dell’Unione dei Comuni della Val di Merse; PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. -

Val Di Merse
Val di merse La Val di Merse si colloca ad ovest di Siena tra la val d’Elsa e la val d’Orcia. E’ terra di passaggio verso il mare e la maremma. E’ costituita dai territori dei comuni di Sovicille, Chiusdino, Monticiano e Murlo. Tra gli ambiti della Provincia senese è quello meno evocato dagli itinerari turistici, ma la sua ricchezza di Pievi, Chiese, Ville, Castelli, Siti Archeologici, Abbazie, fiumi, mulini ed il paesaggio davvero peculiare, lasciano un segno indelebile nell’animo di ogni visitatore. Sovicille Il patrimonio storico – artistico del territorio è di assoluto rilievo e può vantare una diffusa presenza di Pievi romaniche come San Giusto a Balli, Pernina, Molli, Ponte allo Spino, la Pieve di San Giovanni Battista a Rosia, la chiesa di San Lorenzo a Sovicille e Torri con il notevole chiostro policromo dell’Abbazia di Santa Mustiola. Tra le ville si segnala la seicentesca Cetinale, il castello di Celsa con la cinquecentesca cappella del Peruzzi, il granaio, il parco e lo scenografico giardino all’italiana (visitabile da marzo ad ottobre) e la settecentesca Villa Linari. Le Tombe Etrusche della Necropoli di Malignano. Un discorso a parte merita il Ponte della Pia, che la leggenda vuole fosse attraversato dalla Pia de’ Tolomei per il suo esilio in Maremma, come ricordato da Dante nel V canto dell’Inferno. Chiusdino Nel paese, affacciato in magnifica posizione sulla valle della Merse la chiesa di San Martino detta “fuori le mura”, la Prepositura di San Michele, attigua alla casa natale di San Galgano e la chiesa della Compagnia di San Galgano con un interessante bassorilievo (1466) raffigurante San Galgano che conficca la spada nella roccia. -

I Bolli Guller Delle Province Di Siena E Grosseto Massimo Monaci E Paolo Saletti (Aspot)
I bolli Guller delle province di Siena e Grosseto Massimo Monaci e Paolo Saletti (Aspot) Presentazione Il servizio postale è tuttora un campo fertile di ricerca per chi ha voglia e tempo, ma credo che in tema di bolli ci sia ben poco di importante da scoprire, almeno per il periodo fin ad oggi indagato, che dai precursori va fino ai tondo- riquadrati, vale a dire fino a cent’anni fa. E dopo? Dopo vengono i bolli Guller, così chiamati dal nome della ditta svizzera che li fabbricava e che fornì per alcuni anni anche le nostre Poste. Queste in seguito provvidero da sé, incaricando (forse dal 1926 in poi) le singole Direzioni postali di provvedere quando ce ne fosse bisogno, per rottura o smarrimento dei timbri o per apertura di nuovi uffici, incaricando incisori locali; i bolli dovevano essere sempre del tipo Guller, ma inevitabilmente ci sono fra loro differenze di dimensione, caratteri, ornato e altro. Ebbene, questi bolli – Guller o tipo Guller - furono in dotazione a tutti gli uffici postali (direzioni, ricevitorie e collettorie) aperti nel secolo scorso e crediamo sia il caso di cominciare a occuparcene più di quanto si è fatto finora. Saltuariamente c’è stato in passato un certo interesse, specialmente per i cosidetti “frazionari”, poi non ne ho più sentito parlare. Io sono ormai agli sgoccioli, ma ho lanciato l’idea a due cari amici, Paolo Saletti e Massimo Monaci, che sarei tentato di chiamare “allievi” (anche se ormai mi hanno superato), appassionati come me di storia postale. Hanno aderito di buon grado a fare una prima sommaria catalogazione per quanto riguarda le provincie di Siena e di Grosseto.