Dr. Geol. Giovanni Moro INDICE Pag
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lr 3/2020 Art. 5
Allegato 1 LR 3/2020 ART. 5 - DGR 1718 - ELENCO DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO 13.545.600,00 Numero Denominazione Partita IVA Comune Provincia Contributo protocollo SAN LORENZO #BARINPLAZA DI BOT CRISTINA 01200750311 33996 GO 1.500,00 ISONTINO #IRICCI3STANZE 00000000000 37415 MONFALCONE GO 900,00 0.3 STANZE 00000000000 31850 TRIESTE TS 900,00 0433 S.R.L. 02790740308 28278 RAVASCLETTO UD 4.800,00 100UNO SRL 02607290307 24997 TOLMEZZO UD 1.500,00 1077 S.R.L. 02946980303 16734 CAMPOFORMIDO UD 1.800,00 FOGLIANO 15 - 18 DI YAN SENXIAN 04653210288 18670 GO 1.500,00 REDIPUGLIA 1975 FOOD SRL 02853190300 20895 POZZUOLO DEL FRIULI UD 1.800,00 2 B DI BRIEDA ANGELO & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 00385600937 38440 SACILE PN 1.800,00 LIGNANO 21 SNC DI BILALI ARJON E DEL NEGRO ROBERTO 02886080304 21145 UD 1.800,00 SABBIADORO 23PUNTO02 S.A.S. DI DE NADAI ROBERTO 01749210934 27558 FONTANAFREDDA PN 1.500,00 2EAST ITALY - RETE D'IMPRESE 01804560934 46815 VALVASONE ARZENE PN 1.500,00 2MM DI MURARO MIRKO 02706730302 36552 RONCHIS UD 1.500,00 3AT S.N.C. DI TRIA ANGELO, ANDREA E CARLO 02480870308 21635 LATISANA UD 1.800,00 3F FAMILY S.R.L. 02908780303 20456 PAULARO UD 1.500,00 4 AMICI SRLS 02986730303 18892 CAMPOFORMIDO UD 1.500,00 4L S.R.L. 01014310302 33793 UDINE UD 900,00 4LG S.R.L. 02455870309 30666 CODROIPO UD 900,00 4T DI STEFANO MICOR E ALICE BELLIA S.N.C. 01253710329 36201 TRIESTE TS 1.500,00 5 STARS TRAVEL DI RUSTIA MITJA 00916220320 24535 TRIESTE TS 4.800,00 54210 S.R.L. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

Comune Di Palazzolo Dello Stella Provincia Di Udine
Nr. 058 - ORIGINALE COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA PROVINCIA DI UDINE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO : : Associazione Intercomunale Riviera Turistica Friulana – Convenzione quadro – modifica art. 2). L’anno duemilaundici , il giorno ventinove , del mese di novembre , alle ore 20,30’, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri - Tecnico: Il Responsabile del Servizio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. dott.ssa Luisa CANTARUTTI Seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione. Fatto l’appello nominale risultano : CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 13. RIVA Marco 1. BORDIN Mauro 14. TISIOT Giovanni 2. ROMANO Manuela 15. MIOTTO Valentina 3. ZORODDU Simone Francesco 16. SCARPOLINI Marziano 4. D’ALTILIA Franco 17. DOMENIGHINI Vigilio 5. PIZZALI Marina 6. CAODURO Michele 7. ZAGO Benito 8. PITTON Antonia 9. BINI Luciana 10. TOLLON Mauro 11. ROSSO Alessandro 12. BIASIOLI Enrico Totale Nr. 15 2 Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa CANTARUTTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Mauro BORDIN nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE : OGGETTO: Associazione Intercomunale Riviera Turistica Friulana – Convenzione quadro – modifica art. 2). IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 13.07.2007 avente ad oggetto l’approvazione della Convenzione quadro dell’Associazione Intercomunale Riviera Turistica Friulana tra i Comuni di Lignano Sabbiadoro, Carlino, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis e Teor, stipulata il 15/03/2007 tra i medesimi Comuni. -
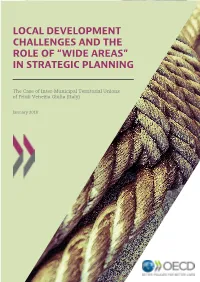
Local Development Challenges and the Role of “Wide Areas” in Strategic Planning
LOCAL DEVELOPMENT CHALLENGES AND THE ROLE OF “WIDE AREAS” IN STRATEGIC PLANNING The Case of Inter-Municipal Territorial Unions of Friuli Venezia Giulia (Italy) January 2018 2 │ OECD Working Papers should not be reported as representing the official views of the OECD or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the authors. Working Papers describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on which the OECD works. Comments on Working Papers are welcomed, and may be sent to CFE Directorate, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Cover image: Designed by welcomia / Freepik © OECD 2018 You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to [email protected]. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at [email protected] or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) [email protected]. -

Posti Disponibili Cacciatori Presenti Posti Liberi Eccedenti Parco Regionale O Riserve Naturali
Elenco posti nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia al 25/02/2021 Riserve interessate da Riserve di caccia - Gorizia posti disponibili cacciatori presenti posti liberi eccedenti parco regionale o riserve naturali BOSCHINI - PETEANO 12 14 0 2 BRAZZANO 11 11 0 0 CAPRIVA DEL FRIULI 9 9 0 0 CORMONS 39 38 1 0 CORONA 7 7 0 0 DOBERDO' DEL LAGO 14 14 0 0 * DOLEGNA DEL COLLIO 13 13 0 0 FARRA D'ISONZO 23 23 0 0 FOGLIANO 10 9 1 0 GABRIA 8 9 0 1 GIASBANA 8 8 0 0 GRADISCA D'ISONZO 10 9 1 0 GRADO 80 79 1 0 * JAMIANO 13 13 0 0 * LUCINICO 22 22 0 0 MARIANO DEL FRIULI 13 13 0 0 MEDEA 15 15 0 0 MERNICO 10 10 0 0 MONFALCONE 13 11 2 0 * MORARO 8 7 1 0 MOSSA 11 13 0 2 PIEDIMONTE 9 9 0 0 PIERIS - BEGLIANO - ISOLA MOROSINI 19 14 5 0 * PIUMA 11 11 0 0 PLESSIVA 10 10 0 0 ROMANS 1° 13 13 0 0 RONCHI DEI LEGIONARI 16 14 2 0 * RUTTARS 11 9 2 0 SAGRADO - SAN MARTINO 14 14 0 0 SAN CANZIAN D'ISONZO 14 8 6 0 * SAN FLORIANO DEL COLLIO 14 16 0 2 SAN LORENZO ISONTINO 9 9 0 0 SAN MAURO - SALCANO 8 9 0 1 SAN MICHELE DEL CARSO 10 9 1 0 SAN PIER D'ISONZO 14 11 3 0 SAVOGNA - RUBBIA 13 13 0 0 SPESSA 8 9 0 1 STARANZANO 14 14 0 0 * TURRIACO 7 7 0 0 * VALLONE 16 15 1 0 * VERSA 9 10 0 1 VILLESSE 19 19 0 0 TOTALE 607 590 27 10 Riserve interessate da Riserve di caccia - Pordenone posti disponibili cacciatori presenti posti liberi eccedenti parco regionale o riserve naturali ANDREIS 11 12 0 1 * ARBA 40 40 0 0 ARZENE 15 17 0 2 AVIANO 176 176 0 0 AZZANO DECIMO 76 76 0 0 BARCIS 50 49 1 0 * BRUGNERA 31 28 3 0 BUDOIA 54 54 0 0 CANEVA 63 75 0 12 CASARSA DELLA DELIZIA 25 25 0 0 -

Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia Lista num. : 1 ALTER.SOC.MUSSOLINI Nominativo Data Nascita Luogo Nascita 1 ZUCCHINI VALENTINO 04/01/1953 BRESCIA C 2 LANZARA ALFONSO 16/12/1953 NOCERA INFERIORE (SA) C 3 SERVADEI MAURIZIO 28/05/1959 TRIESTE 4BUBBA LUIGI 10/10/1944 CARAFFA DI CATANZARO 5 SCARPA CLAUDIO 17/03/1951 TRIESTE 6 STIMAMIGLIO GIAMPAOLO 26/11/1954 PADOVA 7 NORBEDO DINO 09/09/1958 TRIESTE Lista num. : 2 ALLEANZA NAZIONALE Nominativo Data Nascita Luogo Nascita 1 COLLINO GIOVANNI 15/06/1954 PONTEBBA (UD) E 2LIPPI PARIS 14/08/1957 CAIVANO (NA) 3 MARIN ROBERTO 09/06/1965 TRIESTE 4 BRANDI IN LOCCHI ANGELA 19/02/1957 BARI 5 GRANDI ARNALDO 06/12/1939 MARMIROLO (MN) 6 CARLANTONI RENATO 25/04/1964 VILLACO (AUSTRIA) 7 IACONO ANNA 30/01/1947 TARQUINIA (VT) Lista num. : 3 FORZA ITALIA Nominativo Data Nascita Luogo Nascita 1 ANTONIONE ROBERTO 15/06/1953 NOVARA E 2 CAMBER GIULIO 09/11/1953 TRIESTE E 3 ASQUINI ROBERTO 07/09/1964 UDINE 4 PEDICINI ANTONIO 14/01/1954 ARIANO IRPINO (AV) 5 VALENTI GAETANO 23/12/1946 PARENZO (PL) 6 GALASSO DANIELE 03/06/1955 RONCHIS (UD) 7 BACCO IN BARUZZO MARIA LUISA 21/11/1946 FOSSO' (VE) E = eletto; C = candidato anche in altre regioni martedì 11 aprile 2006 Pagina 1 di 5 Lista num. : 4 FIAMMA TRICOLORE Nominativo Data Nascita Luogo Nascita 1COSMA SERGIO 01/01/1943 MATERA 2 ARILOTTA VINCENZO 19/01/1946 MESSINA 3 LESA LUCIO 13/10/1960 UDINE 4 PEZZETTA LUIGI 30/06/1952 UDINE 5 ROSCIOLI ORESTE 27/02/1938 LAPEDONA (AP) 6 SAVORGNANI PIERGIORGIO 21/12/1936 UDINE Lista num. -

(D) of Regulation
C 202/32 EN Offi cial Jour nal of the European Union 16.6.2020 Publication of the single document referred to in Article 94(1)(d) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council and of the reference to the publication of the product specification for a name in the wine sector (2020/C 202/06) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 98 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council (1) within two months from the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘FRIULI’/‘FRIULI VENEZIA GIULIA’/‘FURLANIJA’/‘FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA’ PDO-IT-02176 Date of application: 21.7.2016 1. Name to be registered Friuli Friuli Venezia Giulia Furlanija Furlanija Julijska krajina 2. Geographical indication type PDO – Protected Designation of Origin 3. Categories of grapevine products 1. Wine 4. Sparkling wine 4. Description of the wine(s) ‘Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina’- ‘Bianco’ Colour: straw yellow of varying intensity, occasionally with greenish hints; Aroma: floral, fruity, consisting essentially of primary and secondary aromas. Where certain varieties are used, the aromas evolve into tertiary aromas characterised by those varieties; Taste: dry, harmonious; Minimum total alcoholic strength by volume: 10,5 %; Minimum sugar-free extract: 14,0 g/l. Any analytical parameters not shown in the table below comply with the limits laid down in national and EU legislation. General analytical characteristics Maximum total alcoholic strength (in % volume) Minimum actual alcoholic strength (in % volume) Minimum total acidity 4,0 grams per litre expressed as tartaric acid Maximum volatile acidity (in milliequivalents per litre) Maximum total sulphur dioxide (in milligrams per litre) (1) OJ L 347, 20.12.2013, p. -

Ufficio Del Territorio Di UDINE
Ufficio del territorio di UDINE Data: 14/03/2017 Ora: 10.55.18 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.2 del 20/01/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 1 2 Comuni di: AMPEZZO, COMEGLIANS, ENEMONZO, FORNI AVOLTRI, Comuni di: AMARO, ARTA TERME, CAVAZZO CARNICO, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, LAUCO, OVARO, PRATO CERCIVENTO, LIGOSULLO, PALUZZA, PAULARO, SUTRIO, CARNICO, PREONE, RAVASCLETTO, RAVEO, RIGOLATO, SAURIS, TOLMEZZO, TREPPO CARNICO, VERZEGNIS, ZUGLIO SOCCHIEVE, VILLA SANTINA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) ALPE 260,00 260,00 BOSCHI 6000,00 6000,00 BOSCO CEDUO 4000,00 4000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 9500,00 9500,00 FRUTTETO 33500,00 33500,00 GOLENALE IN. 1500,00 1500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 6000,00 6000,00 ORTO 32000,00 32000,00 ORTO VIVAIO FLOREALE 43000,00 PASCOLO 1200,00 1200,00 PASCOLO CESPUGLIATO 500,00 500,00 PRATO 10500,00 10500,00 PRATO ARBORATO 10500,00 10500,00 Pagina: 1 di 10 Ufficio del territorio di UDINE Data: 14/03/2017 Ora: 10.55.18 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.2 del 20/01/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 1 2 Comuni di: AMPEZZO, COMEGLIANS, ENEMONZO, FORNI AVOLTRI, Comuni di: AMARO, ARTA TERME, CAVAZZO CARNICO, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, LAUCO, OVARO, PRATO CERCIVENTO, LIGOSULLO, PALUZZA, PAULARO, SUTRIO, CARNICO, PREONE, RAVASCLETTO, RAVEO, RIGOLATO, SAURIS, TOLMEZZO, TREPPO CARNICO, VERZEGNIS, ZUGLIO SOCCHIEVE, VILLA SANTINA COLTURA Valore Sup. -

Cart. 3 - PROVINCIA DI UDINE - Comuni E Codici Istat N
Cart. 3 - PROVINCIA DI UDINE - Comuni e codici Istat n. 137 Comuni 30040 30071 30094 30050 30088 30022 30125 30073 30081 30029 30076 30112 30067 30054 30107 30005 30059 30136 30117 30089 30047 30033 30041 30121 30003 30035 30042 30110 30133 30025 30002 30084 30132 30093 30021 30131 30092 30012 30124 30051 30043 30061 30113 30066 30006 30137 30116 30065 30013 30052 30053 30126 30007 30086 30108 30087 30019 30034 30028 30127 30099 30090 30036 30045 30122 30095 30063 30078 30103 30068 30102 30111 30032 30037 30118 30060 30031 30106 30057 30091 30026 30039 30072 30129 30085 30058 30080 30083 30109 30009 30016 30079 30030 30055 30074 30048 30027 30101 30062 30010 30104 30015 30011 30128 30024 30114 30070 30105 30044 30135 30096 30020 30130 30001 30115 30075 30077 30008 30119 30017 30098 30097 30023 30123 30064 30134 30100 30069 30018 30120 30038 30082 30004 30046 30056 30049 PROVINCIA DI UDINE Comuni e codici Istat n. 137 Comuni Aiello del Friuli 30001 Lauco 30047 Resiutta 30093 Amaro 30002 Lestizza 30048 Rigolato 30094 Ampezzo 30003 Lignano Sabbiadoro 30049 Rive d'Arcano 30095 Aquileia 30004 Ligosullo 30050 Rivignano 30096 Arta Terme 30005 Lusevera 30051 Ronchis 30097 Artegna 30006 Magnano in Riviera 30052 Ruda 30098 Attimis 30007 Majano 30053 S. Daniele del Friuli 30099 Bagnaria Arsa 30008 Malborghetto-Valbruna 30054 San Giorgio di Nogaro 30100 Basiliano 30009 Manzano 30055 San Giovanni al Natisone 30101 Bertiolo 30010 Marano Lagunare 30056 San Leonardo 30102 Bicinicco 30011 Martignacco 30057 San Pietro al Natisone 30103 Bordano 30012 Mereto -

Archivio Comunale Di Remanzacco
archivio comunale di Remanzacco inventario 0 Guarnerio soc.coop. GENNAIO 2019 Introduzione Questo inventario è il frutto del lavoro di riordino effettuato dagli archivisti della ditta Guarnerio soc.coop. tra l’ottobre del 2017 e l’ottobre dell’anno successivo. L’intervento è stato possibile grazie a un contributo erogato dalla Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia: l’intento di questi finanziamenti è sostenere gli enti nella salvaguardia del proprio patrimonio documentario - storico, culturale - e quindi garantire la custodia e la trasmissione della memoria alle generazioni future. Diciamo “sostenere” gli enti perché la conservazione della propria documentazione è per gli enti pubblici territoriali un obbligo di legge sancito dalla legislazione fin dalle origini dello stato unitario. Poiché per ragioni diverse le carte dell’archivio non sono liberamente accessibili al pubblico (come quasi sempre lo sono i libri di una biblioteca di pubblica lettura, ad esempio), per la loro consultazione serve uno strumento di mediazione che si chiama Inventario . Esso contiene la descrizione delle buste e dei registri (= unità archivistiche) che compongono l’archivio comunale. Attenzione: gli inventari non contengono quasi mai la descrizione dei singoli documenti, carta per carta. Solitamente la profondità della descrizione si ferma alla busta o al registro, o, in alcuni casi, al fascicolo. L’archivio - così come si presenta alla fine del lavoro di riordino, quando può essere “trascritto” nell’inventario - rappresenta l’ente che lo -

P.R.G.C. Paularo
Pedreit LEGENDA: Casera Tamai Casera Costa Di Crignis mt 1363 (rovine) STATO ATTUALE TERRITORIO E 3 E 2 E 2 Partitura fondiaria catastale E 3 E 2 E 2 Edifici Bosco Ravinis E 2 Alvei fluviali E 3 Stavoli Battaia R 8 Ravenchian mt 930 Rii coperti R 5 R 8 Rete viaria esistente Pradis E 3 Siceit Sentieri TV Clapert E 2 G 2b.2 Stavolo Nereledis Limite del piano attuattivo della zona attrezzata industriale Casera Pizzul Alta Maratediis opera di presa mt 1520 E 3 Bosco G 2b.1 R 5 probon Plan Di Fontanis TV Limite area di reperimento prevista dalla L.R. 42/96 - alpi Carniche e ambito Z.P.S. E 3 R 5 "Gruppo del Monte Coglians" (art. 66-68 N.A.) Cuel Moretes Casera Pizzul Bassa Ambiti dei S.I.C. "Monte Dimon e Paularo" (art. 68 N.A.) Chiaradis Sortisella mt 1484 E 3 Limite aria 1 - bosco del Duron (art. 67 N.A.) opera di presa opera di presa R 5 E 1 E 2.1 Bosco sortisella jonio Limite dell'area d'interesse archeologico (art. 64 N.A.) Selva Pissignaris E 2 Casera Paluscian Ronchis Cogliat 4 Confine territoriale comunale E 4 opera di presa mt 1625 chiarandis ZONIZZAZIONE E 2 Chiaulat ZONE OMOGENEE e E 4 E 4 ZONE "B" RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (art. 23 N.A.) Palucis ESTRATTO IN SCALA 2000 R 6 ZONA OMOGENEA "TV" RIO PRABON B0 - Immobili e pertinenze soggette ad interventi di tutela ambientale Cuestauda e conservazione tipologica (art. 25 N.A.) R 5 E 3.1 E 4 B1 - Intensiva di completamento (art. -

Il Friuli Al Voto Ribaltone Tavagnacco, Lirutti Travolge Maiarelli
II Martedì 28 Maggio 2019 Speciale elezioni www.gazzettino.it Il Friuli al(C) votoCed Digital e Servizi | ID: 01018188 | IP ADDRESS: 79.10.176.1 sfoglia.ilgazzettino.it I RISULTATI UDINE Le elezioni amministrative non saranno lo specchio delle po- litiche del 2018 e nemmeno delle europee di domenica, giorno in cui sono stati chiamati al voto an- che i cittadini di numerosi comu- ni, ma il vento che spira a favore della Lega è riuscito a soffiare for- te nei Comuni chiave nell’ex pro- vincia di Udine, quelli più popolo- si. Non mancano, però, le eccezio- ni come Tolmezzo dove il sindaco uscente dem Francesco Brollo ha vinto la sfida contro la candidata del centrodestra Laura D’Orlan- do, sostenuta dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e contro Valter Marcon. L’altro co- mune più popoloso, Tavagnacco, vede sconfitto il sindaco uscente Gianluca Maiarelli con la vittoria dell’ex vicesindaco Moreno Lirut- ti sostenuto dal centrodestra. RIVIGNANO TEOR PARTITA CHIUSA Due cittadine davanti ai cartelloni elettorali domenica A Rivignano Teor (6.403 abi- tanti), l’esito era decisamente più scontato e nella sfida a due tra l’uscente Mario Anzil appoggiato da Lega Salvini e Tutti per Anzil e Francesco Pussini (Per la demo- crazia) Anzil è stato confermato con 2.964 voti, pari al 93,95%. Pussini fermo al 6,05%, ma se chi Il centrodestra fa corre vince e chi non corre non vince, comunque la soddisfazio- ne per il risultato c’è. «È una fidu- cia che però ora c’impegna a non deludere i cittadini» ha affermato Anzil che ha le idee ben chiare sull’inizio del percorso, ovvero il recupero di Villa Ottelio Savor- il pieno di sindaci gnan, «che può essere un volano di sviluppo per l’economia di tut- to il territorio».