Annali 35/2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Two Cryptic Species of Lotus (Fabaceae) from the Iberian Peninsula 21-45 Wulfenia 27 (2020): 21– 45 Mitteilungen Des Kärntner Botanikzentrums Klagenfurt
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wulfenia Jahr/Year: 2020 Band/Volume: 27 Autor(en)/Author(s): Kramina Tatiana E., Samigullin Tahir H., Meschersky Ilya G. Artikel/Article: Two cryptic species of Lotus (Fabaceae) from the Iberian Peninsula 21-45 Wulfenia 27 (2020): 21– 45 Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums Klagenfurt Two cryptic species of Lotus (Fabaceae) from the Iberian Peninsula Tatiana E. Kramina, Tahir H. Samigullin & Ilya G. Meschersky Summary: The problem of cryptic species is well known in taxonomy of different groups of organisms, including plants, and their recognition can contribute to the assessment of global biodiversity and the development of conservation methods. Analyses of Lotus glareosus and related taxa from the Iberian Peninsula based on various types of data (i.e. sequences of nuclear ribosomal ITS-1-2, 5’ETS and cpDNA trnL-F, seven loci of nuclear microsatellites) revealed that the material earlier determined as ‘L. glareosus’ is subdivided into two genetically distant groups: L. carpetanus, related to L. conimbricensis, and L. glareosus, included in the L. corniculatus complex. Though only slight morphological distinctions were found between them, significant genetic differences comparable to those between sections of the genus Lotus (p-distance 0.07– 0.08 in ITS, 0.060 – 0.067 in ETS and 0.010 – 0.013 in trnL-F; substitution number 43 – 47 bp in ITS, 22–24 bp in ETS and 12–14 bp in trnL-F) and no evidence of genetic exchange suggest that these groups may represent two deeply diverged lineages that should be treated as two separate species. -
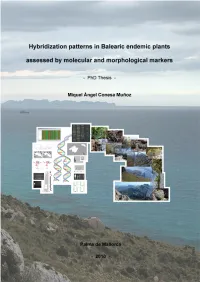
Tmcm1de1.Pdf
Departament de Biologia Facultat de Ciències Hybridization patterns in Balearic endemic plants assessed by molecular and morphological markers — Ph. D. Thesis — Miquel Àngel Conesa Muñoz Supervisors: Dr. Maurici Mus Amézquita (Universitat de les Illes Balears) Dr. Josep Antoni Rosselló Picornell (Universitat de València) May 2010 Palma de Mallorca El doctor Maurici Mus Amézquita, professor titular de la Universitat de les Illes Balears, i el doctor Josep Antoni Rosselló Picornell, professor titular de la Universitat de València, CERTIFIQUEN: Que D. Miquel Àngel Conesa Muñoz ha realitzat, baix la seva direcció en el Laboratori de Botànica de la Universitat de les Illes Balears i en el Departament de Botànica del Jardí Botànic de la Universitat de València, el treball per optar al grau de Doctor en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, amb el títol: “HYBRIDIZATION PATTERNS IN BALEARIC ENDEMIC PLANTS ASSESSED BY MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL MARKERS” Considerant finalitzada la present memòria, autoritzem la seva presentació amb la finalitat de ser jutjada pel tribunal corresponent. I per tal que així consti, signem el present certificat a Palma de Mallorca, a 27 de maig de 2010. Dr. Maurici Mus Dr. Josep A. Rosselló 1 2 A la meva família, als meus pares. 3 4 Agraïments - Acknowledgements En la vida tot arriba. A moments semblava que no seria així, però aquesta tesi també s’ha acabat. Per arribar avui a escriure aquestes línies, moltes persones han patit amb mi, per mi, o m’han aportat el seu coneixement i part del seu temps. Així doncs, merescut és que els recordi aquí. Segurament deixaré algú, que recordaré quan ja sigui massa tard per incloure’l. -

Flora Mediterranea 26
FLORA MEDITERRANEA 26 Published under the auspices of OPTIMA by the Herbarium Mediterraneum Panormitanum Palermo – 2016 FLORA MEDITERRANEA Edited on behalf of the International Foundation pro Herbario Mediterraneo by Francesco M. Raimondo, Werner Greuter & Gianniantonio Domina Editorial board G. Domina (Palermo), F. Garbari (Pisa), W. Greuter (Berlin), S. L. Jury (Reading), G. Kamari (Patras), P. Mazzola (Palermo), S. Pignatti (Roma), F. M. Raimondo (Palermo), C. Salmeri (Palermo), B. Valdés (Sevilla), G. Venturella (Palermo). Advisory Committee P. V. Arrigoni (Firenze) P. Küpfer (Neuchatel) H. M. Burdet (Genève) J. Mathez (Montpellier) A. Carapezza (Palermo) G. Moggi (Firenze) C. D. K. Cook (Zurich) E. Nardi (Firenze) R. Courtecuisse (Lille) P. L. Nimis (Trieste) V. Demoulin (Liège) D. Phitos (Patras) F. Ehrendorfer (Wien) L. Poldini (Trieste) M. Erben (Munchen) R. M. Ros Espín (Murcia) G. Giaccone (Catania) A. Strid (Copenhagen) V. H. Heywood (Reading) B. Zimmer (Berlin) Editorial Office Editorial assistance: A. M. Mannino Editorial secretariat: V. Spadaro & P. Campisi Layout & Tecnical editing: E. Di Gristina & F. La Sorte Design: V. Magro & L. C. Raimondo Redazione di "Flora Mediterranea" Herbarium Mediterraneum Panormitanum, Università di Palermo Via Lincoln, 2 I-90133 Palermo, Italy [email protected] Printed by Luxograph s.r.l., Piazza Bartolomeo da Messina, 2/E - Palermo Registration at Tribunale di Palermo, no. 27 of 12 July 1991 ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 online DOI: 10.7320/FlMedit26.001 Copyright © by International Foundation pro Herbario Mediterraneo, Palermo Contents V. Hugonnot & L. Chavoutier: A modern record of one of the rarest European mosses, Ptychomitrium incurvum (Ptychomitriaceae), in Eastern Pyrenees, France . 5 P. Chène, M. -

Конспект Родини Fabaceae У Флорі України. II. Підродина Faboideae (Триби Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae) Микола М
Систематика, флористика, географія рослин Plant Taxonomy, Geography and Floristics https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.305 Конспект родини Fabaceae у флорі України. II. Підродина Faboideae (триби Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae) Микола М. ФЕДОРОНЧУК, Сергій Л. МОСЯКІН Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна Fedoronchuk M.M., Mosyakin S.L. A synopsis of the family Fabaceae in the flora of Ukraine. II. Subfamily Faboideae (tribes Galegeae, Hedysareae, Loteae, and Cicereae). Ukr. Bot. J., 2018, 75(4): 305–321. M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine 2 Tereshchenkivska Str., Kyiv 01004, Ukraine Abstract. The article provides a synopsis of tribes Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae of Fabaceae subfam. Faboideae in the flora of Ukraine, with nomenclatural citations, types, and main synonyms. It is based on critical analysis of available data of taxonomic, morphological, and molecular phylogenetic studies. Tribe Galegeae is best represented in the flora of Ukraine, comprising 10 genera, including the most species-rich genus Astragalus (48 species). However, the number of genera in the tribe will be probably changed due to further results of morphological and molecular phylogenetic studies which already indicate possible inclusion of Calophaca and Halimodendron in Caragana s. l.; however, these data require confirmation. Tribe Loteae is accepted here in a wide circumscription, including Coronilleae, which is in accordance with results of new morphological and molecular studies. There are 9 genera (or 7, in a wider circumscription) in the tribe, but the number of natural genera in that group will be clarified after further studies. -

Taxonomic and Phylogenetic Relationships Between Old World
© Landesmuseum für Kärnten; download www.landesmuseum.ktn.gv.at/wulfenia; www.biologiezentrum.at Wulfenia 10 (2003): 15–50 Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums Klagenfurt Taxonomic and phylogenetic relationships between Old World and New World members of the tribe Loteae (Leguminosae): new insights from molecular and morphological data, with special emphasis on Ornithopus Galina V. Degtjareva, Carmen M. Valiejo-Roman, Tatiana E. Kramina, Evgeny M. Mironov, Tahir H. Samigullin & Dmitry D. Sokoloff Summary: The tribe Loteae s.l. (incl. Coronilleae) comprises about 275 species distributed in Eurasia, Africa, Australia, North and South America. 47 species of Loteae are endemic to the New World, while all others are restricted to the Old World. Main centres of diversity are Mediterranean region and California. The genus Ornithopus has an unusual disjunctive distribution, with one species (O. micranthus) in subtropical regions of Eastern South America and five species in Europe, Mediterranean region, Macaronesia and the Caucasus. We have produced sequences of nuclear ribosomal DNA ITS1-2 region of six Loteae species, and have studied fruit anatomy, pollen morphology and other morphological characters in several members of the tribe, with special emphasis on Ornithopus. Our data confirm that the genus Ornithopus, in its traditional circum- scription, represents a natural, monophyletic group. The ITS data strongly suggest sister group relationships between O. micranthus and Old World species of Ornithopus. We have confirmed results by ALLAN & PORTER (2000) and ALLAN et al. (2003) that Ornithopus tend to group with North American genus Hosackia on trees inferred from analyses of ITS sequences. There is little morphological support for such a grouping. -

Departamento De Biología Vegetal, Escuela Técnica Superior De
CRECIMIENTO FORESTAL EN EL BOSQUE TROPICAL DE MONTAÑA: EFECTOS DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y DE LA MANIPULACIÓN DE NUTRIENTES. Tesis Doctoral Nixon Leonardo Cumbicus Torres 2015 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA E.T.S. I. AGRONÓMICA, AGROALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA-BIOLOGÍA VEGETAL TESIS DOCTORAL CRECIMIENTO FORESTAL EN EL BOSQUE TROPICAL DE MONTAÑA: EFECTOS DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y DE LA MANIPULACIÓN DE NUTRIENTES. Autor: Nixon Leonardo Cumbicus Torres1 Directores: Dr. Marcelino de la Cruz Rot2, Dr. Jürgen Homeir3 1Departamento de Ciencias Naturales. Universidad Técnica Particular de Loja. 2Área de Biodiversidad y Conservación. Departamento de Biología y Geología, ESCET, Universidad Rey Juan Carlos. 3Ecologia de Plantas. Albrecht von Haller. Instituto de ciencias de Plantas. Georg August University de Göttingen. Madrid, 2015. I Marcelino de la Cruz Rot, Profesor Titular de Área de Biodiversidad y Conservación. Departamento de Biología y Geología, ESCET, Universidad Rey Juan Carlos y Jürgen Homeir, Profesor de Ecologia de Plantas. Albrecht von Haller. Instituto de ciencias de las Plantas. Georg August Universidad de Göttingen CERTIFICAN: Que los trabajos de investigación desarrollados en la memoria de tesis doctoral: “Crecimiento forestal en el bosque tropical de montaña: Efectos de la diversidad florística y de la manipulación de nutrientes.”, han sido realizados bajo su dirección y autorizan que sea presentada para su defensa por Nixon Leonardo Cumbicus Torres ante el Tribunal que en su día se consigne, para aspirar al Grado de Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. VºBº Director Tesis VºBº Director de Tesis Dr. Marcelino de la Cruz Rot Dr. Jürgen Homeir II III Tribunal nombrado por el Mgfco. -

Informatore Botanico Italiano N. 41 (1), 2009
INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, 42 (2) 509-535, 2010 509 NOTULAE ALLA CHECKLIST DELLA FLORA VASCOLARE ITALIANA 10 (1682 - 1750) NOTULAE: 1682-1683 CONTI F., ABBATE G., ALESSANDRINI A., BLASI C. (Eds.), 2005 – An annotated checklist of the Italian vascular flora. Palombi Editori, Roma. Ricevute il 4 febbraio 2010 PARLATORE F., 1848 – Flora Italiana 1. Firenze. Accettate l’8 marzo 2010 C. GANGALE e D. UZUNOV. Museo di Storia NOTULA: 1684 Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria, 87036 Arcavacata di Rende (Cosen- za); [email protected]. Ricevuta il 4 febbraio 2010 Accettata l’8 marzo 2010 D. UZUNOV e C. GANGALE. Museo di Storia 1682. Crypsis alopecuroides (Piller & Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università Mitterp.) Schrad. (Poaceae) della Calabria, 87036 Arcavacata di Rende (Cosen- za); [email protected]. + CAL: Rive del Lago Cecita, presso loc. Vaccarizzo, Sila Grande (Cosenza) (UTM: 33S 630.4359), suoli umidi e sabbiosi soggetti a periodi- ca sommersione, 1135 m, 10 Sep 2009, C. Gangale 1684. Buglossoides calabra (Ten.) I. M. et D. Uzunov (FI). – Conferma per la flora della Johnst. (Boraginaceae) Calabria. La specie, citata genericamente per la regione + CAM: località Vallepiana, Casaletto da PARLATORE (1848), non è riportata per la Calabria Spartano (Salerno) (UTM: 33T 559.4440), su rocce da CONTI et al. (2005). Si rinviene nei pratelli effi- calcaree, al margine del bosco, 1077 m, 7 Mai 2009, meri delle rive lacustri su substrato ciottoloso e sullo D. Uzunov (FI). – Specie nuova per la Campania. sfatticcio granitico, associata a Digitaria sanguinalis La specie è stata rinvenuta nelle radure di una (L.) Scop. -

New Xenophytes from La Palma (Canary Islands, Spain), with Emphasis on Naturalized and (Potentially) Invasive Species – Part 3 R
Collectanea Botanica 39: e002 enero-diciembre 2020 ISSN-L: 0010-0730 https://doi.org/10.3989/collectbot.2020.v39.002 New xenophytes from La Palma (Canary Islands, Spain), with emphasis on naturalized and (potentially) invasive species – Part 3 R. OTTO1 & F. VERLOOVE2 1 Lindenstraße, 2, D-96163 Gundelsheim, Germany 2 Botanic Garden Meise, Nieuwelaan, 38, B-1860 Meise, Belgium ORCID iD. R. OTTO: https://orcid.org/0000-0002-2498-7677, F. VERLOOVE: https://orcid.org/0000-0003-4144-2422 Author for correspondence: R. Otto ([email protected]) Editor: N. Ibáñez Received 22 February 2019; accepted 12 September 2019; published on line 14 April 2020 Abstract NEW XENOPHYTES FROM LA PALMA (CANARY ISLANDS, SPAIN), WITH EMPHASIS ON NATURALIZED AND (POTENTIALLY) INVASIVE SPE- CIES. PART 3.— Several months of field work in La Palma (western Canary Islands) yielded a number of interesting new records of non-native vascular plants. Alstroemeria aurea, A. ligtu, Anacyclus radiatus subsp. radiatus, Chenopodium album subsp. borbasii, Cotyledon orbiculata, Cucurbita ficifolia, Cynodon nlemfuensis, Datura stramonium subsp. tatula, Digitaria ciliaris var. rhachiseta, D. ischaemum, Diplotaxis tenuifolia, Egeria densa, Eugenia uniflora, Galinsoga quadri- radiata, Glebionis segetum, Kalanchoe laetivirens, Lemna minuta, Ligustrum lucidum, Lotus broussonetii, Oenothera fal- lax, Paspalum notatum, Passiflora caerulea, P. manicata × tarminiana, P. tarminiana, Pelargonium capitatum, Phaseolus lunatus, Portulaca trituberculata, Pyracantha angustifolia, Sedum mexicanum, Trifolium lappaceum, Urochloa mutica, U. subquadripara and Volutaria tubuliflora are naturalized or (potentially) invasive xenophytes or of special floristic in- terest, reported for the first time from either theCanary Islands or La Palma. Three additional, presumably ephemeral taxa are reported for the first time from the Canary Islands, whereas seven ephemeral taxa are new for La Palma. -

Vascular Flora of Eight Water Reservoir Areas in Southern Italy
11 2 1593 the journal of biodiversity data February 2015 Check List LISTS OF SPECIES Check List 11(2): 1593, February 2015 doi: http://dx.doi.org/10.15560/11.2.1593 ISSN 1809-127X © 2015 Check List and Authors Vascular flora of eight water reservoir areas in southern Italy Antonio Croce Second University of Naples, Department of Environmental Biological and Pharmaceutical Sciences and Technologies, Via Vivaldi, 43, 8100 Caserta, Italy E-mail: [email protected] Abstract: Artificial lakes play an important role in Although many authors have reported the negative maintaining the valuable biodiversity linked to water impact of dams on rivers and their ecosystems (e.g., bodies and related habitats. The vascular plant diversity McAllister et al. 2001; Nilsson et al. 2005), dams are of eight reservoirs and surrounding areas in southern very important for wildlife, such as birds (Mancuso Italy was inventoried and further analysed in terms of 2010). Artificial lakes fulfill an important role as water biodiversity. A total of 730 specific and subspecific taxa reservoirs for agricultural irrigation; however, their were recorded, with 179 taxa in the poorest area and 303 other functions, such as recreation, fishing, and bio- in the richest one. The results indicate a good richness diversity conservation, should not be overlooked. The of the habitats surrounding the water basins, with some Italian National Institute for Economic Agriculture species of nature conservation interest and only a few (INEA) launched the project “Azione 7” (Romano and alien species. Costantini 2010) to assess the suitability of reservoirs in southern Italy for nature conservation purposes. -
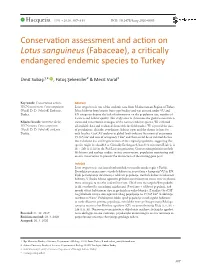
A Critically Endangered Endemic Species to Turkey
19/1 • 2020, 307–315 DOI: 10.2478/hacq-2020-0003 Conservation assessment and action on Lotus sanguineus (Fabaceae), a critically endangered endemic species to Turkey Ümit Subaşı1,*, Fatoş Şekerciler2 & Mecit Vural3 Key words: Conservation action, Abstract IUCN assessment, Lotus sanguineus Lotus sanguineus is one of the endemic taxa from Mediterranean Region of Turkey. (Vural) D. D. Sokoloff, Endemic, It has hitherto been known from type locality and was assessed under VU and Turkey. EN categories despite the lack of information on the population size, number of location and habitat quality. This study aims to determine the global conservation Ključne besede: varstvene akcije, status and conservation strategies of the narrow endemic species. We collected IUCN ocena, Lotus sanguineus all available data and evaluated them with the field studies. We reported the sizes (Vural) D. D. Sokoloff, endemit, of populations, altitude, coordinates, habitat types and the threats it faces for Turčija. each locality. GeoCAT analyses at global levels indicate the extent of occurrence 19.965 km2 and area of occupancy 9 km2 and there could be an inferred decline due to habitat loss and fragmentation of the original population, suggesting this species might be classified as Critically Endangered, based on criterium B1ab (i, ii, iii) + 2ab (i, ii, iii) in the Red List categorization. Conservation priorities include life history and ecology studies, in-situ conservation, population monitoring and ex-situ conservation to prevent the destruction of the existing gene pool. Izvleček Lotus sanguineus je ena izmed endemitskih vrst mediteranske regije v Turčiji. Dosedaj je poznana samo s tipske lokalitete in je uvrščena v kategoriji VU in EN, kljub pomanjkanju informacij o velikosti populacije, številu lokalitet in kakovosti habitata. -
![Index Seminum 2020 [Pdf]](https://docslib.b-cdn.net/cover/4135/index-seminum-2020-pdf-6124135.webp)
Index Seminum 2020 [Pdf]
INDEX SEMINUM 2020 Un particolare ringraziamento per la collaborazione - Associazione di volontariato CITTAVIVA - Trieste - ANTONIO BUSSANI Comune di Trieste Civico Orto Botanico via Carlo de’ Marchesetti, 2 34142 - Trieste (Italia) tel. : +39 040 360 068 e-mail: [email protected] www.ortobotanicotrieste.it Progetto copertina FABIOLA FAIDIGA Foto LOREDANA FLEGO (Nelumbo nucifera Gaertn. 'Osiris') © 2020 Comune di Trieste Tutti i diritti riservati Stampato in Italia presso Centro Stampa Comunale di Trieste Trieste Botanical Garden is IPEN Member and assures the CBD-regulations (Rio1992) ebgconsortiumindexseminum2020 ISSN 1972-800X comune di trieste hortus botanicus tergestinus delectus seminum pro mutua commutatione offert quae anno MMXX CIVICO ORTO BOTANICO DI TRIESTE quote min. 75 - max. 95 m s.l.m. coordinate lat. 45° 39' 11'' N long. 13° 47' 29'' E area 10.000 m2 serre 110 m2 Il Civico Orto Botanico è di proprietà del The Municipal Botanical Garden is owned Comune di Trieste (sotto la direzione dei by Trieste Town Council (and managed by Civici Musei Scientifici). L'organizzazione the City Science Museums). The botanical dell'Orto segue criteri sistematici e garden is arranged systematically and comprende diverse sezioni. includes various sections. E’ associata una riserva naturale formata The area also includes a nature reserve dal Bosco Biasoletto e Bosco Farneto (tot. made up of Biasoletto and Farneto Woods 90 ha). (total area: 90 ha). Verranno sempre inviati i semi di più Only the most recently gathered seeds are recente raccolta. Qualora questi fossero delivered. If we are out of stock, seeds esauriti saranno sostituiti con quelli degli collected in previous years will be used anni precedenti. -

Lotus Newsletter, 2005, Volume 35, Number 1
ISSN 1510-7809 LOTUS NEWSLETTER 2007 Volume 37, Number 2 Editor: M. Rebuffo INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA Editor: M. Rebuffo INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA Editorial Office INIA La Estanzuela This Newsletter consists of informal Colonia, Uruguay reports which are presented to further Phone: +598-574-8000 the exchange of ideas and information Email: [email protected] between research workers. Fax No.: +598-574-8012 Consequently the data presented here Web: http://www.inia.org.uy/sitios/lnl/ are not to be used in publications without the consent of the authors. Images are copyright of the authors, and their reproduction is strictly prohibited without their consent. Front cover: Juan Ramón Acebes Ginovés and Felicia Oliva Tejera spoke about the endemic Lotus species of the Canary Islands (pp. 14-15) at the Workshop: Lotus as a model legume and a sustainable alternative for marginal land reclamation (Botanic Garden of the University of Valencia, Spain, September 6-7 2007). The photograph on the front cover shows flowers of Lotus berthelotii, one of the species from the Canary Islands. The picture was recorded at the Jardin Mundani, Mallorca, Islas Baleares, Spain, and authorized by its publication at Lotus Newsletter 37(2) by Juan Bibiloni Pou. The opinions in this publication are those of the authors and not necessarily those of the Lotus Newsletter. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Newsletter concerning the legal status of any country, territory, city, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.