[Scambi Di Idee in Materia - [email protected]]
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Lost Book of Enki.Pdf
L0ST BOOK °f6NK1 ZECHARIA SITCHIN author of The 12th Planet • . FICTION/MYTHOLOGY $24.00 TH6 LOST BOOK OF 6NK! Will the past become our future? Is humankind destined to repeat the events that occurred on another planet, far away from Earth? Zecharia Sitchin’s bestselling series, The Earth Chronicles, provided humanity’s side of the story—as recorded on ancient clay tablets and other Sumerian artifacts—concerning our origins at the hands of the Anunnaki, “those who from heaven to earth came.” In The Lost Book of Enki, we can view this saga from a dif- ferent perspective through this richly con- ceived autobiographical account of Lord Enki, an Anunnaki god, who tells the story of these extraterrestrials’ arrival on Earth from the 12th planet, Nibiru. The object of their colonization: gold to replenish the dying atmosphere of their home planet. Finding this precious metal results in the Anunnaki creation of homo sapiens—the human race—to mine this important resource. In his previous works, Sitchin com- piled the complete story of the Anunnaki ’s impact on human civilization in peacetime and in war from the frag- ments scattered throughout Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Hittite, Egyptian, Canaanite, and Hebrew sources- —the “myths” of all ancient peoples in the old world as well as the new. Missing from these accounts, however, was the perspective of the Anunnaki themselves What was life like on their own planet? What motives propelled them to settle on Earth—and what drove them from their new home? Convinced of the existence of a now lost book that formed the basis of THE lost book of ENKI MFMOHCS XND PKjOPHeCieS OF XN eXTfCXUfCWJTWXL COD 2.6CHXPJA SITCHIN Bear & Company Rochester, Vermont — Bear & Company One Park Street Rochester, Vermont 05767 www.InnerTraditions.com Copyright © 2002 by Zecharia Sitchin All rights reserved. -

Mesopotamian Culture
MESOPOTAMIAN CULTURE WORK DONE BY MANUEL D. N. 1ºA MESOPOTAMIAN GODS The Sumerians practiced a polytheistic religion , with anthropomorphic monotheistic and some gods representing forces or presences in the world , as he would later Greek civilization. In their beliefs state that the gods originally created humans so that they serve them servants , but when they were released too , because they thought they could become dominated by their large number . Many stories in Sumerian religion appear homologous to stories in other religions of the Middle East. For example , the biblical account of the creation of man , the culture of The Elamites , and the narrative of the flood and Noah's ark closely resembles the Assyrian stories. The Sumerian gods have distinctly similar representations in Akkadian , Canaanite religions and other cultures . Some of the stories and deities have their Greek parallels , such as the descent of Inanna to the underworld ( Irkalla ) resembles the story of Persephone. COSMOGONY Cosmogony Cosmology sumeria. The universe first appeared when Nammu , formless abyss was opened itself and in an act of self- procreation gave birth to An ( Anu ) ( sky god ) and Ki ( goddess of the Earth ), commonly referred to as Ninhursag . Binding of Anu (An) and Ki produced Enlil , Mr. Wind , who eventually became the leader of the gods. Then Enlil was banished from Dilmun (the home of the gods) because of the violation of Ninlil , of which he had a son , Sin ( moon god ) , also known as Nanna . No Ningal and gave birth to Inanna ( goddess of love and war ) and Utu or Shamash ( the sun god ) . -

Zecharia-Sitchin-The-Lost-Book-Of-Enki
1 !"# $%& ' ( ) ! * 2 Zecharia Sitchin Sumerian Cuneiform - Clay Tbalet ! "& $% "# . (8 * +7 + ). 562 14 (* 3 ! "& /2 * (0* + .(/ + , - + ()* . "+ * * + > = <+ * "# +7 ") + + * (* + & ;7 (9: ! "#8* 3 ") + + * (* + "& * @ A(. * @ + + ?#& <F D !! D &+ 2 3 "# E D > ( (8. (* C(. B=* * " > 2+ @ & 2 2 > #): I/ (* H G27 + + + * * #& D > $% . 2 < ( J(? I/ <+ *+ + : A(. 3 (8. E2 . 2 < OA : (I N# D LM * .(C & /7 * 2 * &+ .+ + * ... » . <# ( + 2 + S* <R 3+ Q( + (. >(*+ < / / L2 2 2+ P 3 < /7 > 2 (* L27 & 6: ()* L2: (: H 2 * * > T 2 < * (: , "H 2 + &C 2 * & M +7 @ * L@ V+ U 4 8 U L#: 2 # + <+ * * , +W& 3 + + 7 8W. L@ + + .+ <+ * + 2 & /7 . # 2 @ 7 Z 4 # ( * @( T 2 * , F (/ Y7 &C & /7 + LX N . " < +7 @ * N "& M #* [4 - T (04 . + < ,* D(1 4 * @( E@ T > C [?H 7 « . UE: .... "UF # Julian jaynes : 2 The origin consciousness in the breakdown mind $2 * + )2 < @(: 2 & H7 Q : « 3 &` (. + _ & /7 ^ )#» #F 6: ; . < ( ()# + 7 2 ()2 G ( U/ J 4 ( a ?> 2 + G H7 . " * $# $* L f2 <(W@ + 2 W U: (/W e + 1990 , + G ( * @ .(/ + C NYU + 1993 , + * H= . D * < ( H= # : D (: < /7 (. (& . " ( 2(#i 2 * + 2 h. + + (& # O(): + 2(* L27 * @ <+ ? #)2 * A + <W7 G (j2 + (/ * a *( 7 LH : . ( > Q : Biogenetic W+ 2(* , 3600 . <7 * <+ + U 8: *(E: + & N2 . G .(/ * < : + (j2 2 (.( 8 < 4 1920 , + G ( + N#(.7 <#& : (12 + Nephilim . 2 < +7 @ * <( + + 2 R2 2 * + 2 h. ( + @ <+ & <+ j# + # J(? + 4 . 2 * * ( f#&(. ( ( 2 # (> >(* Q : (j2 <+ + >(* (/ . 2 2 Tiamat + 7 + >(* N , U 4/5 + < (/ $8 (j2 . @ 4 (0 h* (* 4 < .(/ 4 + j# + e: <+ e . S: (/ $8 (j2 : G& / : * * i @ Immanuel Velikovsky's "H & 2 + >(* 2 / <(& * . (*+ 2 1) * UF $. 6 <+ ? + + j# 6: 2 0# 2 & /7 <2 : 2 * L2 2 ( + G + 2 < p(. -

Royal Inscriptions. Text
UR EXCAVATIONS ROYAL INSCRIPTIONS PUBLICATIONS OF THE JOINT EXPEDITION OF THE BRITISH MUSEUM AND OF THE MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF 'PENNSYLVANIA TO MESOPOTAMIA UR EXCAVATIONS TEXTS I ROYAL INSCRIPTIONS By C. J. GADD, M.A., F.S.A., Assistant in the Department of Egyptian and Assyrian Antiquities in the British Museum, and LEON LEGRAIN, D.D., Sc.D., Curator of the Babylonian Section of the Museum of the University of Pennsylvania; with contributions by SIDNEY SMITH, M.A., F.S.A., of the British Museum, and E. R. BURROWS, s.J., M.A. PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE TWO MUSEUMS 1928 SOLD IN ENGLAND AT THE BRITISH MUSEUM AND BY BERNARD QUARITCH ii Grafton Street, London, W. I THE OXFORD UNIVERSITY PRESS Amen House, London, E.C. 4 KEGAN PAUL & CO. 38 Great Russell Street London, W.C. I PRINTED IN ENGLAND BY HARRISON & SONS LIMITED ST. MARTIN'S LANE, LONDON, W.C. 2 PREFACE HE present volume inaugurates the series of texts emanating from the excavations of the Joint Expedition of the British Museum and of the Museum of the University of Pennsylvania at and in the neighbourhood of Ur, which, as stated in the Preface to the volume on al-'Ubaid (Oxford University Press, 1927), will accompany the series of volumes describing the excavations. This first volume contains the whole of the material of one particular class which has accrued from the excavations of the Joint Expedition in the seasons of 1922-7, together with some acquired by the British Museum alone in the season of 9 9. -

Divine Encounters
CONTENTS 1. The First Encounters 1 2. When Paradise Was Lost 29 3. The Three Who to Heaven Ascended 49 4. The Nefilim: Sex and Demigods 72 5. The Deluge 87 6. The Gates of Heaven 108 7. In Search of Immortality 131 8. Encounters in the GIGUNU 161 9. Visions from the Twilight Zone 185 10. Royal Dreams, Fateful Oracles 212 11. Angels and Other Emissaries 248 12. The Greatest Theophany 284 13. Prophets of an Unseen God 313 Endpaper: God, the Extraterrestrial 347 Index 381 1 THE FIRST ENCOUNTERS Divine Encounters are the ultimate human experience—the maximal, the utmost possible when alive, as when Moses encountered the Lord upon Mount Sinai; and the final, termi- nal, and conclusive, as that of Egyptian Pharaohs who at death assumed an eternal Afterlife by joining the gods in their Divine Abode. The human experience of Divine Encounters as recorded in scriptures and texts from the ancient Near East is a most amazing and fascinating saga. It is a powerful drama that spans Heaven and Earth, involving worship and devotion, eternity and morality on the one hand, and love and sex, jealousy and murder on the other; ascents unto space and journeys to the Netherworld. A stage on which the actors are gods and goddesses, angels and demigods, Earthlings and androids; a drama expressed in prophecies and visions, in dreams and omens and oracles and revelations. It is a story of Man, separated from his Creator, seeking to restore a pri- meval umbilical cord and, by so doing, reach for the stars. -
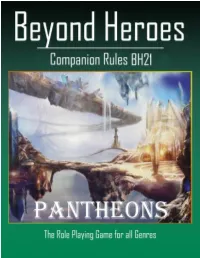
The Beyond Heroes Roleplaying Game Book I: the Player's Guide
1 The Beyond Heroes Roleplaying Game Book XXI: The Book of Pantheons Writing and Design: Marco Ferraro The Book of Pantheons Copyright © 2019 Marco Ferraro. All Rights Reserved This is meant as an amateur free fan production. Absolutely no money is generated from it. Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons, and their logos are trademarks of Wizards of the Coast LLC in the United States and other countries. © 2019 Wizards. All Rights Reserved. Beyond Heroes is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Wizards of the Coast LLC. Contents Foreword 4 Timeline 4 Earth Pantheons 6 Afghani 7 Afrikana 9 Arabian 16 Armenian 23 Australian Aboriginal 24 Aztec 28 Babylonian 34 Baltic 41 Basque 48 British 49 Burmese 50 Cambodian 53 Canaanite 56 Celtic 58 Chinese 68 Egyptian 76 Eskimo 80 Estonian 82 Etruscan 85 Filipino 93 Finnish 105 Gaulish 108 Greek 111 Hindu 116 Hittite 123 Hungarian 125 2 Hurrian 128 Inca 133 Indonesian 135 Irish 139 Islander 144 Japanese 155 Korean 162 Lusitanian 165 Malaysian 174 Maori 178 Mayan 179 Mesopotamian and Sumerian 186 Mongolian 192 Native American 194 Norse 201 Ossetian 207 Phoenician 208 Pop Culture 212 Primordial 215 Roman 221 Sami 233 Scottish 234 Semitic 236 Slavic 237 Syrian 240 Thai 241 Thracian 244 Tibetan 245 Voodun 256 Welsh 265 DC Comics Entities 269 Marvel Comics Entities 275 Dungeons and Dragons 279 Eternal Champion 297 Middle Earth 299 Palladium Fantasy 301 Pathfinder 302 Warhammer Fantasy 302 The Pantheon Creation Guide 304 Spheres for Gods 317 Mana and Deities 320 Creating Cosmic Beings 325 Characters who Ascend 327 Characters who Ascend II 328 List of Cosmic Powers 331 Organizations 338 3 Foreword while countless points of light flare and The Beyond Heroes Role Playing Game die in the interior. -

Ancient Records of Assyria and Babylonia
oi.uchicago.edu ANCIENT RECORDS oi.uchicago.edu ANCIENT RECORDS Under the General Editorship of JAMES HENRY BREASTED FIRST SERIES ANCIENT RECORDS OF ASSYRIA AND BABYLONIA Edited by DANIEL DAVID LUCKENBILL SECOND SERIES ANCIENT RECORDS OF EGYPT Edited by JAMES HENRY BREASTED THIRD SERIES ANCIENT RECORDS OF PALESTINE, PHOENICIA AND SYRIA oi.uchicago.edu '^- 'ZL % ANCIENT RECORDS OF ASSYRIA AND BABYLONIA oi.uchicago.edu THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS CHICAGO, ILLINOIS THE BAKER & TAYLOR COMPANY NEW YORK THE MACMILLAN COMPANY OF CANADA, LIMITED TORONTO THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS LONDON THE MARUZEN-KABUSHIKI-KAISHA TOKYO, OSAKA, KYOTO, FUKUOKA, SENDAI THE COMMERCIAL PRESS, LIMITED SHANGHAI oi.uchicago.edu ANCIENT RECORDS OF ASSYRIA AND BABYLONIA -By DANIEL DAVID L^CKENBILL, PH.D. Professor of the Semitic Languages and Literatures in the University of Chicago VOLUME I HISTORICAL RECORDS OF ASSYRIA FROM THE EARLIEST TIMES TO SARGON 'Pa \s> vb •")- '<& Vp \ ^ <§>• "h % CHICAGO, ILLINOIS \ -& THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRES oi.uchicago.edu ') t L i COPYRIGHT 1926 BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO All Rights Reserved Published November 1926 Composed and Printed By The University oi Chicago Press Chicago, Illinois, U.S.A. 100 oi.uchicago.edu(o^Q EDITOR'S FOREWORD These two volumes, containing a complete English version of the historical records of ancient Assyria, represent the resumption of a long-interrupted plan for the creation of a library of the historical documents of the ancient Near East in English, begun over thirty years ago. The present writer, returning in 1895 from oriental studies in Europe and the Near East, found himself entirely without the tools and instrumentalities for teaching the ancient cultures he was supposed to represent, especially the Egyptian. -

List of Goddess Spirits for MD 3 Charities, 3 Cranes, 3 Erinyes, 3 Moirai, 7 Flowers, Abuk, Abarbarea, Abeguwo, Abeona, Abnoba
List of Goddess Spirits for MD 3 charities, 3 cranes, 3 Erinyes, 3 Moirai, 7 Flowers, Abuk, Abarbarea, Abeguwo, Abeona, Abnoba, Abundantia, Acca Larentia, Aceso, Achadian mythology, Achelois, Achthonian, Aditi, Adrasteia, Adrestia, Adsullata, Advaita, Aecerbot, Aegle, Aequitas, Aeraecura, Aeternitas, Aganippe, Agasaya, Agdistis, Agenoria, agriculture goddesses, Agrona, Aibell, Aide, Ailas, Aimend, Aine, Airmed, Aja, Aja orisha, ajo njo, Ajysyt, Ak Ana, Akka, Akna, Al Basti, al-Lat, al-Manat, Al-Uzza, Ala, Ala Odinani, Alala, Albina, Alcinoe, Ale, Alemonia, AlfrooullAlke, Ali, Alilat, Alke, all ground of earth considered Holy land, All-Goddess, Allat, Allatu, Alor, Alpanu, Alruna, Alt nan Cailleach, Alu Ani, Alusi, Ama-arhus, Amahraspand, Amasagnul, Amathaunta, Ambika, Amaterasu, Amaunet, Amazon feminism, Amazon societies, Amazons, Ameretat, Ame-no-Uzume-no-Mikoto, Amesaspand, Amesha Spenta, Amor, Amordad, Amrtatva, Amurdad, An, Ana, Anahit, Anahita, Anaisa Pye, Ananke, Anann, Anat, Anath, Anaxibia, Ancamna, ancestral deity, Ancharia, Andarta, Andraste, Angel One, Angelos, Angerona, Angeronalia, Angeronia, Angitia, Angra Mainyu, Ani, Anima, Anjea, Anna Jagiellon, Annona, Anput, Antevorta, anti-male, Antevorta, Antu, Anu Irish goddess, Anuket, Anumati, Aoide, Apate, Appias, Apollo, Apollonis, Aphaea, Aphrodite, Apsara, Aradia Gospel of Witches, Arae, Aranyani, archaic local goddesses, archtypal mother in collective unconscious of humans, Arda, Arduenna silva, Arduina, Arduinna, Arduinnae, Arduinne, Argive Horae, Ariadne, Aricia sacred grove, -

From Heaven to Earth They Came by R.H.H. the EPIC CIVIL WAR OF
From Heaven to Earth They Came By R.H.H. THE EPIC CIVIL WAR OF THE ANCIENT SUMERIAN GODS THE ANNUNAKI LOC copyright 1-670580611 Robert H.Householder WGAW 1537014 [email protected] 330-921-5430 FADE IN: WAR EXT. OUTER SPACE - NIGHT CGI Flying past planets, zooming in on a large futuristic planet with war torn skies, suffering, atrocity, death, futuristic weapons in use, red hazed sky with harsh winds. END CGI THRONE ROOM INT. THRONE ROOM - NIGHT Great ornate throne room, Marble floors, Gods palace, the aged King ANU sits on his throne with his three oldest children in front of him; ENKI, ENLIL,and NINHARSAG. ANU I have summoned you here before me. Our people are suffering and though the war upon us is near its end, I fear the suffering of our people is just beginning. The rebels have unleashed the most horrid of the forbidden weapons upon our northern provinces. This time they have gone too far. Even though the rebels are nearly eradicated the damage is already done. ALALU has allowed this weapon to destroy our atmosphere, to the point that it will not mend itself, and soon Nibiru will no longer support life. Yet all is not lost, our scientist have developed a long term solution to save our atmosphere. They have discovered a means to pulverize the element and magnetize it to create a shield around our world. It would seem that there is another world that may contain the element of gold as Nibiru once did. The primitive world Ki(Earth) may be the answer to our prayers. -

THE BABYLONIAN SKY SCIENCE Volume I
THE BABYLONIAN SKY SCIENCE volume I by Rumen Kolev A COLLECTION of writings from 2000 - 2010 THE BABYLONIAN SKY SCIENCE volume I, hard cover, ~300 pages, astral photos, first-time translations from Akkadian + + by Rumen Kolev A COLLECTION of THE BABYLONIAN ASTROLOGY & ASTRONOMY BASIC CONCEPTS- The Heliacal Phases + ALL FOUR VOLUMES OF THE BABYLONIAN SKY OBSERVER + more materials unpublished until now Selected pages from the collection follow next ASTRO-RESEARCH CENTER “ZENITH” www.babylonianastrology.com a THE BABYLONIAN ASTROLOGY & ASTRONOMY BASIC CONCEPTS- The Heliacal Phases by Rumen Kolev Venus in Leo, in her full Glory, close to Morning Elongation Oct 01, 1999 5:26 AM (TZ= 2E) 28E33 / 43N27 Kamen Briag, Bulgaria. On the foreground- the ‘Altar’, a place for observation of an ancient astral cult civilization a CONTENTS a THE BABYLONIAN ASTROLOGY & ASTRONOMY by Rumen Kolev written in a 2000 PRINCIPLES 2 THE SUNRISE & SUNSET PROCESS 4 ARCUS VISIONIS (AV), MAGNITUDE 8 THE HELIACAL CYCLE OF THE STARS, G, H& J 10 DURATION OF SHINING, THE HELIACAL CYCLE OF D& F 16, 18 AVERAGE AV AND BRIGHTNESS IN THE HELIACAL PHASES 26 THE GLOBAL HELIACAL CYCLES OF THE PLANETS 31 THE BABYLONIAN CALENDAR, LUNAR HELIACAL PHASES 41, 42 SAND STORMS, ECLIPSES, SOLSTICES, WINDS 52 ORIENTATION OF TEMPLES, CULTURE, PROGNOSIS METHODS 57, 58 THE COMPUTER PROGRAM BABYLONIA, BIBLIOGRAPHY 60 PICTURE Sirius, Altar MM, Varna FOREWORD Since this book was written in 2000, a lot of new material came into my hands. The section on the Arcus visiones of the planets is according to the Schoch values which give valid results only for Jupiter and Venus. -

Tuesday Bible Class Notes
Tuesday, March 22, 2012 Chapter 10 Gomer (a son of Japheth, grandson of Noah) means completeness. Magog (a son of Japheth, grandson of Noah) was a barbarous northern region. Madai (a son of Japheth, grandson of Noah) was a country of Central Asia, also known as Medes or Media. Javan (a son of Japheth, grandson of Noah) means effervescing (i.e. hot and active) also the name of another individual, and of the race (Ionians i.e. Greeks) descended from him, with their territory, also a place in Arabia. Tubal (a son of Japheth, grandson of Noah) was a postdiluvian patriarch. Meshech (a son of Japheth, grandson of Noah) probably means sowing, also a possession, precious, price. Tiras (a son of Japheth, grandson of Noah) probably means fearful. Ashkenaz (a son of Gomer, grandson of Japheth, great-grandson of Noah) was a Japhethite. Riphath (a son of Gomer, grandson of Japheth, great-grandson of Noah) Togarmah (a son of Gomer, grandson of Japheth, great-grandson of Noah) Elishah (a son of Javan, grandson of Japheth, great-grandson of Noah) Tarshish (a son of Javan, grandson of Japheth, great-grandson of Noah) was the region of the stone or the reverse. Tarshishn was a place on the Mediterranean, hence the epithet of a merchant vessel, also the name of a Persian and an Israelite. Kittim (a son of Javan, grandson of Japheth, great-grandson of Noah) is partial from an unused name denoting Cyprus (only in the plural), a Kittite or Cypriote, hence an islander in general, i.e. the Greeks or Romans on the shores opposite Palestine. -

The Mythology of All Races
Woman’s College Library DUKE UNIVERSITY DURHAM, N. C. Rec’d /% I9S3 i THE MYTHOLOGY OF ALL RACES Volume V SEMITIC Volume I. Greek and Roman William Sheewood Fox, Ph.D., University of Western Ontario. Volume II. Eddie Canon John A. MacCulloch, D.D., Bridge of Allan, Scotland. Volume III. Celtic, Slavic Canon John A. MacCdlloch, D.D., Bridge of Allan, Scotland. Jan Machal, Ph.D., Bohemian University. Volume IV. Finno-Ugric, Siberian Uno Holmbekg, Ph.D., Turku University. Volume V. Semitic Stephen H. Langdon, M.A., B.D., Ph.D., Oxford University. Volume VI. Indian, Iranian A. Berriedale Keith, D.C.L., Edinburgh University. Albert J. Carnoy, Ph.D., University of Louvain. Volume VII. Armenian, African Maedieos Ananikian, B.D., Kennedy School of Missions. Alice Weenee, L.L.A. (St. Andrews), School of Oriental Studies. Volume VIII. Chinese, Japanese John C. Feeguson, Ph.D., Peking, China. Masahaeo Anesaki, Litt.D., University of Tokyo. Volume IX. Oceanic Roland Bueeage Dixon, Ph.D., Harvard University. Volume X. North American Hartley Burr Alexander, Ph.D., Scripps College. Volume XI. American {Latin) Hartley Burr Al.xxander, Ph.D., Scripps College. Volume XII. Egypt, Far East W. Max MOllee, Ph.D., University of Pennsylvania. Sir (James) George Scott, K.C.I.E., London. Volume XIII. iTtdex Louis Herbert Gray, A.M., Ph.D., Columbia University. THE MYTHOLOGY OF ALL RACES IN THIRTEEN VOLUMES CANON JOHN ARNOTT MacCULLOCH, D.D., Editor GEORGE FOOT MOORE, A.M., D.D., LL.D., Consulting Editor SEMITIC BY STEPHEN HERBERT LANGDON, M.A. JESUS COLLEGE, OXFORD FELLOW OF THE BRITISH ACADEMY MARY W.