Un'antica Famiglia Patrizia Di Brissago: I Codonini Genealogia E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Raiders of the Lost Ark
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 12 2020 Full Issue Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation (2020) "Full Issue," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 12. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/12 This Full Issue is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. et al.: Full Issue Swiss A1nerican Historical Society REVIEW Volu1ne 56, No. 1 February 2020 Published by BYU ScholarsArchive, 2020 1 Swiss American Historical Society Review, Vol. 56 [2020], No. 1, Art. 12 SAHS REVIEW Volume 56, Number 1 February 2020 C O N T E N T S I. Articles Ernest Brog: Bringing Swiss Cheese to Star Valley, Wyoming . 1 Alexandra Carlile, Adam Callister, and Quinn Galbraith The History of a Cemetery: An Italian Swiss Cultural Essay . 13 Plinio Martini and translated by Richard Hacken Raiders of the Lost Ark . 21 Dwight Page Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace . 41 Alex Winiger Niklaus Leuenberger: Predating Gandhi in 1653? Concerning the Vindication of the Insurgents in the Swiss Peasant War . 64 Hans Leuenberger Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California . 94 Tony Quinn A History of the Swiss in California . 115 Richard Hacken II. Reports Fifty-Sixth SAHS Annual Meeting Reports . -

22534 Rifiuti 2020 Date
CONSORZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRE DI PEDEMONTE - ONSERNONE - CENTOVALLI www.pedemonte.ch www.onsernone.swiss www.centovalli.swiss [email protected] [email protected] [email protected] 22www.consorziorifiuti-tpoc.ch002020 EP Comune Centovalli Ecocentro Petrucciani T Raccolta ingombranti Terre di Pedemonte Campo Sportivo Verscio O Raccolta carta Valle Onsernone C Raccolta ingombranti Camedo Eco-centro RS Rifiuti speciali P Raccolta ingombranti Palagnedra Piazzale Diga R Raccolta ingombranti Russo Zona Segheria M Raccolta ingombranti Mosogno Zona Eliporto LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ Gennaio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 O Febbraio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 EP O EP Marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T T R R O EP Aprile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M M C P O EP Maggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 O O RS EP Giugno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 O O EP Luglio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 O O EP Agosto -

Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 7 2020 Canton Ticino And The Italian Swiss Immigration To California Tony Quinn Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Quinn, Tony (2020) "Canton Ticino And The Italian Swiss Immigration To California," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 7. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/7 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Quinn: Canton Ticino And The Italian Swiss Immigration To California Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California by Tony Quinn “The southernmost of Switzerland’s twenty-six cantons, the Ticino, may speak Italian, sing Italian, eat Italian, drink Italian and rival any Italian region in scenic beauty—but it isn’t Italy,” so writes author Paul Hofmann1 describing the one Swiss canton where Italian is the required language and the cultural tie is to Italy to the south, not to the rest of Switzerland to the north. Unlike the German and French speaking parts of Switzerland with an identity distinct from Germany and France, Italian Switzerland, which accounts for only five percent of the country, clings strongly to its Italian heritage. But at the same time, the Ticinese2 are fully Swiss, very proud of being part of Switzerland, and with an air of disapproval of Italy’s ever present government crises and its tie to the European Union and the Euro zone, neither of which Ticino has the slightest interest in joining. -

Patriziato Di Intragna, Golino E Verdasio
PATRIZIATO DI INTRAGNA 21.02.2019 Catalogo elettorale valido al 21.02.2019 Nome Paternità Data di nascita Domicilio A Alvarez Calderon Diego A. di Monica A.-1961 09.07.1997 Alvarez Calderon Karina A. di Monica A.-1961 18.10.1993 Amati Monica G. n. Tosetti fu Martha-1910 03.10.1946 Ambrosini Moira T. n. Tonascia di Pietro A.-1935 06.12.1968 Losone Angeloni Annika J. di Paolo-1972 16.10.1996 Golino Angeloni George A. fu Pacifico 04.08.1937 Angeloni Giorgio di Pietro-1951 18.11.1976 Losone Angeloni Julian B. di Paolo-1972 28.12.1999 Golino Angeloni Marina di Pietro-1951 07.08.1984 Golino Angeloni Paolo di Bruno-1948 27.06.1972 Golino Angeloni Pierina C. n. Zurini 12.06.1954 Golino Angeloni Pietro fu Antonio 19.05.1951 Golino Angeloni Veronica B. n. Kollarik 15.01.1940 Avosti Alberto fu Amabile 16.06.1955 Intragna Avosti Amabile fu Amabile 17.05.1957 Ascona Avosti David L. di Amabile-1957 07.04.1994 Ascona Avosti Isabelle D. n. Chopard 14.05.1961 Locarno Avosti Rachele di Miriam-1962 12.01.1986 Intragna Avosti Rosina n. Angeloni Lorenzo 27.10.1967 Avosti Sophie di Amabile-1957 25.07.1992 Locarno B Baccalà Eufemia T. n. De Angeli 04.08.1931 Breganzona Baccalà Glaucia n. Da Silva 02.06.1958 Baccalà Luciano fu Albino 27.10.1940 Ascona Baccalà Marco fu Albino 02.08.1947 Brissago Baccalà Marco R. fu Francesco C.-1927 19.01.1965 Breganzona Baccalà Roberto G. fu Francesco C.-1927 28.01.1960 Bardelli Maura n. -

The Italian Swiss DNA
Swiss American Historical Society Review Volume 52 Number 1 Article 2 2-2016 The Italian Swiss DNA Tony Quinn Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Quinn, Tony (2016) "The Italian Swiss DNA," Swiss American Historical Society Review: Vol. 52 : No. 1 , Article 2. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol52/iss1/2 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Quinn: The Italian Swiss DNA The Italian Swiss DNA by Tony Quinn* DNA testing is the new frontier in genealogical research. While the paper records of American and European churches and civil bodies are now generally available on line, DNA opens a new avenue of research into the period well before the advent of written records. And it is allowing people to make connections heretofore impossible to make. Recent historical examples are nothing short of amazing. When the bodies thought to be the last Russian Czar and his family, murdered in 1918, were discovered, a 1998 test using the DNA of Prince Philip proved conclusively that the bodies were indeed the Czar and his family. That is because Prince Philip and the Czarina Alexandra shared the same maternal line, and thus the same mitochondrial DNA. Even more remarkable was the "king in the car park," a body found under a parking lot in England thought to be King Richard III, killed at the Battle of Bosworth Field in 1485. -

Orario . Fahrplan 15.12.2019 – 13.06.2020
Orario . Fahrplan 15.12.2019 – 13.06.2020 Locarno - Domodossola – Locarno Intragna – Pila – Costa Verdasio - Rasa AMAZING JOURNEY ACROSS SWITZERLAND & ITALY û Locarno - Camedo - Locarno Biglietti solo all’automatico / Billette am Automaten lösen Il viaggiatore deve essere in possesso di un titolo di trasporto valido prima dell’orario di partenza. Der Reisende muss vor der Abfahrtszeit im Besitz eines gültigen Fahrausweises sein. Gruppi / Gruppen Per viaggi in gruppi, gruppi con Ticino Ticket e scuole occorre rivolgersi direttamente all’impresa: Gruppen, Gruppen mit Ticino Ticket und Schulen wenden Sie sich an die Transportunternehmung: 091 756 04 00, [email protected] Informazioni / Auskünfte Ì Non tutti i treni, non tutte le stazioni / Nicht alle Züge, nicht alle Bahnhöfe. 091 756 04 00 Treni in coincidenza www.ffs.ch / Anschlüsse www.sbb.ch Gli orari dei treni regionali della tratta italiana (Ribellasca–Domodossola) sono consultabili sul sito www.vigezzinacentovalli.com oppure sugli orari aziendali SSIF / Fahrpläne der Regionalzüge Ribellasca–Domodossola siehe www.vigezzinacentovalli.com oder Plakatfahrplan SSIF. Scartamento ridotto / Schmalspur Prenotazioni e shop online www.vigezzinacentovalli.com Contatti / Kontakt Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi FART, 6600 Locarno 091 756 04 00 [email protected] Orario · Fahrplan Locarno - Domodossola - Locarno dal 15.12.2019 al 06.01.2020 dal 07.01.2020 al 04.04.2020 dal 05.04.2020 al 13.06.2020 Intragna - Pila - Costa Verdasio - Rasa 620 Locarno - Domodossola (Centovalli) 620BellinzonaLocarno - Domodossola5 00 (Centovalli)5 32 Bellinzona6 02 6 32 dal 15.12.2019 al 06.01.2020 R R PE 300R 302R 120PE Locarno 5 25300 5 59302 Locarno6 29120 6 59 8A 8F 8F 8G Locarno FART 5 40 6Locarno 14 FART 6 49 Bellinzona 5 00 5 32 6 02 6 32 LocarnoBellinzona S. -
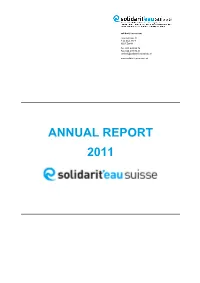
ANNUAL REPORT 2011 Annual Report 2011 2
solidarit’eau suisse Lagerstrasse 33 P.O. Box 3977 8021 Zurich Tel. 044 299 95 76 Fax 044 299 95 80 [email protected] www.solidariteausuisse.ch ANNUAL REPORT 2011 Annual Report 2011 2 Contents 1 Institutional setup ..................................................................................................................... 3 1.1 Steering Committee........................................................................................................... 3 1.2 Secretariat ......................................................................................................................... 4 1.3 Aguasan Group ................................................................................................................. 4 1.4 NGOs ................................................................................................................................ 4 1.5 Patronage committee......................................................................................................... 4 2 Communication / Marketing Activities....................................................................................... 5 2.1 Marketing of solidarit’eau suisse........................................................................................ 5 2.1.1 Flyer............................................................................................................................ 5 2.1.2 Individual communication ............................................................................................ 5 2.1.3 Mailings...................................................................................................................... -

Orarietti Linea 1 2019 Metà Anno.Pmd
Linea 1 Ascona-Locarno-Minusio-Tenero Multi carta Lunedì - sabato feriali Ascona, Centro 05.35 06.05 06.17 06.29 06.44 06.59 07.14 19.29 19.44 19.59 20.29 20.59 21.29 21.59 22.29 22.59 23.29 00.30 Losone, Ponte Maggia 05.39 06.09 06.21 06.35 06.48 07.05 07.20 19.35 19.50 20.03 20.33 21.03 21.33 22.03 22.33 23.03 23.33 00.34 Orario giornaliera. Solduno, Stazione 05.39 06.09 06.21 06.37 06.48 07.07 07.22 19.37 19.52 20.03 20.33 21.03 21.33 22.03 22.33 23.03 23.33 Locarno, S. Antonio 05.42 06.12 06.24 06.39 06.51 07.09 07.24 19.39 19.54 20.06 20.36 21.06 21.36 22.06 22.36 23.06 23.36 Valevole dal La scelta giusta Locarno, Piazza Castello 05.44 06.14 06.26 06.42 06.53 07.12 07.27 19.42 19.57 20.08 20.38 21.08 21.38 22.08 22.38 23.08 23.38 09.06.2019 al Locarno, Via della Pace 05.47 06.17 06.29 06.44 06.56 07.14 07.29 19.44 19.59 20.11 20.41 21.11 21.41 22.11 22.41 23.11 23.41 14.12.2019 per viaggiare tutto il giorno: Locarno, Stazione 05.50 06.20 06.32 06.47 06.59 07.17 07.32 19.47 20.02 20.14 20.44 21.14 21.44 22.14 22.44 23.14 23.44 Muralto, Croce Bianca 05.51 06.21 06.33 06.48 07.00 07.18 07.33 19.48 20.15 20.45 21.15 21.45 22.15 22.45 23.45 Minusio, Piazza 05.53 06.23 06.35 06.51 07.02 07.21 07.36 19.51 20.17 20.47 21.17 21.47 22.17 22.47 23.47 6 giorni al prezzo di 5. -

Foce Maggia (Locarno) 5113.02
Impianti di depurazione (IDA) www.ti.ch/acqua Pianificazione e progettazione Febbraio 2020 5 Scheda tecnica IDA Pagina 1 di 1 Nr. federale IDA Foce Maggia (Locarno) 5113.02 Coordinate 2704608 / 1112825 Altitudine 201 m s.l.m. Proprietario e gestore Consorzio depurazione acque del Verbano via Canevascini, 6601 Locarno Entrata in servizio 1983 Ampliamenti e 2005-2006 eliminazione odori ristrutturazioni 2008 rinnovo trattamento biologico, Bio-P 2009 pipeline Brissago-Ascona, dismissione dell’IDA di Brissago 2018 stazione sollevamento Bacino d’utenza Locarno,Ascona, Losone, Ronco s/Ascona Brissago, Minusio, Brione, Terre di Pedemonte Intragna (Centovalli), Avegno, Gordevio, Aurigeno, Moghegno, Maggia, Lodano, Coglio, Giumaglio, Someo, Riveo, Cevio, Bignasco Abitanti allacciati 51’061 (31.12.19) Ricettore diretto - Ricettore finale Lago Maggiore Tecnologia Impianto meccanico-biologico a fanghi attivi con defosfatazione chimica e Bio-P Linea acque Sollevamento Griglia grossa e griglia fine Dissabbiatore Decantazioni primarie Bacini biologici (fanghi attivi) Defosfatazione chimica e Bio-P Chiarificatore finale Linea fanghi Ispessimento Pipeline verso IDA Foce Ticino Dimensionamento 78’500 AE dim,COD,120 Fonti carte e fotografie: © 2020 swisstopo (5704001842), documentazione interna UPAAI e CDV D1-R-3_FMA Dipartimento del Territorio Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo Divisione dell’Ambiente Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico Impianti di depurazione (IDA) www.ti.ch/acqua Gestione IDA IDA -
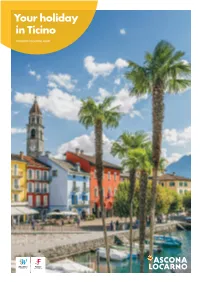
Your Holiday in Ticino Ascona-Locarno.Com Fusio
Your holiday in Ticino ascona-locarno.com Fusio Robiei Mogno 0 2 5 km Piano di Peccia S.Carlo Peccia Sonlerto Prato Sornico Val Lavizzara Val Bavona Broglio Menzonio Sabbione Brontallo Sonogno Cavergno Frasco Bignasco Sonnenberg Val Rovana Bosco Gurin Gerra Verzasca Cevio Cerentino Riveo Linescio Campo Brione Verzasca Someo Vallemaggia Cimalmotto Val di Campo Valle Verzasca Giumaglio Coglio Lavertezzo Lodano i Maggia Corippo Moghegno Vergeletto Aurigeno Gordevio Vogorno Gresso Salei Valle Onsernone Avegno Mergoscia Berzona Comologno Russo Loco Cimetta Auressio Crana Cardada Spruga Contra Mosogno Tegna Cavigliano Brione Gordola Agarone Pila/Costa Tenero Comino Verscio Orselina Bellinzona i Verdasio Minusio Riazzino Intragna Golino i Muralto Cugnasco-Gerra Centovalli Corcapolo Losone Borgnone Arcegno Locarno Rasa i Magadino Contone Bellinzona/ Domodossola (I) Camedo Palagnedra Ronco Ascona Quartino s/Ascona Lugano i Vira Gambarogno Porto Ronco Isole Piazzogna di Brissago S.Nazzaro Brissago Gerra Gambarogno i Ranzo Gambarogno Alpe di Neggia Cannobio (I) Luino (I) Indemini Freiburg (D) Mncen St. Gallen Basel ric Innsbruck (A) Luzern Bern Chur Switzerland Lausanne Ascona-Locarno Genève Bellinzona Sion Lyon (F) Torino (I) Lugano Lago Maggiore Milano (I) Benvenuti Cari ospiti, Willkommen vi presento la regione di Ascona-Locarno! Un territorio unico che va dalle palme ai ghiacciai, Bienvenue dove il mondo mediterraneo e quello alpino s’incon- Welcome trano. Dalle località di lago a quelle di montagna, al Lago Maggiore e nelle sue valli saprete trovare la destinazione che più si addice ai vostri bisogni. Liebe Gäste, herzlich willkommen in der Region Ascona-Locarno! Ein unvergleichliches Gebiet das von Palmenhainen bis zum Gletscher alles bietet. -

MM 18/2017 Preventivo Comunale 2018
Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurini 2 6652 Tegna TERRE DI PEDEMONTE T GNA- VERSCIO - CAVI OLIANO servizi. finanziari@pedemonte. ch Tegna, 9 novembre 2017 Ris. Mun. 591/2017 MESSAGGIOMUNICIPALE NO. 18/2017 conto preventivo comunale 2018 Il conto preventivo comunale per l'anno 2018 presenta seguenti dati: Gestione corrente: Spese CHF 9'506'422.00 Ricavi CHF 2'798'IOO. OC^ Fabbisogno CHF 6'708'322.1 CHF 9'506'422.00 CHF S'506'422.00 Preventivo 2018 Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, con il presente Messaggio vi sottoponiamo per analisi ed approvazione il Preventivo 2018 che presenta un risultato d'esercizio positivo pari a CHF 74'178. 00. Comune di Terre di Pedemonte - Preventivi 2014 2015 2016 2017 2018 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CKF CHF CHF do gest. corrente uscite correnti 8'075'950 7'987'575 7'990'820 8'188'65Ù S'241'422 ammort.amministr. I'176'OOO l'311'OOO l'633'OOO l'320'OOO l'265'OOO totale spese correnti 9'251'950 9'298'575 S'623'820 9'508'650 9'506'422 entrate correnti 3'336'600 3'275'200 3'379'860 2'745'650 2'798'IDO fabbisognodi imp. S'915'350 6'023'375 6'243'960 6'763'ODO 6'708'322 gettito di imp. com. S'719'350 6'046'OOD 6'299'SOO 6'440'SOO 6'782'SOO risultato d'eserdzlo -196'OM 22'625 55'540 -322'SOO 74'178 pagina nr. 1 Servizi finanziari Piazza Don Gottardo Zurini 2 6652 Tegna TERRE DI PEDEMONTE TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO [email protected] Dal riassunto e confrontando i diversi esercizi, possiamo evidenziare: la stima del risultato d'esercizio pari ad un utile di CHF 74'178. -

Mba N O Lago Maggiore
4 Il lago – idee Cardada-Cimetta Mercato di Ascona Falconeria Locarno 21 Locarno Via Chiossin Via (1332–1671 mslm) 6 (martedì, aprile-ottobre) 12 Collegiata Vallemaggia Cimetta Via delle Scuole 12, Locarno Resa per una vacanza perfetta e a n cardada.ch Piazza G. Motta, Ascona falconeria.ch o 44 BUS Lago Monti s o Valle Onsernone Mergoscia Valle Verzasca Ai s Via V Sempione i P a ia S i zza S e a S z taz ion Via Scazzig Centovalli ascona-locarno.com/shopping n T l ia e 6 Cardada di Vogorno t A a . a Via Cattor Costa e z V t a Funivia e seggiovia, passerella panoramica, Rappresentazioni di rapaci in volo /Flugvorführun- dritta gn z a Vi in i S Domodossola 1332 mslm Der See Tipps für einen Delle o V a – . V i nt Monti. e S M V escursioni a piedi e itinerario per mountainbike / Markt (Dienstag, April-Oktober) / Marché gen mit Greifvögeln / Représentations de vol Ai Via Delle Mona a ia i VVi g i ina o in al r c S i Seilbahn und Sessellift, Aussichtssteg, Wanderwege (mardi, avril-octobre) / Market (Tuesday, April- de rapaces / Bird of prey shows a u a perfekten Urlaub onte pp ell Via Cantonale 41 dram Via Ca D er Diga a ale V ban e i o Vi i V P V und MTB-Strecke / Téléphérique et télésiège, October) V a i V c Via i ia he ale della Verzasca Vallemaggi V a h M To Verscio passerelle panoramique, excursions à pied et a BorgheseBorghesB a r Piazzazza VViiaa rc re Stradón a tt Ball cc a Le lac – idées pour i nelle Ponte Brolla S.AntonioS.AntS Antonio n parcours VTT / Cable car and chairlift, panoramic Piazza G.