Skenè Studies I • 1 Συναγωνίζεσθαι Studies in Honour of Guido Avezzù
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quaderni Musicali Marchigiani 14
Quaderni Musicali Marchigiani 14 a cura di Concetta Assenza Pubblicazione dell’A.Ri.M. – Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI 14/2016 a cura di Concetta Assenza ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) via P. Bonopera, 55 – 60019 Senigallia www.arimonlus.it [email protected] QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 Comitato di redazione Concetta Assenza, Graziano Ballerini, Lucia Fava, Riccardo Graciotti, Gabriele Moroni Realizzazione grafica: Filippo Pantaleoni ISSN 2421-5732 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 a cura di Concetta Assenza In copertina: Particolare dell’affresco di Lorenzo D’Alessandro,Madonna orante col Bambino e angeli musicanti, 1483. Sarnano (MC), Chiesa di Santa Maria di Piazza. La redazione del volume è stata chiusa il 30 giugno 2016 Copyright ©2016 by A.Ri.M. – onlus Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, riservati per tutti i Paesi. «Quaderni Musicali Marchigiani» – nota Lo sviluppo dell’editoria digitale, il crescente numero delle riviste online, l’allargamento del pubblico collegato a internet, la potenziale visibilità globale e non da ultimo l’abbattimento dei costi hanno spinto anche i «Quaderni Musicali Marchigiani» a trasformarsi in rivista online. Le direttrici che guidano la Rivista rimangono sostanzialmente le stesse: particolare attenzione alle fonti musicali presenti in Regione o collegabili alle Marche, rifiuto del campanilismo e ricerca delle connessioni tra storia locale e dimensione nazionale ed extra-nazionale, apertura verso le nuove tendenze di ricerca, impostazione scientifica dei lavori. -

L'opera Italiana Del Novecento
PIERO MIOLI L'OPERA ITALIANA DEL NOVECENTO MANZONI MILANO, 2018 PREMESSA Cento anni: così Giuseppe Rovani volle intitolare il suo grande romanzo storico-ciclico, narrando vicende comprese fra il 1750 e il 1849 e fra l’altro largheggiando di curiose situazioni e riflessioni musicali (l’edizione definitiva del libro è del 1868-69); e così dovrebbe pur chiamarsi questo sommario panorama del '900 teatro-musicale italiano, nonostante tutti gli imbarazzi che presiedono a tali quadrature cronologiche e tutti i rischi che esso corre fornendo forse più dati che idee. Cent’anni, un secolo, un lungo segmento temporale tutto sommato finito da poco: ma se la fine di questo fatidico '900 si trova a sfumare nell’inizio del secolo seguente, il '100 del Duemila che è in corso, altrettanto si deve riconoscere oggi e si sarà asserito allora del suo inizio sfumato dalla fine del secolo precedente. Nell’impossibilità, dunque, di fissare un avvio riferibile a un preciso fattore di carattere sociale, civile, culturale, per non dire artistico e musicale, sarà provvedimento modesto e rassegnato ma almeno utile e chiaro quello che accetta di dare l'inizio al semplicissimo 1901 e la fine all'altrettanto schietto 2000, permettendosi il credibile lusso di procedere qualche anno ancora. L’imbarazzo non viene a mancare, s’intende, né s’abbassa il rischio, ma da parte sua, almeno, la matematica non ammette né repliche né sfumature. Prima di pervenire al corpo del discorso diacronico, descrittivo, impostato insomma come una giusta suddivisione in periodi, è però sembrato bene fornire degli schizzi storico-culturali che sappiano inquadrare degnamente, si spera, le fasi storiche del genere, un genere significativo ma assai esigente come il teatro d’opera italiano: dunque il diverso “panorama” sincronico promesso dall’indice comprende gli elementi generali, alcuni fenomeni particolari, i luoghi teatrali nel loro complesso e qualche teatro in vista più di altri, ovviamente e principalmente le prime culle della nuova produzione operistica. -

Download This PDF File
Mediterranean Journal of Clinical Psychology ISSN 2282-1619 Vol 7, n 1, 2019-Supplementum Psychology and Psychopathology of the Mask Clytemnestra both victim and executioner Marinella Calabrese 1 Abstract The present article deals with the relation between the concept of mask and some dynamics of fiction and revelation related to it. Each person, in the sense of individual, wears more masks, according to the roles and contexts of the society in which they live. The mask hides and, at the same time, reveals parts of the subject's personality. Even in the dynamic "victim-executioner" the roles, although apparently opposed, can sometimes be confused and overturned, and the masks can be exchanged. Among the figures of Greek mythology, Clytemnestra, the uxoricide who witnessed the murder of her first husband and newborn son, who saw the beloved daughter Iphigenia sacrificed for her husband Agamemnon's cravings for power, embodies the double role of victim and executioner. Clytemnestra has no other way to claim her role as a wounded mother and betrayed queen, if not to take power and exercise it in a bloody way: from being a victim she becomes an executioner, manifesting in her actions the primitive, cruel and murderous part she despised in the husband and in the world that surrounds her. 1 CIPA Centro Italiano Psicologia Analitica, Catania, Italy E-mail corresponding author: [email protected] Keywords: Clytemnestra; Victim; Executioner; Analytical Psychology. DOI: 10.6092/2282-1619/2019.7.2234 1. Clytemnestra in the past The Greek tragedy, from its birth, involved the use of masks. The mask served to make the features of the actor's face more evident, to enhance their expressions, to amplify the voice. -

Wend 1 Patriarchal Authority
Wend 1 Patriarchal Authority and “Coming Home” In Tragedy Patriarchal authority in the power of women in the home has been subverted in different ways over the past few millenniums in tragedy. To return from matriarchal to patriarchal rule Clytemnestra in the Oresteia has to be murdered in cold blood in an act of vengeance. There is a sharp return back to matriarchal rule in Harold Pinter's The Homecoming, where a woman sees through her role as her husband's, what Gayle Rubin refers to as a, conduit and manipulates the men in her life using their misogynistic fantasies to control and subvert them to literally a kneeling position before her. Henrik Ibsen's A Doll's House allows a further move away from woman as aesthetic fantasy and through a drastic rebellion allows a woman to become much more than a wife and mother. Others, such as Italian playwright Dacia Maraini's postmodern play I sogni di Clitennestra have attempted to rewrite the misogyny of plays like the Oresteia to put an even greater emphasis on women being able to “come home” to their authority and power. An examination of these texts using theorists as varied as Penelope Prentice, Froma Zeitlin, Toril Moi, and finally Rubin herself will allow for the ways in which patriarchal authority is subverted and the power of women is accentuated in these plays to come to life. * Harold Pinter's 1965 play The Homecoming displays a subversive female protagonist whose actions change the lives of the men in the home she takes over. -

Ildebrando Pizzetti
ILDEBRANDO PIZZETTI Nato a Parma nel 1880, Ildebrando Pizzetti fu iniziato dal padre allo studio del pianoforte; studiò poi Composizione al Conservatorio della sua città ed ottenne il Diploma nel 1901, mettendosi ben presto in luce con le musiche di scena per “La nave” di D'Annunzio (nel 1908); nello stesso anno assunse la cattedra di Armonia e Contrappunto al Conservatorio di Firenze, che diresse poi dal 1917 al 1923. Nel 1924 venne nominato direttore del Conservatorio di Milano, che lasciò nel 1936 per assumere la cattedra di perfezionamento in Composizione, lasciata vacante da Ottorino Respighi, all'Accademia di Santa Cecilia di Roma (fra i suoi allievi si ricordano Nino Rota, Mario Castelnuovo – Tedesco, Gianandrea Gavazzeni e molti altri). All'intensa attività creativa, il musicista affiancò fin dalla giovinezza quella di critico, di musicologo e di direttore dei propri lavori teatrali e sinfonici in tournées artistiche non solo in Europa, ma anche nell'America del Nord. Fu poi anche presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (dal 1949) e negli ultimi anni della sua vita diresse l'Istituto di Studi Verdiani a Parma. Anch’egli fu insignito dei titoli di Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Partendo dalla produzione strumentale, specificamente dai suoi due Quartetti per archi, dai due Trii per pianoforte e archi, e dalla Sonata per violino e pianoforte, si nota un gusto per la freschezza melodica che troviamo anche nelle pagine operistiche come Fedra e La figlia di Jorio di Gabriele D'Annunzio, in Fra' Gherardo, Lo straniero, Orseolo, Assassinio nella cattedrale (da Eliot) e Clitennestra, l'ultima sua opera. -

Laura Orvieto and the Classical Heritage in Italy Before the Second World War*
chapter 5 Laura Orvieto and the Classical Heritage in Italy before the Second World War* Valentina Garulli To Elda Baldi Montesano, who gently opened my eyes to the wonderland of literature, to life. ⸪ Introduction Molti e molti anni fa c’era nell’Asia, vicino al mare, una città che si chia- mava Troia. Il re di Troia si chiamava Ilo…1 * I would like to thank Caterina Del Vivo (Director of the Historical Archive at the “Gabinetto G.P. Vieusseux,” Florence, and of the Tuscany Section at the Associazione Nazionale Ar- chivisti Italiani) for her precious advice, generous help, and support at every stage of this project. The unpublished documents quoted in the following belong to the Contemporary Archive “Alessandro Bonsanti: Gabinetto G.P. Vieusseux,” Florence (henceforth mentioned as acgv): my warmest thanks to Gloria Manghetti (Director of the Contemporary Archive) for kindly granting me permission to use and publish this material, and to Fabio Desideri (Con- temporary Archive) for his help with the manuscript material. My gratitude also to Guido Bastianini, Patrick Finglass, Lucia Floridi, Gabriella Gruder-Poni, Camillo Neri, and Vinicio Tammaro for reading a first draft of this paper and making useful comments. Laura’s and Angiolo Orvieto’s writings will be referred to as follows. Laura Orvieto’s works (ordered by date): Orvieto, Leo e Lia = Laura Orvieto, Leo e Lia. Storia di due bambini italiani con una gover nante inglese [Firenze: Bemporad, 1909], illustrazioni di Vanna Vinci (Firenze: Giunti, 2011). Orvieto, Storie greche e barbare = Laura Orvieto, Storie della storia del mondo. Greche e barbare [Firenze: Bemporad, 1911, but in fact 1910] (Firenze: Giunti, 1961). -

TRA IMPIA CAEDES E PIUM FURTUM: LOTTA DI PAROLE NELL'agamemnon DI SENECA Nell'agamemnon Senecano Si Fronteggiano Due Aspetti
GIUSEPPE SPINNATO TRA IMPIA CAEDES E PIUM FURTUM : LOTTA DI PAROLE NELL’ AGAMEMNON DI SENECA Nell’ Agamemnon senecano si fronteggiano due aspetti specifici, simmetrici e con - comitanti, dei doli messi in scena: da un lato il riuso viziato e disinvolto di un lessico relativo ai valori da parte dei carnefici, dall’altro il contro-inganno delle vittime. Se infatti la macchina della regia drammatica illumina a tinte piene il dolus princi - pale di Clitemnestra ai danni del marito – variamente declinato e sostanziato dal cor - rispondente vocabolario 1 – d’altro canto, l’inganno dei ‘grandi’ carnefici e la loro manipolazione verbale sembrano produrre un simmetrico cono d’ombra, speculare non solo per valori ma anche per lessico, un vero e proprio contro-inganno, messo in atto dalle vittime e a sua volta connotato e denotato positivamente. Si tratta di azioni in qualche modo anch’esse riconducibili all’alveo proteiforme della fraus , con - dotte e dirette da Elettra, figlia e rivale della madre, al cui dolus culminante nell’ impia caedes si oppone con il suo pium furtum . In questo secondo caso, come si vedrà, si scontreranno sotto il denominatore comune del lessico valoriale le azioni e le voci di madre e figlia, in una lotta in cui ad essere in gioco sono tanto i corpi quanto le parole: dopo essere fuggita dalla reggia alla notizia dell’omicidio del padre, Elettra sottrarrà il fratello Oreste alle mani della madre e di Egisto con un furtum da lei stessa definito pium , qualificazione avvertita come necessaria, vista la natura essenzialmente negativa del termine a cui si riferisce 2. -
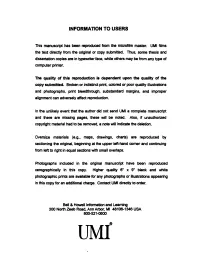
Operatic Reform in Turin
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter tece, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, If unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. Bell & Howell Information and Learning 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 NOTE TO USERS This reproduction is the best copy available. UMI OPERATIC REFORM IN TURIN: ASPECTS OF PRODUCTION AND STYLISTIC CHANGE INTHEI760S DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Margaret Ruth Butler, MA. -

Ildebrando Pizzetti a Quarant'anni Dalla Scomparsa
Un musicista che ha onorato l’italianità ILDEBRANDO PIZZETTI A QUARANT’ANNI DALLA SCOMPARSA di Anna Maria Novelli el febbraio 1968 si spegneva a Roma Ildebrando Pizzetti, uno dei Tebaldini lo portò con al- Npiù grandi compositori italiani del ventesimo secolo. Aveva vissu- tri allievi in visita alla Villa to l’avventura umana con assoluta dedizione all’arte. Era nato a Parma di Sant’Agata. Vi introdusse nel 1880. Il padre Odoardo, anch’egli musicista, accortosi delle sue in- il declamato, diede un ruolo solite doti intellettuali e creative, dopo gli studi classici, lo iscrisse al lo- preponderante ai cori, adottò cale Conservatorio. Lì Ildebrando ebbe la fortuna di incontrare Giovan- modalità compositive inedite, ni Tebaldini, direttore trentatreenne dell’Istituto - maestro competente dove la musicalità si compe- e rigoroso, dalle idee innovative - che ne aveva subito intuito il talento netrava ai testi poetici. Infatti, indirizzandolo verso la strada che egli continuerà a percorrere per tutta nello sviluppare la sua attivi- la vita: quella della riscoperta della tradizione musicale italiana che af- tà con serietà e professionali- fonda le radici nel canto gregoriano, nella polifonia palestriniana e nel tà, tenendosi fuori dalla mon- “recitar cantando”. Ciò gli consentì di approfondire le più gloriose espe- danità, aveva saputo coltivare rienze musicali del nostro passato, di dare continuità storica all’arte del e finalizzare, con autorevo- suono e di giungere a una modernità autentica, basata su un linguaggio lezza, il genere letterario. Co- Ildebrando Pizzetti nel 1901, studente al Regio di gusto nuovo, ricco di contenuti umani e immateriali, tutt’altro che as- sì ci ha lasciato una quantità Conservatorio di Musica di Parma soggettato alle mode esterofile che imperversavano in quegli anni. -

Da Zeuž Xevn Iož Al Fantasma Di Tieste. Vendetta E Giustizia in Eschilo E Seneca
Gianni Guastella Da Zeuž Xevniož al fantasma di Tieste. Vendetta e giustizia in Eschilo e Seneca Abstract Comparing Aeschylus’s and Seneca’s Agamemnon it is possible to see how, whereas in Aeschylus “just revenge” aims at putting an end to the sequence of retaliations, in Seneca it is anger that triggers a boundless succession of crimes. Il confronto fra l’ Agamennone di Eschilo e l’omonima tragedia di Seneca mostra come nel primo un meccanismo retributivo di “giusta vendetta” sia concepito secondo un principio che aspira a porre fine alla catena delle ritorsioni, mentre nella seconda predomina la logica senza misura dell’ira, che scatena una gara di delitti potenzialmente infinita. 0. Vendetta e giustizia Per presentare il tema della “giustizia” 1 in una vicenda come quella rappresentata da Eschilo nell’ Orestea , può essere utile partire dalla domanda che Elettra propone al coro al v. 120 delle Coefore 2: povtera dikažth;n h] dikhfovron levgeižÉ Nella distinzione fra le funzioni di chi “amministra” la giustizia e chi la “realizza direttamente” sta il dilemma fra le due modalità di risoluzione dei conflitti che si contrappongono per tutto il corso della trilogia. Da una parte la divkh realizzata direttamente dagli interessati allo scontro familiare che oppone i due rami della famiglia 1 Userò il termine “giustizia” fra virgolette, per indicare che mi riferisco a una sfera semantica ampia, quella della giustizia secondo le nostre coordinate culturali. Non è possibile in questa sede riprendere la complessa discussione sul significato generale del termine divkh . Senza contare vecchi lavori come HIRZEL (1907, 56-227), mi limito a rimandare, fra i contributi più recenti, ad ALLEN (2000, 39-49 e 148- 51 in partic.), COHEN (1986), GAGARIN (1973, 1974 e 1976), HAVELOCK (1978), KAUFMANN -BÜHLER (1951: specificamente sulle tragedie eschilee: all’Orestea sono dedicate le pp. -

Aeschylus' Clytemnestra Versus Her Senecan Tradition
Aeschylus’ Clytemnestra versus her Senecan Tradition Edith Hall 1. Clytemnestra’s gauntlet An unknown Etrurian sculptor in the second century AD decorated an alabaster urn with a scene in which Clytemnestra takes the principal role in the murder of Agamemnon (fig. 1). It is an unremarkable art work in both design and execution, but it has a peculiar significance that only a diachronic process of reflection on the figure of Clytemnestra can reveal. For this is the sole certain ancient visual illustration of the murder of Agamemnon to post-date Aeschylus’ Oresteia which makes Clytemnestra the primary agent in her husband’s slaughter.1 Literary versions which make her both mastermind and the executor of the crime are also rare, one exception being Philostratus’ even later Cassandra, an ecphrasis of a painting written in about 300 AD (Imagines 2.10, see further Easterling, this volume, pp. 000). Philostratus’ semi-crazed Clytemnestra, her hair streaming, is visualised assaulting Cassandra with an axe still warm from Agamemnon’s body (2.10.4). It is striking, however, that even here, in a detailed description of Agamemnon’s return which self-consciously harks back to classical Athenian tragedy, no mention whatsoever is made of Iphigenia.2 Clytemnestra dominates the Aeschylean play named after her husband. She is a murderer, an androgyne, a liar, an orator, and executor of a palace coup. She is also an avenging mother. Of all the characters she has the most powerful speeches and the most confrontational scenes. Her impact was swift: when the legal speech-writer Antiphon composed the case for the prosecution in the mid-fifth-century trial of a woman accused of murdering her husband (a trial which would have been held, like the trial depicted in Eumenides, at the court of the Areopagus), he invoked a parallel with Clytemnestra (Antiphon 1.17). -

Mary Rowen Obelkevich, Associate Editor GENERAL EDITING: Margaret Ross Griffel, Associate Editor REPORTS-DOMESTIC: D
EDITOR-IN-CHIEF: L. MICHAEL GRIFFEL ADJUNCT EDITOR: Mary Rowen Obelkevich, associate editor GENERAL EDITING: Margaret Ross Griffel, associate editor REPORTS-DOMESTIC: D. Jay Rahn, associate editor REPORTS-FOREIGN: Emmanuel Leemans, associate editor Robert Fuller, assistant editor ARTICLES: Isabelle Emerson, associate editor Miriam Kartch, editorial assistant DISSERTATIONS: Josephine Mongiardo Cooper, associate editor Susan Testa, associate editor BIBLIOGRAPHICA: Thomas W. Baker, associate editor June Lord-Wood, editorial assistant SPECIAL PROJECTS: Tamara Lowe Dworsky, associate editor Leonie Rosenstiel, associate editor Maurie Sommer, associate editor Bonnie Lester, assistant editor BUSINESS: Stephen Willis, Manager, associate editor Jack Light, Advertising, assistant editor SECRETARY: Cynthia Schwan FACULTY ADVISOR: Edward A. Lippman Copyright © 1971, The Trustees of Columbia University in the City of New York Printed in Great Britain by Wm. Clowes & Sons, Ltd., London CORRESPONDING EDITORS Domestic Patricia T. Nolan Boston University, Boston, Mass. Alexander Silbiger Brandeis University, Waltham, Mass. Harriet Franklin Brown University, Providence, R.I. Myrl Hermann Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pa. Harrison M. Schlee Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pa. Marilyn Holt Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio Robert E. Houston Catholic University of America, Washington, D.C. Nathan Bergenfeld City University of New York,Brooklyn College,Brooklyn, N.Y. Adrienne F. Block City University of New York, Hunter College, New York, N.Y. Bea Friedland City University of New York, Queens College, Flushing, N.Y. Mary R. Obelkevich Columbia University, New York, N.Y. Gaynor G. Jones Cornell University, Ithaca, N.Y. Thomas Kelly Harvard University, Cambridge, Mass. James C. Griesheimer Indiana University, Bloomington, Ind. Howard Knopf Juilliard School, New York, N.Y.