Alcune Storie Nella… Storia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
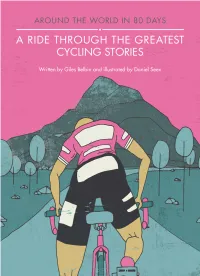
9781781316566 01.Pdf
CONTENTS 1 The death of Fausto 7 Nairo Quintana is born 12 Maurice Garin is born 17 Van Steenbergen wins 27 Henri Pélissier, convict 37 The first Cima Coppi Coppi 2 January 4 February 3 March Flanders 2 April of the road, is shot dead 4 June 2 Thomas Stevens cycles 8 The Boston Cycling Club 13 First Tirenno–Adriatico 18 71 start, four finish 1 May 38 Gianni Bugno wins round the world is formed 11 February starts 11 March Milan–Sanremo 3 April 28 The narrowest ever the Giro 6 June 4 January 9 Marco Pantani dies 14 Louison Bobet dies 19 Grégory Baugé wins Grand Tour win is 39 LeMond’s comeback 3 Jacques Anquetil is 14 February 13 March seventh world title recorded 6 May 11 June born 8 January 10 Romain Maes dies 15 First Paris–Nice gets 7 April 29 Beryl Burton is born 40 The Bernina Strike 4 The Vélodrome d’Hiver 22 February underway 14 March 20 Hinault wins Paris– 12 May 12 June hosts its first six-day 11 Djamolidine 16 Wim van Est is born Roubaix 12 April 30 The first Giro d’Italia 41 Ottavio Bottecchia fatal race 13 January Abdoujaparov is born 25 March 21 Fiftieth edition of Paris– starts 13 May training ride ‘accident’ 5 The inaugural Tour 28 February Roubaix 13 April 31 Willie Hume wins in 14 June Down Under 19 January 22 Fischer wins first Hell of Belfast and changes 42 Franceso Moser is born 6 Tom Boonen’s Qatar the North 19 April cycle racing 18 May 19 June dominance begins 23 Hippolyte Aucouturier 32 Last Peace Race finishes 43 The longest Tour starts 30 January dies 22 April 20 May 20 June 24 The Florist wins Paris– 33 Mark Cavendish -

Introduction Ottavio Bottecchia Died on June 15, 1927. Ninety Years Have Since Passed, but He Has Not Faded Into Oblivion. If Yo
Introduction Ottavio Bottecchia died on June 15, 1927. Ninety years have since passed, but he has not faded into oblivion. If you pause to listen, you can hear the faint sound of his breath. The echoes of his horn, echoing through the mountains, the great horn of Orlando. Bottecchia does not merely belong to the histories of sport or Italy, but in the tales of heroic deeds. His accomplishments are too great for reporters, they should be told by the poets. He emerged at the time of the "giants of the road". Audacious and pure, defying the ambushes. The bicycle was his sword, the Excalibur next to which he died. The mountain roads of Friuli were his battleground. Throughout Bottecchia's life, heroism, mystery and tragedy are all interwoven with glorious embellishment. If Bartali was the champion of faith, then Bottecchia was the hero of war. If Bartali was the river Jordan, then Bottecchia was the Piave. Bartali was like a crusader, he had an army at his back and God on his side. Bottecchia stood alone, an embodiment of all these values. Face to face with Rommel at the Tagliamento. He was the prisoner that escaped three times. He was the champion of migrants. His footsteps have been traced by millions of Italians. Those who were cannon fodder. Those with cardboard suitcases. Those who crossed boundaries and challenged the unknown. Those who, instead of a bank account, had two counsellors: dreams and despair. First Carnera has her own shoes. They leave heavy footprints. He was the man of metamorphosis. -

Giro Ditalia Bibliografia
Il Giro d'Italia ha un sapore mitico: sembra J. Foot, Pedalare! La grande avventura del esistere da sempre, eppure ha una sua storia, ciclismo italiano. Rizzoli, 2011 che accompagna e in cui si riflette la storia B. Conti, 100 storie del Giro. Graphot, 2008 culturale e sociale dell'Italia. (M. Franzinelli) G.L. Favetto, Italia, provincia del Giro. Storie di Fra pochi giorni anche Cernusco entrerà a far eroi, strade e di inutili fughe. Mondadori, 2006 IL GIRO D’ITALIA parte di questa Storia e anche se altri e più tristi G. Brera, L’Anticavallo; sulle strade del Tour e eventi hanno smorzato l’entusiasmo, vogliamo del Giro. Baldini & Castoldi, 1997 Bibliografia comunque celebrare l’evento con i nostri consueti suggerimenti di lettura. D. Buzzati, Dino Buzzati al Giro d’italia. Mondadori, 1981 Buon Giro a tutti! Il ciclismo e la Storia S. Clemiston, Storia del ciclismo in 100 oggetti, Rizzoli, 2018 R. Dineen, Ciclopedia. Guida Infografica al ciclismo. Il Castello, 2017 C. Sidwells, Le maglie leggendarie del ciclismo, Storia del Giro Ediciclo, 2017 D. Coltrinari, L. Onesti, C’era una volta in J.L. Marianantoni, 110 anni in rosa. Pendragon, Portogallo, Tuga, 2016 2019 G. Burreddu. Vedrai che uno arriverà. Il ciclismo I. Serantoni, La magia rosa. Bolis, 2017 tra inferni e paradisi. Absolutely Free, 2014 P. Colombo, La corsa del secolo. Mondadori, O. Beha, Un cuore in fuga. Piemme, 2014 2017 A. Bartali, Gino Bartali, mio papà. Limina, M. Franzinelli, Il Giro d’Italia. Dai pionieri agli 2012G. Brera, L’avocatt in bicicletta. Book Time, anni d’oro. -

1. Místo 1903 Maurice Garin 1904 Henri Cornet 1905 Louis Trousselier 1906 René Pottier 1907 Lucien Petit-Breton 1908 Lucien Pe
VÍT ĚZOVÉ TOUR DE FRANCE 1. místo 2. místo 3. místo 1903 Maurice Garin Lucien Pothier Fernand Augereau 1904 Henri Cornet Jean-Baptiste Dortignacq Alois Catteau 1905 Louis Trousselier Hyppolite Aucouturier Jean-Baptiste Dortignacq 1906 René Pottier Georges Passerieu Louis Trousselier 1907 Lucien Petit-Breton Gustave Garrigou Emile Georget 1908 Lucien Petit-Breton François Faber Georges Passerieu 1909 François Faber Gustave Garrigou Jean Alavoine 1910 Octave Lapize François Faber Gustave Garrigou 1911 Gustave Garrigou Paul Duboc Emile Georget 1912 Odile Defraye Eugene Christophe Gustave Garrigou 1913 Philippe Thys Gustave Garrigou Marcel Buysse 1914 Philippe Thys Henri Pélissier Jean Alavoine 1919 Firmin Lambot Jean Alavoine Eugene Christophe 1920 Philippe Thys Hector Heusghem Firmin Lambot 1921 Léon Scieur Hector Heusghem Honoré Barthelemy 1922 Firmin Lambot Jean Alavoine Félix Seller 1923 Henri Pélissier Ottavio Bottecchia Romain Bellenger 1924 Ottavio Bottecchia Nicolas Frantz Lucien Buysse 1925 Ottavio Bottecchia Lucien Buysse Bartolomeo Aimo 1926 Lucien Buysse Nicolas Frantz Bartolomeo Aimo 1927 Nicolas Frantz Maurice Dewaele Lucien Vervaecke 1928 Nicolas Frantz André Leducq Maurice Dewaele 1929 Maurice Dewaele Giuseppe Pancera Jef Demuysere 1930 André Leducq Learco Guerra Antonin Magne 1931 Antonin Magne Jef Demuysere Antonio Pesenti 1932 André Leducq Kurt Stoepel Francesco Camusso 1933 Georges Speicher Learco Guerra Gius eppe Martano 1934 Antonin Magne Giuseppe Martano Roger Lapébie 1935 Romain Maes Ambrogio Morelli Félicien Vervaecke -

'Tour De France' 1903
Unusual and little-known Tales from the ‘Tour de France’ 1903 – 1947 With Barrington Day The line between insanity and genius is said to be a fine one, and in early 20th century France, anyone envisaging a near 2,500km cycle race around the country would have been widely viewed as unhinged. But that didn’t stop Géo Lefèvre, a journalist with L’Auto magazine at the time, from proceeding with his inspired plan. His editor, Henri Desgrange, was bold enough to believe in the idea and to throw his backing behind the Tour de France. So, on 1st July 1903, sixty pioneers set out on their bicycles from Montgeron. After six mammoth stages (Nantes - Paris, 471 km!), only 21 “routiers”, led by Maurice Garin, arrived at the end of this first epic. Having provoked a mixture of astonishment and admiration, le Tour soon won over the sporting public and the roadside crowds swelled. The French people took to their hearts this Tour Founder - Henri Desgrange unusual event which placed their towns, their countryside, and since 1910, even their mountains, in the spotlight. Le Tour has always moved with the times. Like France as a whole, it benefited from the introduction of paid holidays from 1936; it has lived through wars, and then savoured the “trente glorieuses” period of economic prosperity while enjoying the heydays of Coppi, Bobet, Anquetil and Poulidor. It has opened itself up to foreign countries with the onset of globalisation. Over a hundred years after its inception, le Tour continues to gain strength from its experience. -

LA VECIA FEROVIA DE LA VAL DE FIEMME Percorso 40 MOLINA DI FIEMME (TN), 06 Agosto 2017
LA VECIA FEROVIA DE LA VAL DE FIEMME Percorso 40 MOLINA DI FIEMME (TN), 06 Agosto 2017 Pos Pett Nominativo Anno Cat Pos Squadra Tempo Distacco 1 25 RABENSTEINER FABIAN 1990 E 1 TEAM TREK SELLE SAN MARCO-TONE 01:28:37.16 - 27,35 2 3 FRUET MARTINO 1977 E 2 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE 01:29:23.75 +46 27,12 3 2 LONGA MATTIA 1988 E 3 CANNONDALE RH-RACING 01:29:42.67 +1:05 27,02 4 45 FAVILLI ELIA 1989 E 4 BIKE INNOVATION FOCUS PISSEI 01:29:57.74 +1:20 26,94 5 12 VALERIO DOMENICO 1991 E 5 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 01:30:29.25 +1:52 26,79 6 18 BONELLI EFREM 1986 E 6 CMQ CARBONHUBO 01:30:30.24 +1:53 26,78 7 40 CARGNELUTTI DIEGO 1986 E 7 WILIER FORCE SQUADRA CORSE 01:30:30.25 +1:53 26,78 8 36 DAL GRANDE STEFANO 1990 E 8 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:30:41.48 +2:04 26,73 9 50 CRISI EMANUELE 1994 E 9 CANNONDALE RH-RACING 01:31:03.99 +2:26 26,62 10 7 DEHO MARZIO 1968 E 10 G.S. CICLI OLYMPIA 01:31:09.67 +2:32 26,59 11 34 MEDVEDEV DMITRY 1987 E 11 TORPADO-SUDTIROL MTB PRO TEAM 01:31:19.61 +2:42 26,54 12 99 ZAMBONI ANDREA 1982 M2 1 CARINA BRAO CAFE' 01:31:26.01 +2:48 26,51 13 26 OLIVA VITTORIO 1991 E 12 CARBONHUBO CMQ INFOTRE 01:31:42.73 +3:05 26,43 14 22 GOGOLEV MAKSIM 1981 E 13 SAMARA 01:31:45.57 +3:08 26,42 15 11 ADAOS ALVAREZ FRANCO NICOLAS 1995 U23 1 KTM TORRE BIKE 01:32:43.36 +4:06 26,14 16 203 ZAMPEDRI LUCA 1976 M3 1 SC PERGINE 01:33:04.39 +4:27 26,04 17 88 LORENZETTI MATTIA 1987 M1 1 SC ALA 01:33:10.01 +4:32 26,02 18 81 TAFFAREL NICOLA 1999 J 1 TEAM DAMIL - GT TREVISAN 01:33:39.71 +5:02 25,88 19 95 SEGATA CLAUDIO 1973 M3 2 TEAM TODESCO 01:33:46.88 -

Alla Scoperta Del Giro D'italia
ALLA SCOPERTA DEL GIRO D’ITALIA IL GIRO D’ITALIA E BICISCUOLA Il Giro d’Italia è una corsa a tappe di ciclismo su strada che ogni anno, a partire dal 1909, attraversa il nostro paese nel mese di maggio. Il Giro però è qualcosa di più di un evento sportivo. È un’avventura lunga 23 giorni, che vede i suoi protagonisti (ciclisti, tifosi, giornalisti) darsi appuntamento sulle strade d’Italia per vivere assieme una grande emozione. Un’emozione rosa! BICISCUOLA è un progetto che promuove il Giro d’Italia tra i giovanissimi. In 13 anni, Biciscuola ha insegnato, divertito e incoraggiato l’utilizzo della bicicletta per uno stile di vita sano oltre 1.2 milioni di giovani italiani, assegnando premi e riconoscimenti al Giro ad oltre 22 mila ragazzi. Questa guida, che avete ricevuto grazie all’adesione della vostra classe a BiciScuola, vuole accompagnarvi alla scoperta del magico mondo del Giro d’Italia e della bicicletta in generale. Siete pronti per seguirci assieme in questo viaggio? Allacciate il casco, trattenete il fiato e girate la pagina. Inizia l’avventura! E per ogni dubbio o curiosità…non esitate a contattarci! Segreteria BiciScuola, Casella Postale n° 692 - 43123 Parma Telefono: 0521/1813823 - Fax: 0521/1812572 E-mail: [email protected] - Sito internet: www.biciscuola.it 1 03 I VALORI DEL GIRO Il Giro d’Italia è un grande evento di sport che 04 IL TROFEO SENZA FINE porta con sé alcuni valori molto importanti: 05 LA MAGLIA ROSA E LE ALTRE MAGLIE VALORI 06 I CAMPIONI DEL GIRO 08 LA STORIA DEL GIRO DEL GIRO 09 I MOMENTI PIÙ BELLI DEL -

Veneto Cup XC 2021 Master Classifica Individuale Dopo Ultima Prova
Veneto Cup XC 2021 Master Classifica Individuale Dopo Ultima Prova Rg Nominativo Cat. Anno ID Team Team Punti Montecchio M. Farra di S. Maser Borso d Grappa Conegliano Soapirolo S Pietro di Fel Donne Master 1 MIOLA ASTRID EWS 1997 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 176 21 23 20 21 26 35 30 2 ZOCCA LORENA W2 1977 03N2871 S.C. BARBIERI 161 26 35 35 30 35 - - 3 SOLIGO DEBORAH EWS 1993 03N2062 A.S.D. M B TEAM MACRO 153 23 30 21 23 30 - 26 4 VAZZOLER MARTINA W2 1980 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 129 - 20 18 19 23 26 23 5 SELVA CHIARA W2 1980 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 87 - - 26 26 - - 35 6 RIGO ELISA EWS 1999 03M1420 S.S.D. PEDALE FELTRINO 50 - - - 20 - 30 - 7 CIPRIAN ROMINA W2 1976 03Z3243 CYCLE LAB A.S.D. 40 - 21 19 - - - - 8 SESENNA FEDERICA EWS 1993 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 35 35 - - - - - - 9 CAMEDDA OLGA EWS 1997 02M3998 ASD CICLI BACCHETTI 35 - - - 35 - - - 10 FILIBERTI SILVIA W2 1975 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 30 30 - - - - - - 11 TOSATO KARIN W2 1979 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 30 - - 30 - - - - 12 CE' SIMONA W2 1976 02B3422 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 26 - 26 - - - - - 13 DANIELE SILVIA W2 1980 03C3134 OMAP CICLI ANDREIS 20 20 - - - - - - 14 PONTANI LUNA EWS 1997 05E0538 TEAM GRANZON 19 19 - - - - - - 15 GASPAROTTO LARA EWS 1993 05B0782 ASD TECNO BIKE TEAM K2 18 18 - - - - - - MasterElite 1 SAVI NICOLA ELMT 1993 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 236 35 35 35 35 35 35 26 2 NARDEI DAVIDE ELMT 1994 03X2201 BIKE CLUB 2000 197 23 26 30 30 23 30 35 3 DE BONA SIMONE ELMT 1995 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 158 30 30 21 21 30 26 - 4 PAVANELLO ANDREA ELMT 1992 03S2388 EL CORIDOR TEAM 145 26 23 26 19 21 - 30 5 CELEGHIN DAVIDE ELMT 1993 03X2201 BIKE CLUB 2000 119 14 18 17 15 19 19 17 6 ZANANDREA SIMONE ELMT 2000 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 115 17 16 - 18 20 23 21 7 ZANETTE WILLIAM ELMT 1999 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 79 - 21 18 17 - - 23 8 MANCIN MAJONI DAVIDE ELMT 1997 03D1495 A.S.D. -

Mancebo:“Elmejorpremio Hasidomihijapaula”
MUNDO ATLETICO Lunes 25 de julio de 2005 POLIDEPORTIVO Ciclismo/Tour 31 PALMARÉS TODOS LOS GANADORES DE LA HISTORIA DEL TOUR DE FRANCIA DESDE 1903 HASTA 2005: 2005 Lance Armstrong (Estados Unidos) 2004 Lance Armstrong (Estados Unidos) 2003 Lance Armstrong (Estados Unidos) 2002 Lance Armstrong (Estados Unidos) 2001 Lance Armstrong (Estados Unidos) 2000 Lance Armstrong (Estados Unidos) 1999 Lance Armstrong (Estados Unidos) RDE FRANCIA 1998 Marco Pantani (Italia) 1997 Jan Ullrich (Alemania) 1996 Bjarne Riis (Dinamarca) 1995 Miguel Indurain (España) 1994 Miguel Indurain (España) 1993 Miguel Indurain (España) 1992 Miguel Indurain (España) 1991 Miguel Indurain (España) 1990 Greg LeMond (Estados Unidos) 1989 Greg LeMond (estados Unidos) 1988 Pedro Delgado (España) 1987 Stephen Roche (Irlanda) 1986 Greg LeMond (Estados Unidos) 1985 Bernard Hinault (Francia) 1984 Laurent Fignon (Francia) 1983 Laurent Fignon (Francia) 1982 Bernard Hinault (Francia) 1981 Bernard Hinault (Francia) 1980 Joop Zoetemelk (Holanda) 1979 Bernard Hinault (Francia) 1978 Bernard Hinault (Francia) 1977 Bernard Thevenet (Francia) 1976 Lucien Van Impe (Bélgica) 1975 _ Bernard Thevenet (Francia) 1974 Eddy Merckx (Bélgica) 1973 Luis Ocaña (España) La última etapa 1972 Eddy Merckx (Bélgica) de esta edición 1971 Eddy Merckx (Bélgica) del Tour quedará 1970 Eddy Merckx (Bélgica) para siempre en el 1969 Eddy Merckx (Bélgica) recuerdo de Lance 1968 Jan Jansen (Holanda) Armstrong. Corrió 1967 Roger Pingeon (Francia) relajado, enseñó 1966 Lucian Almar (Francia) orgulloso su 1965 Felice Gimondi (Italia) trofeo en el podio, 1964 Jacques Anquetil (Francia) brindó con 1963 Jacques Anquetil (Francia) Bruyneel, saludó a 1962 Jacques Anquetil (Francia) Leblanc, abrazó a 1961 Jacques Anquetil (Francia) Ullrich en el podio 1960 Gastone Nencini (Italia) y enseñó un 1959 Federico Martín Bahamontes (España) dorsal con un 1958 Charly Gaul (Luxemburgo) número mágico 1957 Jacques Anquetil (Francia) para él FOTOS: EFE/AP 1956 Roger Walkowiak (Francia) 1955 Louison Bobet (Francia) que admirar desde atrás. -

Vainqueurs D'étapes Du Tour D'italie (Le Giro)
Vainqueurs d'étapes du Tour d'Italie (Le Giro) Vainqueurs d'étapes du Tour d'Italie (Le Giro) depuis 1909. Etapes du 08/05 au 30/05/2021 1 Torino - Torino, 8.6 km C.M.Individuel 2 Stupinigi - Novara, 179 km 3 Biella - Canale, 190 km 4 Piacenza - Sestola, 187 km 5 Modena - Cattolica, 177 km 6 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 160 km 7 Notaresco - Termoli, 181 km 8 Foggia - Guardia Sanframondi, 170 km 9 Castel di Sangro - Campo Felice, 158 km 10 L'Aquila - Foligno, 139 km 11 Perugia - Montalcino, 162 km 12 Siena - Bagno di Romagna, 212 km 13 Ravenna - Verona, 198 km 14 Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km 15 Grado - Gorizia, 147 km 16 Sacile - Cortina d'Ampezzo, 153 km 17 Canazei - Sega di Ala, 193 km 18 Rovereto - Stradella, 231 km 19 Abbiategrasso - Alpe di Mera, 176 km 20 Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km 21 Milano - Milano, 30.3 km C.M.Individuel 1ère étape. 1er Filippo Ganna (Ita) C.M.Individuel 2ème étape. 1er Tim Merlier (Bel) 3ème étape. 1er Taco Van Der Hoorn (Hol) 4ème étape. 1er Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) 5ème étape. 1er Caleb Ewan (Aus) 6ème étape. 1er Gino Mäder (Sui) 7ème étape. 1er Caleb Ewan (Aus) 8ème étape. 1er Victor Lafay (Fra) 9ème étape. 1er Egan Arley Bernal Gomez (Col) 10ème étape. 1er Peter Sagan (Svq) 11ème étape. 1er Mauro Schmid (Sui) 12ème étape. 1er Andrea Vendrame (Ita) 13ème étape. 1er Giacomo Nizzolo (Ita) 14ème étape. 1er Lorenzo Fortunato (Ita) 15ème étape. 1er Victor Campenaerts (Bel) 16ème étape. -

La Fausto Coppi
LA FAUSTO COPPI - Gran Fondo domenica 30 agosto 2009 pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media 1 168 FORNI ALESSANDRO Team Orobica Sen 1 06:35:52 06:35:23 30,35 2 191 ROUX MICHEL TEAM SCOTT- VELO Vet2 1 06:35:52 06:35:15 30,36 3 238 MAIELLO GIOVANNI AGISKO-VINER Vet1 1 06:39:12 06:38:39 30,10 4 189 MESTRE BRUNO TEAM SCOTT- VELO ITA Mas2 1 06:42:59 06:42:24 29,82 5 162 ORSI GABRIELE TEAM PIANETA BICI CERVELO Mas1 1 06:48:45 06:48:41 29,36 6 218 GIACOMELLI MANUEL ASD ORLANDI Mas1 2 06:51:47 06:51:09 29,19 7 14 GAGINO MATTEO CICLI ASTEGGIANO ITA Sen 2 06:52:00 06:51:40 29,15 8 1114 SCOLASTICO ANDREA RENOFIN SINTESI CASTELLI NWR Mas1 3 06:52:02 06:50:59 29,20 9 33 SPEYBROUCK FILIP TEAM DE ROSA BELGIO Mas1 4 06:55:00 06:54:19 28,96 10 214 MASSIMINO SILVIO WWW.XLIVIO.ORG Mas1 5 06:55:01 06:54:43 28,94 11 275 DUTTO MAURIZIO ASD VIGOR CYCLING TEAM Sen 3 06:59:53 06:59:34 28,60 12 952 DOGLIOTTI ENRICO TEAM EDILCASE 05 Mas2 2 07:02:02 06:59:54 28,58 13 287 HEFNER HEIKO STENGER Vet1 2 07:02:20 07:01:59 28,44 14 242 RENEDO GONZALES MARCO GS PASSATORE ITA Sen 4 07:04:11 07:03:53 28,31 15 236 CIURLINO TOMMASO MOIA BIKE TEAM Vet1 3 07:04:41 07:04:26 28,27 16 10 FOSSATI ALBERTO COLLINE OLTRE PO CYCLING PROMOT ITA Mas2 3 07:06:36 07:06:00 28,17 17 211 NEBIOLO ANDREA GS ALESSANDRO ERCOLE Mas2 4 07:06:37 07:06:02 28,17 18 181 POLETTI DANIELE FREE TEAM Mas2 5 07:07:23 07:06:59 28,10 19 279 FERRACIN DARIO VIGOR CYCLING TEAM ITA Vet1 4 07:07:23 07:06:57 28,11 20 895 LANDOLFI GIUSEPPE TEAM PIANETA BICI Vet2 2 07:14:01 07:13:05 27,71 21 657 CAPRA SIMONE -

Tour De France
MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Historie největších silničních etapových závodů Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. Bc. Michal Beneš Učitelství TV pro ZŠ a SŠ Brno, 2012 „Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Historie největších silničních etapových závodů zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury.“ Obsah Úvod ........................................................................................................................ 5 Jízdní kolo, historie, vývoj, první závody ............................................................... 7 Cyklistické komponenty, technika ........................................................................ 10 Tour de France ...................................................................................................... 12 Tour de France - obecný popis, charakteristika, vznik a vývoj závodu do 2. světovou války .................................................................................................. 12 Obecná charakteristika .................................................................................. 12 Události spojené se zaloţením .......................................................................... 14 První Tour de France ......................................................................................... 16 Pokračování