Il Capitale Umano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mappa-Schematica-Como.Pdf
CARTA DELLA RETE DEI TRASPORTI DI COMO MASLIANICO Dogana MASLIANICO Battisti 6 CH I MASLIANICO Municipio MASLIANICO Moja MASLIANICO Verdi Stabio Dogana Brogeda Lugano MASLIANICO Caronti Bellinzona 1 MASLIANICO Roma CHIASSO Volta Fumagalli Brogeda 44 MASLIANICO Cosio Quasimodo CERNOBBIO Sauro CHIASSO Stazione Brogeda 15 Fulda CERNOBBIO Montello ASF C28 Rovenna Dogana Ponte Chiasso Papini C10 Colico Franscini Deledda 41 Segantini Mognano C20 Lanzo Deledda 21 CERNOBBIO Ponte Nuovo C29 Tosnacco Fattori Salesiani Frank Zanella CERNOBBIO Mazzini Sagnino Campari Reina CERNOBBIO Manzoni 7 11 Bruno Pola Tibaldi 69 Calvi CERNOBBIO Viadotto A9 Friuli Bernasconi Pio XI Nievo 12 Pellico Tibaldi 51 CERNOBBIO Visconti Canova Tibaldi 6 C30 Bellagio C31 Palanzo CERNOBBIO Campanini C32 Piano del Tivano Spalato BRUNATE Capanna CAO T3 S. Zenone BRUNATE Faro Voltiano Cardina P Pontile Tavernola BRUNATE Scalini 58 BRUNATE Scalini 42 Como Funicolare V Alpini Villa Flori Como Alta Carescione T3 Cimitero Civiglio Roncate S. Stefano Ceresio Villa Sucota C10 C40 C46 C60 BRUNATE Funicolare C20 C45 C47 C62 D’Azeglio Terrazze Bignanico Stazione Autolinee Piscine Villa Olmo Pianazza Torchio Amendola Rosales Stazione Lago Bernasconi S.FERMO Monte Sasso Prudenziana Scalini C50 Brunate 47 C74 Valmorea Mameli C49 Monti Peregrini Lungolario Trento C43 Stazione Lago S.FERMO XXV Aprile C52 (V.Leopardi) Crispi 39 Sacrario S.FERMO Diaz Brunate 31 Bixio 41 Villa Olmo Brunate 13 Cavour Anzi Borgovico Crispi 53 Popolo S. Teresa Cavallotti Zezio S.FERMO Noseda Bixio 34 C74 Recchi Ospedale Valduce Verdi C71 Imbonati 1 S.FERMO Roma Masia - ACI Don Guanella Municipio S.FERMO Forno S. Caterina Dottesio Garibaldi S. Rocchetto S. -

C 74 Como - Uggiate - Valmorea
C_74 Como - Uggiate - Valmorea j Corse che si effettuano solo il lunedì k Corse che si effettuano solo il martedì l Corse che si effettuano solo il mercoledì m Corse che si effettuano solo il giovedì n Corse che si effettuano solo il venerdì o Corse che si effettuano solo il sabato 2 Circola nei giorni di Vacanze Scolastiche Invernali. 15 Circola solo il Sabato Scolastico. 45 Effettua deviazione a Lazzago via Dannunzio e Breccia via Varesina. D1 Prosegue per Olgiate Liceo Terragni. F6 Circola nei giorni di Lunedì e Venerdì scolastici. F7 Circola nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì scolastici. H5 Circola nei giorni di Lunedì, Venerdì e Sabato scolastici. U/ Corse che non effettuano servizio in ambito urbano a Como IL SERVIZIO E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE, IL 1° GENNAIO E IL 1° MAGGIO AREA SUD OVEST COMASCA - INVERNALE 2021/22 C_74 Como - Uggiate - Valmorea VETTORE ASF FERIALE INVERNALE 740002 740008 740014 740032 740018 740016 740026 740208 740030 740038 740040 740020 740048 740902 740052 740056 740062 Fer6 Scol Fer6 Scol Scol Scol Fer6 Scol Fer6 Scol Fer6 Sco5 Scol Scol Fer6 Fer6 Fer6 2 Como - P.zza Popolo - V.le Lecco 06.10 07.10 07.10 07.50 08.10 08.40 08.50 09.40 09.50 10.10 10.40 11.10 Como - Via Bertinelli 06.11 07.11 07.11 07.51 08.11 08.41 08.51 09.41 09.51 10.11 10.41 11.11 Como - Piazza Vittoria 06.14 07.14 07.14 07.53 08.14 08.43 08.53 09.43 09.53 10.13 10.44 11.13 Camerlata - Vecchio H S. -

Itinerari Culturali IT
Itinerari culturali. Cultural itineraries. Le curiosità storiche della regione. The historical curiosities of the region. I / E Basso Mendrisiotto | 1 2 | Basso Mendrisiotto La Regione da scoprire. Le curiosità storiche della regione. The historical curiosities of the region. Rendete il vostro soggiorno interessante! Five routes to add interest to your stay! Cinque itinerari storico culturali sono stati disegna- Five cultural routes in the region of Mendrisiotto and ti nella Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio Basso Ceresio have been developed to take you on per accompagnarvi nella scoperta dei diversi co- a journey of discovery through various towns and muni e villaggi, per svelare le eccellenze e le curio- villages where you will see the sights and curiosities sità legate a luoghi, avvenimenti e persone che of places, events and people, and learn about their hanno avuto ruoli, o svolto compiti, importanti. important roles. I testi inseriti nelle isole informative lungo i cinque Along the five routes, you will find information points itinerari sono stati redatti da tre storici che, in stretta with texts and pictures from both public and private collaborazione con Mendrisiotto Turismo ed i comu- archives, prepared by three historians, together ni della regione, si sono anche occupati della scelta with Mendrisiotto Tourism and the municipalities of del materiale fotografico, reperito in prevalenza da the region. As a rule, each information point has archivi pubblici e privati. Di regola, le isole didattiche three double-sided boards, and presents the route, inserite nelle tappe dei cinque itinerari, sono compo- the history of the place, three points of interest and ste da tre pannelli bifacciali e presentano ciascuno: a curiosity (excepting: Morbio Superiore, Sagno, l’itinerario, la storia del luogo-paese, tre eccellenze Scudellate, Casima, Monte and Corteglia). -

C 74 Como - Uggiate - Valmorea VETTORE ASF FERIALE ESTIVO Dal 09/06 Al 31/07 E Dal 1° Al 12/09
C 74 Como - Uggiate - Valmorea VETTORE ASF FERIALE ESTIVO dal 09/06 al 31/07 e dal 1° al 12/09 740004 740010 740212 740034 740214 740050 740058 740216 740218 740220 740084 740110 740128 740222 740224 740154 740236 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Fer6 Como - Popolo/V.le Lecco 06.20 07.10 07.40 08.10 09.10 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 14.10 15.10 16.10 16.40 17.10 Como - Verdi 06.21 07.11 07.41 08.11 09.11 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 14.11 15.11 16.11 16.41 17.11 Como - Vittoria (Piazza) 06.23 07.13 07.43 08.13 09.13 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 14.13 15.13 16.13 16.43 17.13 Como - Vecchio S.Anna 06.29 07.19 07.49 08.19 09.19 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 14.19 15.19 16.19 16.49 17.19 Como - Camerlata (Destra) 06.30 07.20 07.50 08.20 09.20 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 14.20 15.20 16.20 16.50 17.20 Como - Risorgimento 06.34 07.24 07.54 08.24 09.24 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 14.24 15.24 16.24 16.54 17.24 Como - Giotto 06.37 07.27 07.57 08.27 09.27 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 14.27 15.27 16.27 16.57 17.27 San Fermo - V Diaz / P. -
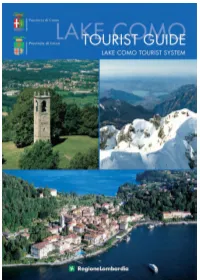
Tourist Guide.Pdf
COMACINA ISLAND PRESENTATION LAKE COMO TOURIST SYSTEM This tourist guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will find, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known places. Subdivided into geographical areas of lake, mountain and plain, the Guide describes the entire territory of Como and Lecco provinces; its history, architecture, art and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport. The section that describes the plains moves down towards the gentle Brianza hills, travelling through villas and castles and working valleys crossed by the River Adda, as well as parks full of treasures and wonderful views. -

Istituto Comprensivo Di Valmorea
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALMOREA ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DIRIGENTE SCOLASTICO BERNASCONI Giovanna Collaboratore Scuola Primaria Collaboratore Scuola Secondaria con funzione Vicaria ERBISINI Katia GIORDANI Lidia Fiduciari di plesso/responsabili sussidi Fiduciari di plesso ALBIOLO CATTONI Gabriella BINAGO CIAPPARELLI Giuseppina BINAGO COMUNE Carmela VALMOREA GIORDANI Lidia CAGNO SEMINATORE Stefania RODERO SCARFO’ Caterina SOLBIATE RIZZO Teresa VALMOREA CEREA M.Cristina FUNZIONI STRUMENTALI Scuola Primaria Scuola Secondaria Informatizzazione e innovazione Informatizzazione e innovazione 1 1 digitale digitale BOTTA Catia BOTTA Catia PIERGIOVANNI Luca PIERGIOVANNI Luca 2 Interventi e servizi per gli studenti 2 Interventi e servizi per gli studenti DVA- Prevenzione Disagio DVA-Prevenzione Disagio SEMINATORE Grazia Stefania SEMINATORE Grazia Stefania SCAGLIONE Vincenza SCAGLIONE Vincenza Interventi e servizi per gli studenti Interventi e servizi per gli studenti 3 3 Continuità/Orientamento Continuità/orientamento ARGONDIZZA Adriana CIAPPARELLI Giuseppina (Bin.) CECCATO M. Laura INCARICHI ISTITUZIONALI SEGRETARIO COLLEGIO DOCENTI LEGRAMANDI Paola COMITATO DI VALUTAZIONE Dirigente Scolastico BERNASCONI Giovanna Docente SEMINATORE Stefania Docente CANNAVACCIUOLO Claudia Docente ROVETTO Marilli Genitore LUCIANI Marco Genitore MACALUSO Roberto Membro esterno Dirigente Scolastico CAPOGROSSO Cosimo NUCLEO INTERNO AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO Dirigente Scolastico BERNASCONI Giovanna Docente Secondaria GIORDANI Lidia Docente -

Dgr 11 Luglio 2014
– 2 – Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 16 luglio 2014 • alla determinazione di un livello di classificazione sismica C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI maggiormente cautelativo rispetto a quello vigente; D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 • all’aggiornamento della classificazione del territorio lom- Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. bardo, anche in funzione del riordino delle disposizioni 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) della normativa regionale in materia di vigilanza e con- trollo sulle costruzione in Zona sismica; LA GIUNTA REGIONALE Preso atto che il Gruppo di Lavoro interdirezionale «Coordina- Richiamati: mento azioni sul rischio sismico», costituito con decreto n. 8448 • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento del 23 settembre 2013 del Direttore Generale della D.G. Sicu- di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni rezza, Protezione Civile e Immigrazione, ha elaborato, come da ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 verbale del 9 aprile 2014, una proposta di aggiornamento della marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 54 comma 1 lett. classificazione sismica regionale approvata dalla richiamata c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le d.g.r. 14964/2003; funzioni relative alla predisposizione della normativa tecni- Preso atto che le competenti Direzioni Generali: ca nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali • hanno valutato la nuova classificazione coerente con le per l’individuazione delle zone sismiche, delegando altre- specificità del territorio lombardo, anche in considerazio- sì alle Regioni le funzioni relative all’individuazione delle ne della presenza di aree fortemente antropizzate e del zone sismiche, alla formazione e all’aggiornamento degli patrimonio storico esistente, nonché con la classificazione elenchi delle medesime; delle Regioni confinanti; • la legge regionale 5 gennaio 2000 n. -

CARTOLINA Suggestivo Itinerario Il Vapore, Ferrovia Della Valmorea 2012
1 Treno : Composizione storica con locomotiva a vapore Tigerli E3/3 PARTENZA DA PARTENZA DA pt 11 .30 Mendrisio pt. 14.00 Malnate Olona pt. 11.45 S. Margherita pt. 14.30 Rodero / Valmorea Un suggestivo itinerario ferroviario pt. 12.00 Rodero / Valmorea pt. 14.40 S. Margherita ar. 12.30 Malnate Olona ar. 15.00 Mendrisio nel Parco della Valle del Lanza Malnate Olona – Valmorea – Mendrisio 2 Treno : Composizione storica con locomotiva a vapore Tigerli E3/3 Al traino di una sbuffante locomotiva a vapore del 1910, si PARTENZA DA PARTENZA DA percorrono i restanti 13 Km attivi (su 36 Km di ferrovia), il Parco Valle del Lanza per circa 8 Km, (riconosciuto dalla Regione pt 17.00 Mendrisio pt. 18.30 Malnate Olona Lombardia nel 2002, per una superficie circa 555 kmq). Si possono pt. 17.15 S. Margherita pt. 19.00 Rodero / Valmorea scorgere vecchi mulini dai nomi suggestivi: Bernasconi, Trotto, pt. 17.30 Rodero / Valmorea pt. 19.10 S. Margherita Tibis. Le chiese di S. Matteo, S. Martino a Malnate. Nella parte più ar. 18.00 Malnate Olona ar. 19.20 Mendrisio stretta della valle si può ammirare una meravigliosa formazione naturale di Gonfolite (formazioni rocciose datate tra l’Oligocene e il Miocene). In prossimità della stazione di Valmorea in posizione NEWS NEWS - CORSE SPECIALI dominante, si intravvede la chiesa Prepositurale di S. Biagio in Casanovalanza. Oltrepassando il confine di Stato, possiamo ammirare la chiesetta di S. Maria in Campo, detta anche S. SOLO SU PRENOTAZIONE. Per gruppi e comitive superiori alle 20 persone, nelle Margherita di origine romanica, qualche chilometro più avanti, dalla programmate corse stagionali, si effettuano corse speciali. -

Elenco Beneficiari Supplenze Brevi E Saltuarie Provvisorio
DATA DI ORE di ORE COGNOME NOME PROV SCUOLA ISTITUTO CORSO NASCITA SERVIZIO spettanti GAROFALO MARIA CARMELA 27/09/1975 CS ATA 36 PESSINA CORSO 4 65 BARONE FEDERICA 03/08/1993 CO INFANZIA 25 IC CANTU' 3 CORSO 7 12 MOLINARI DANIELA ANGELA 18/06/1979 VA INFANZIA 10,5 IC CANTU' 3 CORSO 1 11 ABATEGIOVANNI GIULIA 27/05/1985 NA PRIMARIA 24 IC MERONE CORSO 7 35 BAGARIN FRANCESCA 27/06/1988 CO PRIMARIA 24 IC PONTELAMBRO CORSO 1 59 BASCIALLA STEFANIA 13/06/1977 VA PRIMARIA 24 IC LURATE CACCIVIO CORSO 1 70 CANICATTI ISABEL 03/01/1989 CO PRIMARIA 24 IC FINO MORNASCO CORSO 5 26 CARBONE SARA 31/12/1994 CO PRIMARIA 24 IC COMO LORA/LIPOMO CORSO 1 42 CARPANI FEDERICA 26/10/1997 CO PRIMARIA 19,5 IC GRAVEDONA CORSO 1 57 CASARICO ELENA 03/09/1982 CO PRIMARIA 12,5 IC APPIANO GENTILE CORSO 1 37 CECCHETTO ANNAMARIA 13/03/1985 MI PRIMARIA 22 IC ROVELLASCA CORSO 1 64 CERIANI CHIARA 27/01/1986 MI PRIMARIA 24 IC TURATE CORSO 1 66 CONTE ALESSANDRA 10/09/1995 CO PRIMARIA 10 IC LURAGO D'ERBA CORSO 4 21 DONATORE MARTINA 07/05/1996 CO PRIMARIA 11 IC COMO BORGOVICO CORSO 4 23 DONES CRISTINA 24/03/1996 MI PRIMARIA 24 IC ROVELLASCA CORSO 1 37 FERRO MAURIZIO 01/05/1977 VA PRIMARIA 6 IC FENEGRO' CORSO 1 18 GIARRIZZO ROSINA MYRIAM 05/04/1995 CL PRIMARIA 24 IC VALMOREA CORSO 7 59 GIUDICI DENISE 03/03/1994 CO PRIMARIA 24 IC CANTU' 2 CORSO 1 38 INCARDONA SOFIA 14/12/1987 PA PRIMARIA 24 IC VALMOREA CORSO 7 25 MAGLIA ILARIA 24/06/1996 CO PRIMARIA 18 IC CAPIAGO INTIMIANO CORSO 1 31 MARINELLI MARCO 02/06/1986 RM PRIMARIA 24 IC APPIANO GENTILE CORSO 1 69 MORRA ANNA FRANCESCA 03/05/1978 -

Comuni Di Competenza
Competenza territoriale Conservatoria di Como Brenna Cassina Rizzardi Cremia Brienno Castelmarte Cucciago Brunate Castelnuovo Bozzente Cusino Bulgarograsso Castiglione D'intelvi Dizzasco Cabiate Cavallasca Domaso Cadorago Cavargna Dongo Cagno Cerano D'intelvi Dosso del Liro Campione D'italia Cermenate Drezzo Cantù Cernobbio Erba Capiago Intimiano Cirimido Faggeto Lario Carate Urio Claino con Osteno Faloppio Carbonate Colico Fenegrò Carimate Colonno Figino Serenza Carlazzo Como Fino Mornasco Cargo Consiglio di Rumo Garzeno Casasco d'intelvi Corrido Gera Lario Casnate con Bernate Costamasnaga Gerenzano Catasto in Rete SaS Servizi di Catasto – Conservatoria dei Registri Immobiliari – Camera di Commercio – P.R.A Vico san Giovanni 30 – 95047 Paternò CT www.catasto.it Germasino Luisago Oltrona Di San Mamette Gironico Lurago D'erba Orsenigo Grandate Lurago Marinane Ossuccio Grandola ed Uniti Lurate Caccivio Parè Gravedona Mariano Comense Peglio Griante Maslianico Pellio Intelai Guanzate Menaggio Pianello Del Lario Inverigo Merone Pigra Laglio Mezz’egra Plesso Laino Moltrasio Pognana Lario Lambrugo Monguzzo Ponna Lanzo D'intelvi Montano Lucino Pontelambro Lasnigo Montemezzo Porlezza Lenno Montorfano Ramponio Verna Lezzeno Mozzate Rodero Limido Com’asco Musso Rogeno Lipomo Nesso Ronago Livo Nibionno Rovellasca Locate Varesino Noverate Rovello Lo mazzo Olgiate Com’asco Sala Comacina Catasto in Rete SaS Servizi di Catasto – Conservatoria dei Registri Immobiliari – Camera di Commercio – P.R.A Vico san Giovanni 30 – 95047 Paternò CT www.catasto.it San Bartolomeo Val Solbiate Valmorea Cavargna Sorico Valrezzo San Fedele Intelai Stazzona Valsola San Fermo Della Tavernerio Veleno Battaglia Torno Veniano San Nazzaro Val Cavargna Tramezzo Vercana San Siro Trezzone Vertemate Con Minoprio Schignano Turate Villa Guardia Senna Comasco Uggiate Trevano Zelbio Catasto in Rete SaS Servizi di Catasto – Conservatoria dei Registri Immobiliari – Camera di Commercio – P.R.A Vico san Giovanni 30 – 95047 Paternò CT www.catasto.it . -

Rubrica Di Emergenza
PIANO COMUNALE di PROTEZIONE CIVILE ALLEGATO C RUBRICA per l’EMERGENZA AGGIORNAMENTO 2016 NOTA Il presente documento costituisce parte integrante del “PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” del Comune di Arosio aggiornamento 2016 - Versione 2 Comune di Arosio –Piano Comunale di Protezione Civile – RUBRICA per l’EMERGENZA – ALLEGATO C INDICE NUMERI GENERALI DI EMERGENZA I. Amministrazione dello Stato II. Forze di Polizia III. Corpo Forestale dello Stato IV. Croce Rossa Italiana - Anpas V. Servizio Sanitario VI. Soccorso Alpino VII. Vigili del Fuoco VIII. Protezione Civile IX. Comunità Montane Provinciali X. Servizi Tecnici Nazionali NUMERO UNICO EMERGENZA 112 4 NUMERI GENERALI DI EMERGENZA 5 I AMMINISTRAZIONE DELLO STATO Dipartimento di Protezione Civile 6 II FORZE DI POLIZIA 6 Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo U.T.G. 6 Questura - Polizia 112 6 Polizia Stradale 112 6 Polizia Ferroviaria 6 Polizia Postale 6 Polizia Locale comune di Arosio 6 Carabinieri 112 7 Guardia di Finanza 117 8 Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza 8 Forze Armate - Aeronautica – - Esercito 9 III CORPO FORESTALE DELLO STATO: Provincia di Como 10 CORPO FORESTALE DELLO STATO altre Province Lombardia 10 IV CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 115 11 Direzione Regionale Lombardia 11 VIGILI DEL FUOCO: Provincia di Como 11 VIGILI DEL FUOCO: altre Province Lombardia 12 V CROCE ROSSA ITALIANA 13 Comitato Provinciale CRI 13 I Comitati Locali della Provincia di COMO 13 aggiornamento 2016 - Versione 2 2 Comune di Arosio –Piano Comunale di Protezione Civile – RUBRICA per l’EMERGENZA – ALLEGATO C VI SOCCORSO ALPINO 13 VII SERVIZIO SANITARIO 14 SERVIZI SANITARI D’URGENZA 14 Soccorso S.S.U.Em. -

TOURIST GUIDE ASSOCIATIONS PROVINCE of COMO Associazione Guide E Accompagnatori Turistici Di Como E Provincia Phone No
TOURIST GUIDE www.lakecomo.com ISOLA COMACINA 01_ING_presen_sistema.indd 1 25/07/11 11:40 PRESENTATION This Tourist Guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will fi nd, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known Via Sirtori 5 - 22100 Como places. Phone No. + 39 031 2755551 Subdivided into geographical areas of lake, mountain Fax + 39 031 2755569 and plain, the Guide describes the entire territory of [email protected] www.provincia.como.it Como and Lecco provinces; its history, architecture, art www.lakecomo.com and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport.