27 2006 Gianti Delmastro Prime Notizie Sulla
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Additions, Deletions and Corrections to An
Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -

In Istria in Autumn
Go Slow…. In Istria in Autumn Naturetrek Tour Report 1 - 8 October 2019 Althea cannabina Flame Brocade Spiranthes spiralis Monkodonja Report and images by Paul Tout & Paul Harmes Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Go Slow…. In Istria in Autumn Tour participants: Paul Tout and Paul Harmes (leaders) with 14 Naturetrek clients Day 1 Tuesday 1st October Trieste Airport - Istarske Toplice (our hotel accommodation) Paul Harmes met up with the group at Stansted. Arriving at Trieste airport just after 5pm, we passed through passport control, collected our luggage and moved out into the Arrivals hall where we were met by Paul Tout. We were soon on our way towards Istria, passing through the very attractive historic centre of Trieste and on towards Koper-Capodistria, the main port in Slovenia. At the crossroads of Europe where the three main language groups meet (Romance, Slav and Germanic), the area is an ethnic mix with large areas of bi- (and even tri-) lingualism, so place names are usually hyphenated, made up of two languages. The weather was fine, sunny and warm. We took the road for the centre of Trieste along the Costiera. but no Alpine Swifts were visible. They nest in a colony on the cliffs beside the road and they continue to visit the colonies until mid-October but evidently, they were feeding high up in the fine weather. Passing through the centre of Trieste, the city looked very fine in the evening light, with its Viennese-style waterfront and main square, Piazza Unita d’Italia, the only one in Italy that opens onto the sea. -
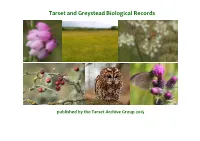
Tarset and Greystead Biological Records
Tarset and Greystead Biological Records published by the Tarset Archive Group 2015 Foreword Tarset Archive Group is delighted to be able to present this consolidation of biological records held, for easy reference by anyone interested in our part of Northumberland. It is a parallel publication to the Archaeological and Historical Sites Atlas we first published in 2006, and the more recent Gazeteer which both augments the Atlas and catalogues each site in greater detail. Both sets of data are also being mapped onto GIS. We would like to thank everyone who has helped with and supported this project - in particular Neville Geddes, Planning and Environment manager, North England Forestry Commission, for his invaluable advice and generous guidance with the GIS mapping, as well as for giving us information about the archaeological sites in the forested areas for our Atlas revisions; Northumberland National Park and Tarset 2050 CIC for their all-important funding support, and of course Bill Burlton, who after years of sharing his expertise on our wildflower and tree projects and validating our work, agreed to take this commission and pull everything together, obtaining the use of ERIC’s data from which to select the records relevant to Tarset and Greystead. Even as we write we are aware that new records are being collected and sites confirmed, and that it is in the nature of these publications that they are out of date by the time you read them. But there is also value in taking snapshots of what is known at a particular point in time, without which we have no way of measuring change or recognising the hugely rich biodiversity of where we are fortunate enough to live. -

A New Species of Pharmacis Hübner, 1820 from Spain with a Brief Review of the Genera Pharmacis and Korscheltellus Börner, 1920 (Lepidoptera, Hepialidae)
Nota Lepi. 41(2) 2018: 225–249 | DOI 10.3897/nl.41.26835 A new species of Pharmacis Hübner, 1820 from Spain with a brief review of the genera Pharmacis and Korscheltellus Börner, 1920 (Lepidoptera, Hepialidae) Axel Kallies1, Teresa Farino2 1 University of Melbourne, School of BioSciences, Parkville, 3010 Victoria, Australia; [email protected] 2 Apartado de Correos 59, 39570 Potes, Cantabria, Spain; [email protected] http://zoobank.org/B506D8D1-960D-4267-9140-2B1D8A11F449 Received 25 May 2018; accepted 21 September 2018; published: 9 November 2018 Subject Editor: Maria Heikkilä. Abstract. We here describe a new ghost moth (Hepialidae) species, Pharmacis cantabricus sp. n. from the Picos de Europa National Park, Cantabria, in northern Spain. The new species belongs to a group of mostly day-flying species that are restricted to the European Alps and some mountain ranges of southern Europe. Based on morphology and analysis of mitochondrial COI gene sequences, the new species is closely related to Pharmacis aemilianus (Constantini, 1911), an endemic of the Italian Apennines. However, Pharmacis cantabricus sp. n. can easily be distinguished from all related species based on both external and genitalic characters. We briefly review and illustrate all species of the genus Pharmacis Hübner, 1820 and discuss its relationship with the related genus Korscheltellus Börner, 1920. We reinstate Hepialus castillanus Oberthür, 1883 as a distinct species and transfer it to Korscheltellus (stat. rev., comb. n.). Resumen. Describimos una nueva especie de Hepialidae, Pharmacis cantabricus sp. n. del Parque Nacional de Picos de Europa, Cantabria, España septentrional. La nueva especie pertenece a un grupo de especies de vuelo diurno cuya distribución se limita a los Alpes europeos y otras cadenas montañosas de Europa merid- ional. -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize
Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

November 2019 Suzanne Burgess and Joanna Lindsay
November 2019 Suzanne Burgess and Joanna Lindsay Saving the small things that run the planet 0 Summary Pot beetles (genus Cryptocephalus) are a fascinating group of beetles. Of the 19 species found in the UK, eleven have been recorded in Scotland and seven of these have conservation designations. Scottish Natural Heritage (SNH) provided funding to Buglife through the ‘Spotting Pot Beetles’ project to run surveys and workshops to raise awareness and improve participants identification skills of the different species of pot beetles and their leaf beetle relatives. During the summer of 2019 surveys with volunteers were carried out at Kirkconnell Flow Site of Special Scientific Interest (SSSI) in Dumfries and Galloway to survey for the Six- spotted pot beetle (Cryptocephalus sexpunctatus) and at the Black Wood of Rannoch in Perthshire to survey for the Ten-spotted pot beetle (Cryptocephalus decemmaculatus). The 2019 surveys successfully found both target species, 17 adults of the Six-spotted pot beetles were recorded at Kirkconnell Flow, 15 of which were within a new area at the site, and Ten- spotted pot beetles were recorded in two areas of a new 1km square within the Black Wood of Rannoch. Guidance is provided within this document on managing habitat at both Kirkconnell Flow and Black Wood of Rannoch for their pot beetles to ensure the long term survival of both species in Scotland. 1 Contents Page Page 1. Introduction to pot beetles 3 2. Spotting Pot Beetles 5 3. Six-spotted pot beetle 5 3.1 Kirkconnell Flow 6 3.2 Six-spotted pot beetle volunteer survey 8 3.3 Habitat management recommendations for Six-spotted pot beetle 11 4. -

Fraßschäden an Buchenvoranbauten Durch Wurzelbohrer (Lepidoptera, Hepialidae) in Mittelfranken Sebastian Gößwein
Fraßschäden an Buchenvoranbauten durch Wurzelbohrer (Lepidoptera, Hepialidae) in Mittelfranken Sebastian Gößwein Abstract Kurzfassung | Im Jahr 2012 wurden im Raum Roth starke Ausfälle an Buchen - Feeding Damage on Beech voranbauten in Kiefernreinbeständen registriert. Die Fraßschäden an den Wurzeln Plants by Swift Moth entstanden durch Raupen von Wurzelbohrerarten (Hepialidae). Bei Grabungen in (Lepidoptera, Hepialidae) unterschiedlich stark geschädigten Beständen wurden die Raup en von zwei Arten Larvae in Central Franconia des Wurzelbohrers gefunden. Bei der ersten Art handelt es sich um den Heide- Significant mortality in plant- 2 ings of beech under pine kraut-Wurzelbohrer (Phymatopus hecta L.). Von diesem wurden auf den 24 m stands was observed in the Grabungs fläche 19 Exemplare gefunden. Die andere Art wurde wesentlich häufiger area of Roth, Central (178 Stück) und in drei verschiedenen Größen gefunden. Die Art konnte noch Franconia, in 2012. Feeding nicht eindeutig bestimmt werden. In Frage kommen der Adlerfarn-Wurzelbohrer damage on roots was caused (Korscheltellus fusconebulosa DeGeer), der Ampfer-Wurzelbohrer (Triodia sylvina by larvae of swift moths L.), der Schwärzliche Wurzelbohrer (Pharmacis carna Denis & Schiffermüller) sowie (Hepialidae). Soil samples in der Kleine Hopfen-Wurzelbohrer (Korscheltellus lupulina L.). Die Anzahl der ge - differently damaged stands fundenen Raupen ist auf den Flächen sehr unterschiedlich. Sie reicht von zehn showed that two species oc- curred. The first one is gold Raupen bis zu 101 Raupen pro 6m²-Grabungsfläche. swift (Phymatopus hecta L.). On a total of 24 m² of Schlüsselworte | Phymatopus hecta, Hepialus fusconebulosa, Hepialus sylvina, Buche, sampled area, 19 specimens Wurzelschädigung were found. The second species was considerably more abundant (178 specimens found); moreover, these larvae occurred in m Jahr 2012 wurden im Raum Roth klimatoleranten Mischwäldern umgebaut three different sizes. -

Forstschutz Aktuell Nr. 59 - Abstracts
Forstschutz Aktuell Nr. 59 - Abstracts First Experiences with Wood Packaging-Inspections in Austria according Implementing Decision 2013/92/EU Hannes Krehan st Since 1 of April 2013 member states are obliged to implement a new decision of the EU commission concerning import- inspection of wood packaging material (WPM) imported from China with granite stone consignments at fixed frequencies before customs clearance. In the first year, till 14 April 2014, 451 shipments (1.374 containers) were inspected by the Austrian plant protection organization. In 44 cases (9.8 %), non-compliance was reported. In 38 consignments, living stages of Cerambycidae were found, among them Anoplophora glabripennis, Trichoferus campestris and Apriona germari. The Pine Wood Nematode - a Contingency Plan for Austria Christian Tomiczek The Pine Wood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus) is one of the most dangerous invasive pests in the world. It is native to the American continent, where it causes no damage to native conifers. Its introduction to Japan, China, South Korea, Mexico as well as to Portugal mainland, Spain and Madeira, however, led to tremendous damage. Therefore, all EU member states are obliged by the EU directive 2012/535/EU to issue a contingency plan by the end of 2013. A working group developed the contingency plan for Austria that lists emergency measures in case of a pine wood nematode infestation. 'Herpotrichia' Needle Browning of Silver Fir - An Error and its Revision Heinz Butin For many years, the fungus Nematostoma parasiticum (syn. Herpotrichia parasitica) has been considered to be the cause of 'needle browning' of Silver fir (Abies alba Mill.). Recent literature has increasingly expressed doubts in the view taken by Robert Hartig (1884). -

Artenbericht 2005 Herausgeber: Nationalpark Harz Oderhaus 1 37444 St
Artenbericht 2005 2 3 Bearbeitungsstand: Dezember 2004 Artenbericht 2005 Herausgeber: Nationalpark Harz Oderhaus 1 37444 St. Andreasberg www.nationalpark-harz.de Bearbeiterinnen: M. Hullen, Dr. A. Kirzinger Titelfoto: Junge Raufußkäuze, Thomas Stephan, GEO-Tag der Artenvielfalt 4 Inhaltsverzeichnis 1VORWORT........................................................................................................................... 5 2ARTENERFASSUNG IM NATIONALPARK HARZ (NIEDERSACHSEN)............................. 6 3ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ARTENLISTEN...................................................................... 8 3.1GEFÄHRDUNGSSTATUS................................................................................................... 8 3.1.1ROTE LISTEN (RL).............................................................................................................. 8 3.1.2BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BAV).............................................................................. 10 3.1.3FFH-RICHTLINIE................................................................................................................ 10 3.1.4EUROPÄISCHE VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE (EVR)....................................................................... 11 4TIERE................................................................................................................................. 12 4.1MAMMALIA – SÄUGETIERE............................................................................................ 12 4.2AVES – VÖGEL......................................................................................................... -

Brachyptery and Aptery in Lepidoptera
Vol. 2 No. 1 1991 HEPPNER: Brachyptery 11 TROPICAL LEPIDOPTERA, 2(1): 11-40 BRACHYPTERY AND APTERY IN LEPIDOPTERA J. B. HEPPNER1 Florida State Collection of Arthropods Bureau of Entomology, DPI, FDACS, P.O. Box 147100, Gainesville, FL 32614, USA ABSTRACT.- The conditions of wing reduction (brachyptery) and loss of wings (aptery), and modifications thereof, are reviewed across all known families of Lepidoptera where this has been observed in either males or females, or both sexes. Brachyptery or aptery is known in 35 families of Lepidoptera, including families or species where a kind of brachyptery is only evident as extreme wing reduction of the hind wings. Examples from most families known to have brachyptery of some form are illustrated among 147 figures. KEY WORDS: Alucitidae, Anthelidae, Arctiidae, Blastobasidae, Brachodidae, Carposinidae, Cosmopterigidae, Cossidae, Ctenuchinae, Elachistidae, Epiplemidae, Eriocottidae, Gelechiidae, genetics, Geometridae, Glyphipterigidae, Gracillariidae, Hepialidae, Heterogynidae, Himantopteridae, Lasiocampidae, Lecithoceridae, Limacodidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Lyonetiidae, Noctuidae, Notodontidae, Oecophoridae, Oxychirotidae, Papilionidae, Psychidae, Pterophoridae, Pyralidae, Scythrididae, Sesiidae, Somabrachyidae, Sphingidae, Syntominae, Thyretidae, Thyrididae, Tineidae, Tortricidae, Yponomeutidae, Zygaenidae. Brachyptery (wing reduction) or aptery (loss of wings) is an unusual phenomenon in adults among several orders of insects (La Greca, 1954). In Lepidoptera, brachyptery has been reviewed -

HOHESTEINHOHESTEIN ZOOLOGISCHEZOOLOGISCHE UNTERSUCHUNGENUNTERSUCHUNGEN N E G N U H C U S R
HESSEN www.hmulv.hessen.de ländlichen RaumundVerbraucherschutz Hessisches MinisteriumfürUmwelt, 7/2.1 N O Naturwaldreservate in Hessen Hohestein – Zoologische Untersuchungen Naturwaldreservate inHessen Naturwaldreservate ländlichen RaumundVerbraucherschutz Hessisches MinisteriumfürUmwelt, ZOOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN HOHESTEIN ZOOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN HOHESTEIN N N O O HESSEN 7 7/2.1 / 2 . 1 Naturwaldreservate in Hessen 7/2.1 Hohestein Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 1 Günter Flechtner Wolfgang H. O. Dorow Jens-Peter Kopelke mit Beiträgen von Beate Löb & Sabine Kiefer (Aves) Jörg Römbke (Lumbricidae) Petra M. Th. Zub (Lepidoptera) Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 41 Impressum Herausgeber: Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Mainzer Str. 80 65189 Wiesbaden Landesbetrieb Hessen-Forst Bertha-von-Suttner-Str. 3 34131 Kassel Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Grätzelstr. 2 37079 Göttingen http://www.nw-fva.de Dieser Band wurde in wissenschaftlicher Kooperation mit dem Forschungsinstitut Senckenberg erstellt. – Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 41 – Titelfoto: Hummeln sind dominante Elemente der Waldbiozönosen. Sie treten selbst in feuchtkühlen Habitaten mit zahlreichen Arten und in hohen Individuendichten auf. (Foto: Jens-Peter Kopelke) Layout: Eva Feltkamp, 60486 Frankfurt Druck: Elektra Reprographischer Betrieb GmbH, 65527 Niedernhausen Umschlaggestaltung: studio zerzawy agd, 65329 Hohenstein Wiesbaden, November 2006 ISBN 3–89274–257–X Zitiervorschlag: -

Investigating the Mechanisms Behind Moth Declines: Plants, Land-Use and Climate
Investigating the Mechanisms Behind Moth Declines: Plants, Land-use and Climate Dan Blumgart August 2020 A thesis submitted to Lancaster University in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Project supervisors James Bell Rothamsted Insect Survey, Rothamsted Research Rosa Menendez Lancaster Environment Centre, Lancaster University Marc Botham Centre for Ecology and Hydrology 1 Declaration and funding statement I declare that the work presented in this thesis is my own and has not been submitted elsewhere for the award of a degree of Doctor of Philosophy. The illustrations at the beginning of each chapter are also my own work. This work was funded by the Natural Environment Research Council (NERC) through the Envision Doctoral Training Program awarded to Lancaster University and Rothamsted Research. Dan Blumgart 22nd August 2020 ii Acknowledgements Thanks go firstly to James Bell, Rosa Menendez and Marc Botham, my three supervisors. Thanks to James, for his encouragement and enthusiasm, and all the hours spent with me going through my work. Thank to Rosa for being so quick and thorough with corrections and feedback, and thanks to Marc for pushing me to think more deeply about the ways of moths. Thanks to everyone in the Rothamsted Insect Survey team, especially to Chris Shortall for answering my endless questions about the database and to Mike Hall for all the woodwork he did for me, as well as all the advice on everything DIY-related. Thanks to Butterfly Conservation for support and to the Centre for Ecology and Hydrology for hosting me several times and arranging my stay at Hillesden Farm.