Il Mito Dell'ausonia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prog Salvaguardia E Tutela Del Parco Aurunci
PROGETTO SALVAGUARDIA E TUTELA DEL PARCO DEI MONTI AURUNCI e PARCO DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia ENTE 1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) PARCO DEI MONTI AURUNCI SU00204 2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto ……………………………………… 3) Eventuali enti coprogettanti 3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto ……………………………………………… 3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti di accoglienza PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI - SU00347 Numero N. Sede di attuazione Comune Codice sede Nominativo Olp volontari PARCO AURUNCI Sede centrale Domenico Sepe Uff. serv. CAMPODIMELE 1 171032 2 Marzella Antonio Vigilanza e comunicazione PARCO AURUNCI CAMPODIMELE 2 Sede centrale Domenico Sepe Uff.promozione 171030 1 Tedeschi Antonio PARCO AURUNCI 3 ITRI 171043 2 Ialongo Giampaolo Vivaio del Parco Uff. patrimonio ambientale PARCO AURUNCI Soscia Fulvio 4 ITRI 171041 2 Vivaio del Parco Centro visitatori parco Antonio PARCO AURUNCI Monumento Naturale Settecannelle Mola della 5 FONDI 171019 2 Izzi Fabrizio Corte Uff. educaz. Ambientale PARCO AURUNCI Centro studi De Santis Ufficio promozione- FORMIA 6 171015 2 Buttaro Raffaele archivio dei Monti Aurunci PARCO AURUNCI SPIGNO 7 171020 4 Tarantino Marco Museo Naturalistico SATURNIA PARCO AURUNCI Palazzo Spinelli-Museo del Carsismo(percorso ESPERIA 8 171022 6 Perrella Paolo grotta carsica) 2 PARCO AURUNCI Monticelli Esperia-Uff. -

By Agabus Bipustulatus (Insecta, Coleoptera, Dytiscidae)
Predation on Italian newt larva, Lissotriton italicus (Amphibia, Caudata, Salamandridae), by Agabus bipustulatus (Insecta, Coleoptera, Dytiscidae) LUIGI CORSETTI1 and GIANLUCA NARDI2 1 Via Adige, 45. I-04100 Latina, Italy. 2 Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale - Corpo Forestale dello Stato. Strada Mantova, 29. I-46045 Marmirolo (MN), Italy. 2 Author for correspondence: [email protected] ABSTRACT — Predation of a larva of Lissotriton italicus by adults of a diving beetle (Agabus bipustulatus) on the Aurunci Mountains (central Italy, Latium region) is recorded. This is the first identified invertebrate predator of this Italian endemic newt. The possible role of this beetle in the local demographic control of the newt is briefly discussed. HE Italian Newt, Lissotriton italicus (Peracca), (Latina province, Castelforte, Monte Siola W-SW Tpreviously referred to the genus Triturus slope, 240 m a.s.l). No other amphibians occurred (Rafinesque), is endemic to central and southern in the pond, which was probably feebly trickle fed Italy. The northern most limits of its distribution by a very small spring. In this pond about 15 adults include an oblique area extended from the Ancona of a predaceous diving beetle, Agabus bipustulatus province (Marches region) South to Lepini (Linnaeus) (Insecta, Coleoptera, Dytiscidae) were Mountains (Latium region, Rome province), on observed attacking a larva of the Italian Newt. The the Adriatic and Tyrrhenian sides of the Apennines, larva was initially attacked by a single beetle that respectively (Corsetti et al., 2005; Balletto, 2006; was quickly followed by the others and was Scillitani et al., 2006; Scillitani & Tripepi, 2007). devoured, almost completely, in about 10-15 It is a euryoecious species living in a wide range seconds. -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

A HISTORY of the PELASGIAN THEORY. FEW Peoples Of
A HISTORY OF THE PELASGIAN THEORY. FEW peoples of the ancient world have given rise to so much controversy as the Pelasgians; and of few, after some centuries of discussion, is so little clearly established. Like the Phoenicians, the Celts, and of recent years the Teutons, they have been a peg upon which to hang all sorts of speculation ; and whenever an inconvenient circumstance has deranged the symmetry of a theory, it has been safe to ' call it Pelasgian and pass on.' One main reason for this ill-repute, into which the Pelasgian name has fallen, has been the very uncritical fashion in which the ancient statements about the Pelasgians have commonly been mishandled. It has been the custom to treat passages from Homer, from Herodotus, from Ephorus, and from Pausanias, as if they were so many interchangeable bricks to build up the speculative edifice; as if it needed no proof that genealogies found sum- marized in Pausanias or Apollodorus ' were taken by them from poems of the same class with the Theogony, or from ancient treatises, or from prevalent opinions ;' as if, further, ' if we find them mentioning the Pelasgian nation, they do at all events belong to an age when that name and people had nothing of the mystery which they bore to the eyes of the later Greeks, for instance of Strabo;' and as though (in the same passage) a statement of Stephanus of Byzantium about Pelasgians in Italy ' were evidence to the same effect, perfectly unexceptionable and as strictly historical as the case will admit of 1 No one doubts, of course, either that popular tradition may transmit, or that late writers may transcribe, statements which come from very early, and even from contemporary sources. -

The Ancient People of Italy Before the Rise of Rome, Italy Was a Patchwork
The Ancient People of Italy Before the rise of Rome, Italy was a patchwork of different cultures. Eventually they were all subsumed into Roman culture, but the cultural uniformity of Roman Italy erased what had once been a vast array of different peoples, cultures, languages, and civilizations. All these cultures existed before the Roman conquest of the Italian Peninsula, and unfortunately we know little about any of them before they caught the attention of Greek and Roman historians. Aside from a few inscriptions, most of what we know about the native people of Italy comes from Greek and Roman sources. Still, this information, combined with archaeological and linguistic information, gives us some idea about the peoples that once populated the Italian Peninsula. Italy was not isolated from the outside world, and neighboring people had much impact on its population. There were several foreign invasions of Italy during the period leading up to the Roman conquest that had important effects on the people of Italy. First there was the invasion of Alexander I of Epirus in 334 BC, which was followed by that of Pyrrhus of Epirus in 280 BC. Hannibal of Carthage invaded Italy during the Second Punic War (218–203 BC) with the express purpose of convincing Rome’s allies to abandon her. After the war, Rome rearranged its relations with many of the native people of Italy, much influenced by which peoples had remained loyal and which had supported their Carthaginian enemies. The sides different peoples took in these wars had major impacts on their destinies. In 91 BC, many of the peoples of Italy rebelled against Rome in the Social War. -

The Roman Army's Emergence from Its Italian Origins
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Carolina Digital Repository THE ROMAN ARMY’S EMERGENCE FROM ITS ITALIAN ORIGINS Patrick Alan Kent A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2012 Approved by: Richard Talbert Nathan Rosenstein Daniel Gargola Fred Naiden Wayne Lee ABSTRACT PATRICK ALAN KENT: The Roman Army’s Emergence from its Italian Origins (Under the direction of Prof. Richard Talbert) Roman armies in the 4 th century and earlier resembled other Italian armies of the day. By using what limited sources are available concerning early Italian warfare, it is possible to reinterpret the history of the Republic through the changing relationship of the Romans and their Italian allies. An important aspect of early Italian warfare was military cooperation, facilitated by overlapping bonds of formal and informal relationships between communities and individuals. However, there was little in the way of organized allied contingents. Over the 3 rd century and culminating in the Second Punic War, the Romans organized their Italian allies into large conglomerate units that were placed under Roman officers. At the same time, the Romans generally took more direct control of the military resources of their allies as idea of military obligation developed. The integration and subordination of the Italians under increasing Roman domination fundamentally altered their relationships. In the 2 nd century the result was a growing feeling of discontent among the Italians with their position. -

1 Duae Patriae
Cambridge University Press 978-0-521-86331-5 - Ethnic Identity and Aristocratic Competition in Republican Rome Gary D. Farney Excerpt More information 1 duae patriae ᨠᨘᨠ 1. Partners in Empire “Because the Romans mixed with themselves Etruscans, Latins, and Sabines and regard there to be one blood from all of these, they have made one body from these various parts and one people composed of 1 all of them.” In this way, the second-century a.d. Roman historian Florus describes the traditional ethnic composition of Rome at the beginning of his chapter on the Social War, Rome’s war with its Italian allies which began in 91 b.c. Although he would judge the actions of the rebels to be criminal, he goes on to criticize Rome for not sharing 2 the citizenship with the deserving peoples of Italy sooner. After all, as a contemporary of Florus would echo in his history, the Italian upper classes had only led the revolt because they had desired to be “partners 3 in empire instead of subjects.” Implicit within these comments is that the Latins, Sabines, and Etruscans had dared to hope this before and had succeeded, and now they were the dominant groups within the Roman state. Their dominance, however, seemed to exclude men from dozens of other groups from a place in the state, notably Rome’s allies that had exerted so much on its behalf. 1 Epit. 2.6.1: quippe cum populus Romanus Etruscos, Latinos Sabinosque sibi miscuerit et unum ex omnibus sanguinem ducat, corpus fecit ex membris et ex omnibus unus est. -

The Emergence of Archival Records at Rome in the Fourth Century BCE
Foundations of History: The Emergence of Archival Records at Rome in the Fourth Century BCE by Zachary B. Hallock A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Greek and Roman History) in the University of Michigan 2018 Doctoral Committee: Professor David Potter, Chair Associate Professor Benjamin Fortson Assistant Professor Brendan Haug Professor Nicola Terrenato Zachary B. Hallock [email protected] ORCID iD: 0000-0003-0337-0181 © 2018 by Zachary B. Hallock To my parents for their endless love and support ii Acknowledgements I would like to thank Rackham Graduate School and the Departments of Classics and History for providing me with the resources and support that made my time as a graduate student comfortable and enjoyable. I would also like to express my gratitude to the professors of these departments who made themselves and their expertise abundantly available. Their mentoring and guidance proved invaluable and have shaped my approach to solving the problems of the past. I am an immensely better thinker and teacher through their efforts. I would also like to express my appreciation to my committee, whose diligence and attention made this project possible. I will be forever in their debt for the time they committed to reading and discussing my work. I would particularly like to thank my chair, David Potter, who has acted as a mentor and guide throughout my time at Michigan and has had the greatest role in making me the scholar that I am today. Finally, I would like to thank my wife, Andrea, who has been and will always be my greatest interlocutor. -
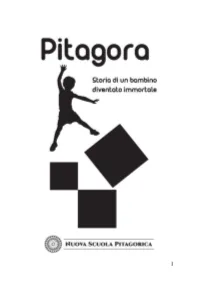
PYTHAGORAS-The-Story-Of-A-Child
1 Title: Pitagora – Storia di un bambino diventato immortale © 2019 Nuova Scuola Pitagorica – all rights reserved Editing by Marco Tricoli Cover by Giuseppe Santoro Translation by Gabriella Mongiardo www.nuovascuolapitagorica.org 2 Pythagoras The story of a child that became immortal Nuova Scuola Pitagorica 3 Foreword This publication was born with the intention of stimulating awareness of the Pythagorean phenomenon and of opening a debate in society and particularly in the world of school edu- cation. It represents a starting point for a series of activities in various fields to schedule over the years. The contents of this text are the result of studies and analyses conducted within the New Pythagorean School, thanks to the contribution of its members spread around the world. The New Pythagorean School is an organization open to eve- ryone, without any preclusion and without precepts or pre- conceived truths to give: a school of free thought. It conducts activities in various cultural sectors, from the artistic to the lit- erary one, giving particular emphasis to ethical philosophy as a universal guide to righteous behavior in order to create a bet- ter world. 4 Pythagoras The story of a child that became immortal There once was a beautiful and intelligent child, with long flowing hair that sometimes took on a blond shade and at other times a copper one. Thus, he was called the long-haired. His eyes were a sea green and light blue sky color and his body was thin and in shape. He was also very curious and continu- ously asked questions about everything. -

Quaternary International 425 (2016) 198E213
Quaternary International 425 (2016) 198e213 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary International journal homepage: www.elsevier.com/locate/quaint Geomorphological features of the archaeological marine area of Sinuessa in Campania, southern Italy * Micla Pennetta a, , Corrado Stanislao a, Veronica D'Ambrosio a, Fabio Marchese b, Carmine Minopoli c, Alfredo Trocciola c, Renata Valente d, Carlo Donadio a a Department of Earth Sciences, Environment and Resources, University of Naples Federico II, Largo San Marcellino 10, 80138 Napoli, Italy b Department of Environment, Territory and Earth Sciences, University of Milano Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, Italy c Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development e ENEA, Portici Research Centre, Piazzale Enrico Fermi 1, Granatello, 80055 Portici, NA, Italy d Department of Civil Engineering, Design, Building, Environment, Second University of Naples, Via Roma 8, 81031 Aversa, CE, Italy article info abstract Article history: Submarine surveys carried out since the '90s along the coastland of Sinuessa allowed us to draw up a Available online 6 June 2016 geomorphological map with archaeological findings. Along the sea bottom, 650 m off and À7 m depth, a Campanian Ignimbrite bedrock was detected: dated ~39 kyr BP, its position is incompatible with the Keywords: current sea level. Towards the northern edge of the shoal, a depressed area with 24 cubic elements in Coastal geomorphology concrete was surveyed. These artefacts (pilae) are typical of Roman maritime structures widespread Geoarchaeology along the southernmost Phlegrean coast. Beachrocks and accessory landforms at the same depth of Sedimentology bedrock suggest that this was emerging and attended by man in Roman times, even for activities related Sea level change Italy to port facilities. -

The Roman Republic S
P1: IML/SPH P2: IML/SPH QC: IML/SPH T1: IML CB598-FM CB598-Flower-v3 August 26, 2003 18:47 The Cambridge Companion to THE ROMAN REPUBLIC S Edited by Harriet I. Flower Princeton University iii P1: IML/SPH P2: IML/SPH QC: IML/SPH T1: IML CB598-FM CB598-Flower-v3 August 26, 2003 18:47 published by the press syndicate of the university of cambridge The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom cambridge university press The Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru,UK 40 West 20th Street, New York, ny 10011-4211, USA 477 Williamstown Road, Port Melbourne, vic 3207, Australia Ruiz de Alarcon´ 13, 28014 Madrid, Spain Dock House, The Waterfront, Cape Town 8001, South Africa http://www.cambridge.org C Cambridge University Press 2004 This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published 2004 Printed in the United States of America Typeface Bembo 11/13 pt. System LATEX 2ε [tb] A catalog record for this book is available from the British Library. Library of Congress Cataloging in Publication Data The Cambridge Companion to the Roman Republic / edited by Harriet I. Flower. p. cm. Includes bibliographical references and index. isbn 0-521-80794-8 – isbn 0-521-00390-3 (pb.) 1. Rome – History – Republic, 510–30 b.c. I. Flower, Harriet I. dg235.c36 2003 937.02 – dc21 2003048572 isbn 0 521 80794 8 hardback isbn 0 521 00390 3 paperback iv P1: IML/SPH P2: IML/SPH QC: IML/SPH T1: IML CB598-FM CB598-Flower-v3 August 26, 2003 18:47 Contents S List of Illustrations and Maps page vii List of Contributors ix Preface xv Introduction 1 HARRIET I. -

Feeding Strategies of Co-Occurring Newt Species Across Different Conditions of Syntopy: a Test of the “Within-Population Niche Variation” Hypothesis
diversity Article Feeding Strategies of Co-occurring Newt Species across Different Conditions of Syntopy: A Test of the “Within-Population Niche Variation” Hypothesis Jennifer Mirabasso 1 , Alessandra M. Bissattini 1, Marco A. Bologna 1, Luca Luiselli 2, Luca Stellati 1 and Leonardo Vignoli 1,* 1 Department of Sciences, Roma Tre University, Viale Marconi, 446, 00146 Rome, Italy; [email protected] (J.M.); [email protected] (A.M.B.); [email protected] (M.A.B.); [email protected] (L.S.) 2 IDECC, Institute for Development, Ecology, Conservation and Cooperation, via G. Tomasi di Lampedusa 33, 00144 Rome, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-06-57336411; Fax: +39-06-57336321 Received: 15 April 2020; Accepted: 5 May 2020; Published: 7 May 2020 Abstract: Intraspecific trait variation in generalist animals is widespread in nature, yet its effects on community ecology are not well understood. Newts are considered opportunistic feeders that may co-occur in different syntopic conditions and represent an excellent model for studying the role of individual feeding specialization in shaping the population dietary strategy. Here, we investigated the diet of three newt species from central Italy occurring in artificial habitats in different coexistence conditions to test the predictions of the niche width (NW) variation hypotheses. Population NW did not vary among species and between presence and absence of coexisting species. An overall positive relationship between individual specialization and population NW was observed. However, this pattern was disrupted by the condition of syntopy with newt populations showing an individual NW variation invariant with population NW in presence of coexisting species, whereas it was larger in populations occurring alone.