I Canali Di Milano Seconda Parte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Riapertura E La Valorizzazione Dei Navigli Come Progetto Di Paesaggio
La riapertura e la valorizzazione dei navigli come progetto di paesaggio e nuovo modello di vivibilità urbana per Milano ri-vista Antonello Boatti Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano [email protected] 01 2017 Abstract La riapertura dei navigli di Milano è una sfida ambiziosa per una città che vuole cambiare nel se- gno della vivibilità e della sostenibilità, e in particolare per Milano, che ha basato la sua storia e il suo sviluppo nel corso dei secoli come città d’acqua. La ricerca esplora tutto ciò che può essere coinvolto dalla riapertura del sistema dei navigli a Milano, dal nord-est della città dove il Marte- sana è ancora aperto, verso il centro della città, dove il canale ritrova il percorso circolare storico (la Cerchia dei Navigli) sul suo lato orientale, fino a raggiungere la Darsena recentemente riatti- vata per ricongiungersi alla fine con i navigli Pavese e Grande. Un progetto ambientale capace di garantire la navigabilità a piccole imbarcazioni, per un nuovo paesaggio e per il recupero dell’i- dentità storica di Milano, tutto proteso al futuro, ma anche pieno di poesia come raccontano le splendide immagini realizzate dall’Associazione Multiverso. Parole chiave Riapertura dei navigli a Milano, città d’acqua, un progetto ambientale, nuovo paesaggio, navi- gabilità. Abstract The reopening of the canals in Milan is an ambitious challenge for a city that wants to change the sign of liveability and sustainability, and in particular for Milan which has based its story and its development over the centuries on being a city of water. -

Immobili, Il Nuovo Skyline Di Milano Traina La Crescita
Relazioni con i media– tel. 02.8515.5224, 335 6413321 www.milomb.camcom.it Immobili, il nuovo skyline di Milano traina la crescita Porta Nuova supera anche Venezia – Monforte Vale di più la casa a Milano, 5 mila € al mq +1,4% in sei mesi e +2,6% in un anno Bene la cerchia semicentrale, trainata da Porta Nuova, Cinque Giornate, Pagano, Porta Genova, Sarpi, la zona Universitaria intorno al Politecnico (Abruzzi), Statale (Tribunale), Cattolica (Leopardi), le zone verdi intorno al Castello, Sarpi, Leopardi, Trenno, le zone economiche, da Inganni a Baggio Quinto Romano per i nuovi milanesi Case nuove, la top ten delle crescite, circa +5% in sei mesi: Ripamonti -Vigentino, Tribunale – Cinque Giornate (da 4 ai 7 mila euro al mq per case vecchie o nuove), Repubblica – Porta Nuova (dai 5 mila ai 10 mila euro per vecchio e nuovo), Greco (intorno ai 3 mila euro), Turro e Precotto (3 mila euro), Sarpi e Procaccini (4 – 5 mila euro), Baggio – Quinto Romano (da mille a 3 mila euro per vecchio e nuovo), Abruzzi - Romagna (5 mila), Gallaratese – Trenno ( 3 mila), Leopardi - Boccaccio – Pagano (cresce il nuovo a 8 mila). Le case vecchie da ristrutturare crescono più del 5% a Inganni – S. Cristoforo (mille euro), Istria – Maciachini (2 mila euro), Solferino – Garibaldi (5 mila), Conca del Naviglio - Porta Genova (3 mila), Fiera – Sempione (3 mila) Repubblica – Porta Nuova supera Venezia - Monforte , + 5% in sei mesi per il nuovo, quasi 10 mila euro al mq e +5% anche per le case vecchie da ristrutturare che valgono 5 mila euro al mq. -

01PAR Relazione Norme Attua
Piano di Governo PGT del Territorio Piano per le Attrezzature Religiose Relazione e norme di attuazione Elaborato emendato a seguito della delibera di adozione n. 2 Seduta Consiliare 5 marzo 2019 Marzo 2019 Relazione 1. Premessa 5 2. Inquadramento normativo e percorso procedurale 6 3. L'istruttoria delle istanze pervenute 7 4. Il Piano per le attrezzature religiose 8 5. Elenco delle attrezzature religiose 10 5.1 Le attrezzature religiose esistenti 10 5.2 Le attrezzature religiose di nuova previsione 18 5.3 Le aree di proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature religiose 18 Norme di attuazione art. 1 Natura e contenuti 19 art. 2 Elaborati del Piano per le attrezzature religiose 19 art. 3 Ambito di applicazione 19 art. 4 Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione 20 art. 5 Disciplina delle attrezzature religiose esistenti 20 Relazione 5 1. Premessa 1 cfr. artt. 2, 3, 8 e 19 – Costituzione della Repubblica Nel rispetto del dettame costituzionale1 e legislativo2, il Comune di Milano italiana si impegna a riconoscere e garantire concretamente i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiedere 2 Legge n. 1159/1929, recante “Disposizioni l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul stabilendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’or- medesimi” e il R.D. -

Nuclei Di Identita' Locale (NIL)
Schede dei Nuclei di Identità Locale 3 Nuclei di Identita’ Locale (NIL) Guida alla lettura delle schede Le schede NIL rappresentano un vero e proprio atlante territoriale, strumento di verifica e consultazione per la programma- zione dei servizi, ma soprattutto di conoscenza dei quartieri che compongono le diverse realtà locali, evidenziando caratteri- stiche uniche e differenti per ogni nucleo. Tale fine è perseguito attraverso l’organizzazione dei contenuti e della loro rappre- sentazione grafica, ma soprattutto attraverso l’operatività, restituendo in un sistema informativo, in costante aggiornamento, una struttura dinamica: i dati sono raccolti in un’unica tabella che restituisce, mediante stringhe elaborate in linguaggio html, i contenuti delle schede relazionati agli altri documenti del Piano. Si configurano dunque come strumento aperto e flessibile, i cui contenuti sono facilmente relazionabili tra loro per rispondere, con eventuali ulteriori approfondimenti tematici, a diverse finalità di analisi per meglio orientare lo sviluppo locale. In particolare, le schede NIL, come strumento analitico-progettuale, restituiscono in modo sintetico le componenti socio- demografiche e territoriali. Composte da sei sezioni tematiche, esprimono i fenomeni territoriali rappresentativi della dinamicità locale presente. Le schede NIL raccolgono dati provenienti da fonti eterogenee anagrafiche e censuarie, relazionate mediante elaborazioni con i dati di tipo geografico territoriale. La sezione inziale rappresenta in modo sintetico la struttura della popolazione residente attraverso l’articolazione di indicatori descrittivi della realtà locale, allo stato di fatto e previsionale, ove possibile, al fine di prospettare l’evoluzione demografica attesa. I dati demografici sono, inoltre, confrontati con i tessuti urbani coinvolti al fine di evidenziarne l’impatto territoriale. -

Pgtpiano Di Governo Del Territorio
Piano di Governo PGT del Territorio Piano dei Servizi Schede dei Nuclei di Identità Locale Dal NIL 31 al NIL 44 Elaborato modificato a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni, dei pareri degli Enti e dei municipi e dell’accoglimento delle proposte di modifica presentate dal C.C. Adozione: Delibera n. 2 Seduta Consiliare del 05.03.2019 Approvazione: Delibera n. 34 Seduta Consiliare del 14.10.2019 Pubblicazione: BURL Serie Avvisi e Concorsi n... Ottobre 2019 Schede dei Nuclei di Identità Locale 3 Nuclei di Identita’ Locale (NIL) Guida alla lettura delle schede Le schede NIL rappresentano un vero e proprio atlante territoriale, strumento di verifica e consultazione per la programma- zione dei servizi, ma soprattutto di conoscenza dei quartieri che compongono le diverse realtà locali, evidenziando caratteri- stiche uniche e differenti per ogni nucleo. Tale fine è perseguito attraverso l’organizzazione dei contenuti e della loro rappre- sentazione grafica, ma soprattutto attraverso l’operatività, restituendo in un sistema informativo, in costante aggiornamento, una struttura dinamica: i dati sono raccolti in un’unica tabella che restituisce, mediante stringhe elaborate in linguaggio html, i contenuti delle schede relazionati agli altri documenti del Piano. Si configurano dunque come strumento aperto e flessibile, i cui contenuti sono facilmente relazionabili tra loro per rispondere, con eventuali ulteriori approfondimenti tematici, a diverse finalità di analisi per meglio orientare lo sviluppo locale. In particolare, le schede NIL, come strumento analitico-progettuale, restituiscono in modo sintetico le componenti socio- demografiche e territoriali. Composte da sei sezioni tematiche, esprimono i fenomeni territoriali rappresentativi della dinamicità locale presente. -

Elenco Schede NIL Per I Municipi Elenco Schede
4 Piano dei Servizi Elenco schede NIL Elenco schede NIL per i municipi 01. Duomo 54. Muggiano Municipio 1 Municipio 5 Municipio 8 02. Brera 55. Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia 1. Duomo 5. P.ta Vigentina - P.ta Lodovica 59. Tre Torri 03. Giardini P.ta Venezia 56. Forze Armate 2. Brera 6. P.ta Ticinese - Conca del Naviglio 64. Trenno 04. Guastalla 57. San Siro 3. Giardini Porta Venezia 36. Scalo Romana 65. Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo 05. P.ta Vigentina - P.ta Lodovica 58. De Angeli-Monte Rosa 4. Guastalla 34. Chiaravalle - Lampugnano 06. P.ta Ticinese - Conca del Naviglio 59. Tre Torri 7. Magenta- S. Vittore 37. Morivione 66. QT8 07. Magenta- S.Vittore 60. Stadio - Ippodromi 8. Parco Sempione 38. Vigentino - Q.re Fatima 67. Portello 08. Parco Sempione 61. Quarto Cagnino (5. Vigentina) 39. Quintosole 68. Pagano 09. P.ta Garibaldi - P.ta Nuova 62. Quinto Romano (6. Ticinese) 40. Ronchetto delle Rane 69. Sarpi 10. Stazione Centrale - Ponte Seveso 63. Figino (68. Pagano) 41. Gratosoglio - Q.re Missaglia 70. Ghisolfa 11. Isola 64. Trenno (69. Sarpi) - Q.re Terrazze 71. Villapizzone - Cagnola - Boldinasco 12. Maciachini-Maggiolina 65. Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano 42. Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta 72. Maggiore - Musocco - Certosa 13. Greco - Segnano 66. QT8 Municipio 2 - Conca Fallata 73. Cascina Merlata 14. Niguarda - Ca’ Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi 67. Portello 10. Stazione Centrale - Ponte Seveso 43. Tibaldi 74. Roserio 15. Bicocca 68. Pagano 16. Gorla - Precotto 85. -

La Riapertura Dei Navigli Nel Sistema Della Mobilità Milanese
CAP 05| La riapertura dei Navigli nel sistema della mobilità milanese 05 LA RIAPERTURA DEI NAVIGLI NEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ MILANESE 5.1 La riapertura dei Navigli nel sistema della mobilità milanese 5.2 Verifica per singoli tratti degli schemi di circolazione | 76 CAP 05| La riapertura dei Navigli nel sistema della mobilità milanese 5.1 LA RIAPERTURA DEI NAVIGLI NEL non con la certezza che questa non determini ulteriori gravi congestioni sulla rete viaria milanese. SISTEMA DELLA MOBILITÀ MILANESE Tuttavia, la continua diminuzione del traffico in entrata nella Giorgio Goggi e Veronica Indelicato Cerchia dei Navigli registratasi nel tempo e la diminuzione del traffico nelle aree centrali determinata dai recenti provvedimenti di Ormai sono del tutto caduti i motivi -veri o presunti- a suo tempo ingresso a pagamento consentono di affrontare il problema con addotti per giustificare la chiusura dalla Cerchia interna dei Navigli ottime probabilità di riuscita. milanesi, ovvero la necessità di far spazio al traffico creando una nuova strada di circonvallazione intorno al centro storico. L’esigenza, quindi, di sottoporre la Cerchia dei Navigli ad una stringente limitazione del traffico è quindi precedente ed Il continuo allargamento dell’area urbana milanese, anche fuori dai indipendente, anche se conforme, rispetto al progetto di riapertura confini municipali, ha inglobato quest’ambito nella ristretta dei Navigli. porzione centrale della città; inoltre la crescita e l’addensarsi delle relazioni hanno fatto sì che quest’area possa essere meglio servita e Quest’esigenza va in direzione di un aumento di qualità della vita, resa maggiormente accessibile con modi di trasporto che fatto estremamente importante soprattutto nel clima di consentono l’accesso ad una più larga massa di cittadini (il trasporto competizione tra aree urbane che caratterizza il mondo pubblico e la pedonalità). -
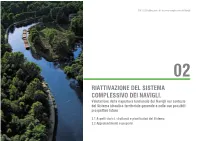
Navigli Lombardi
CAP 02| Riattivazione del sistema complessivo dei Navigli 02 RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DEI NAVIGLI. Valutazione della riapertura funzionale dei Navigli nel contesto del Sistema idraulico-territoriale generale e nelle sue possibili prospettive future 2.1 Aspetti storici, strutturali e pianificatori del Sistema 2.2 Approfondimenti e proposte Coordinamento: G. Rosti, M. Proverbio Contributo tecnico-scientifico: M. Brown, L. Burzilleri, G. Franchina, M. Fossati, P. Lubrano, R. Rosso, S. Sibilla. Collaborazione e contributi: F. Bianchi, B. Colombo, L. Lossi, F. C. Nagari, C. Sciandra, M. Stancati, R. Palermo, B. Ripamonti, A. Verzeletti. Contributo per progetti europei: V. Bombelli | 58 CAP 02| Riattivazione del sistema complessivo dei Navigli PREMESSA validissimo contributo alla costruzione di una vera e propria “Smart City 1”. I cinque referendum ambientali del giugno 2011, che hanno visto la partecipazione di una enorme volontà popolare che si è espressa chiaramente per rendere migliore la città di Milano sia sotto il profilo della qualità della vita, che sotto quello di un vero sviluppo sostenibile, hanno decretato un profondo segnale di svolta a tutte le amministrazioni istituzionali ed una volontà di sostanziale cambiamento drastico rispetto ad un drammatico passato che ha fatto scempio del nostro territorio in tutte le sue componenti: acque, aria, suolo. Uno dei filoni secondo i quali tale volontà si è espressa riguarda in particolare il recupero di un pezzo importante della storia e della capacità progettuale dei nostri predecessori e concerne la rimessa in funzione di quello spettacolare e, primo in Europa, sistema di trasporto fluviale, i Navigli, il cui percorso progettuale e realizzativo è iniziato addirittura nel 1200, per perfezionarsi tra il 1400/1500 anche con il contributo del genio leonardesco e per concludersi FIG. -

3.2.3.2 La Riapertura Della Cerchia
avere tiranti d’aria e acqua compatibili con la navigazione e con 3.2.3.2 La riapertura della cerchia l’attraversamento in superficie (ponti, passerelle); che il canale fosse compatibile con la realizzanda linea 4 della Metropolitana Milanese Andrea Cassone, Giada Longhi, Ekaterina Solomatin. (M4). Da via Senato a via Edmondo De Amicis In subordine si è proceduto a verificare che la riproposizione dei canali: fosse un'opera sostenibile in termini economici; fosse soste- nibile ambientalmente, cioè fosse compatibile con ambienti urbani Il capitolo tratterà della Cerchia da via Senato a via De Amicis, fino già equilibrati; fosse adeguata all’obbiettivo di creare uno spazio ur- all’immissione in via Conca del Naviglio. Alla presentazione gene- bano lineare di importanza strategica per la riqualificazione del rale farà seguito una sintetica presentazione dei tratti specifici, arti- cuore della città; fosse infine effettivamente riqualificante, cioè in colata per parti secondo, il seguente ordine: grado di rendere a Milano la sua qualità di città d’acqua, e con essa, la sua memoria. Via Senato (CN2) Via San Damiano – Via Uberto Visconti Di Modrone (CN3) Nelle pagine seguenti, tratto per tratto si potrà leggere il racconto Via Francesco Sforza (CN4) libero delle verifiche effettuate; fin d’ora si anticipa che esse hanno dato tutte esito positivo, sebbene alcune necessitino di ulteriori ap- Via Santa Sofia (CN5) profondimenti, in una eventuale, auspicata, fase preliminare e defi- Via Molino delle Armi (CN6) nitiva del progetto. In particolare si ritiene che le strade d’alzaia, i percorsi pedonali e ciclopedonali proposti – le strutture del traffico Via Edmondo De Amicis (CN7) in una parola – richiedano uno studio della mobilità generale che permetta di ridurre al massimo il traffico veicolare nell’intera cer- La verifica di fattibilità della riapertura – o più esattamente ripropo- chia. -

Corso Di P.Ta Ticinese 32, Milano
Corso di P.ta Ticinese 32, Milano Nel centrale quartiere di porta ticinese, di fronte alle colonne di san lorenzo e all’omonima basilica sorge, in un contesto unico, gate central: abitazioni di prestigio, costruite in classe energetica a, con le più innovative tecnologie. Il contesto. Porta Ticinese è una delle zone più ambite dai milanesi e non solo. È un quartiere unico, a pochi passi dal centro di Milano, dove storia e cultura si fondono con il design e la contemporaneità. Un’area della città viva e affascinante, che da anni attrae giovani e famiglie, offrendo servizi esclusivi. Un luogo dove vivere il divertimento e il relax, immergendosi nell’atmosfera dei tipici e vivaci locali presenti nella zona o godendosi la tranquillità delle ampie aree verdi circostanti. Gate Central, nel cuore di Porta Ticinese, si trova a pochi passi dal centro di Milano e da alcune meraviglie storiche. Le colonne di San Lorenzo, l’omonima Basilica, gli scavi romani dell’adiacente Conca del Naviglio e Porta Ticinese stessa rendono quest’area una delle più affascinanti della città. Porta Ticinese è in continua evoluzione tra storia e attualità. Un quartiere dove aree residenziali, che conservano ancora il fascino delle case e delle botteghe della vecchia Milano, convivono con aree commerciali che accolgono le più innovative start up e gli studi di design più cool della città. I numerosi locali e ristoranti presenti nella zona richiamano la vita e l’allegria delle serate milanesi. I numerosi locali e ristoranti presenti nella zona richiamano la vita e l’allegria delle serate milanesi. -

Repertorio A, Allegato Al Piano, Che Identifica Le Informazioni Rappresentate Sulla Tavola
100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 Allegati PTCP – Provincia di Milano Introduzione La necessità di disporre di una base conoscitiva del sistema dei limiti alle trasformazioni territoriali si è tradotta nella predisposizione di due elaborati ricognitivi di supporto per la gestione del PTCP: una tavola del "Sistema dei vincoli paesistici e ambientali" in scala 1:60.000 (Tavola 5) in cui sono individuate le aree e gli elementi soggetti a specifiche previsioni di legge di tipo paesistico–ambientale e il presente Repertorio A, allegato al Piano, che identifica le informazioni rappresentate sulla tavola. I vincoli individuati in cartografia, Tav.5 e Tav.5bis, e nel presente allegato sono da considerarsi ricognitivi. E’ necessario pertanto, ai fini della puntuale verifica della loro cogenza, riferirsi agli specifici atti amministrativi emanati dalle Autorità competenti. Il Repertorio A nasce come risposta a quanto previsto dalle norme regionali in merito ai contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: L.R. 1/2000, L.R. 18/1997, D.G.R. n. VI/47670 del 29 dicembre 1999 "Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del PTCP". Ogni oggetto è stato georeferenziato cartograficamente (ovvero localizzato sulla carta tecnica regionale, come previsto dalla Regione Lombardia, in scala 1:10.000). I dati presi in esame costituiscono il repertorio conoscitivo necessario a definire in prima battuta il sistema delle precondizioni alla trasformazione del territorio. La metodologia seguita per individuare i beni oggetto di vincolo è di seguito illustrata. Elementi ed ambiti vincolati ex D.Lgs. -

L'acqua a Mediolanum. Controllo E Gestione Delle Risorse Idriche in Età Romana
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Dottorato di Ricerca in Scienze del Patrimonio letterario, artistico e ambientale XXIX Ciclo L'ACQUA A MEDIOLANUM. CONTROLLO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN ETÀ ROMANA S.S.D. L-ANT/07 Tesi di Dottorato di: Ilaria FRONTORI Matr. R10600 Tutor: Chiar.mo Prof. Fabrizio SLAVAZZI Coordinatore: Chiar.mo Prof. Alberto Valerio CADIOLI Anno Accademico 2015 – 2016 Indice - Introduzione p. 1 1. Contesto idrogeologico e ambientale: acque in superficie e nel sottosuolo 1.1 La situazione attuale p. 4 1.2 Il panorama antico p. 9 2. Studi pregressi e nuove prospettive di indagine p. 11 3. I fossati di Mediolanum: 3.1 Il Seveso, il Nirone e l’alimentazione del fossato p. 17 3.2 Il fossato di età tardorepubblicana - Via del Lauro p. 27 - Piazza Fontana p. 30 - Via Larga e aree adiacenti p. 38 - Via Disciplini e via del Don p. 47 - Via Cardinal Caprara p. 50 - Via Cusani, via Ponte Vetero p. 53 - Via Brisa, via Vigna, via Morigi p. 56 - Largo Carrobbio p. 63 3.3 Il fossato di età massimianea p. 66 - Via Croce Rossa p. 68 - Via Montenapoleone p. 74 - Via Borgogna p. 80 - Via Verziere p. 84 - Corso Magenta, via Ansperto p. 86 3.4 La Vepra, la Vettabbia e il deflusso del fossato p. 90 3.5 La Vepra p. 91 - Via S. Vincenzo, via S. Calocero p. 93 - Piazza Resistenza Partigiana p. 97 - Piazza Vetra, ex via dei Vetraschi p. 100 3.6 La Vettabbia p.