3.2.3.2 La Riapertura Della Cerchia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
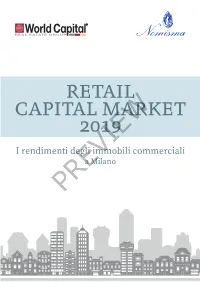
Retail Capital Market 2019
R RETAIL CAPITAL MARKET 2019 SOMMARIO INTRODUZIONE 03 I RENDIMENTI Titoli di stato (2008-2018) 04 Titoli di stato vs Immobili (2008-2019) 05 Immobili commerciali per zona (High Street) 06 Immobili commerciali per zona (Secondary Street) 07 Immobili commerciali per categoria (zona Isola) 10 Immobili commerciali per categoria (zona Garibaldi Repubblica) 12 Immobili commerciali per categoria (zona Centrale) 14 Immobili commerciali per categoria (zona Loreto) 16 Immobili commerciali per categoria (zona Porta Romana) 18 Immobili commerciali per categoria (zona Navigli) 20 Immobili commerciali per categoria (zona Sempione) 22 CONTEXT SCORE NOMISMA Context Score Nomisma a Milano 08 Context score - Isola 11 Context score - Garibaldi Repubblica 13 Context score - Centrale 15 Context score - Loreto 17 Context score - Porta Romana 19 Context score - Navigli 21 Context score - Sempione 23 SOMMARIO INTRODUZIONE INTRODUZIONE 03 Il Report Capital Market, realizzato da World Capital per l’anno 2019, fornisce una panoramica dei rendimenti immobiliari per gli edifici commerciali della città di Milano. E’ proposto un confronto tra i rendimenti dei titoli di stato italiani (BTP 3/5 anni, CTZ 3 anni, BOT 6/12 mesi) e quelli degli immobili ad uso commerciale, per comprendere analogie e differenze. I RENDIMENTI Alcune zone del comune di Milano vengono poi analizzate nel dettaglio, con un‘attenzione specifica Titoli di stato (2008-2018) 04 verso le diverse tipologie di edifici terziari: GDO, sportelli bancari, servizi (farmacie, accessori, ecc.), Titoli di stato vs Immobili (2008-2019) 05 negozi e ristoranti. Le aree prese in esame sono Isola, Garibaldi Porta Nuova, Stazione Centrale, Immobili commerciali per zona (High Street) 06 Loreto, Porta Romana, Navigli, Sempione - che vengono definite “secondary street” per distinguerle dalle celebri high street dello shopping meneghino. -

Yesmilano. Continua Il Viaggio Nei SEGUITECI Quartieri Porta Romana, Lambrate, 4,525 2,369 119 Ortica, Navigli E Ticinese Fans Follower Iscritti
GAIAITALIA.COM Data 23-07-2021 Pagina Foglio 1 / 3 31.3 C Milano venerdì, Luglio 23, 2021 Gaiaitalia.com Notizie Torino Bologna Genova Radiogaiaitalia.com HOME MILANO ALTRE CITTÀ POLITICA CULTURA MILANO & LOMBARDIA Home Milano YesMilano. Continua il viaggio nei SEGUITECI quartieri Porta Romana, Lambrate, 4,525 2,369 119 Ortica, Navigli e Ticinese Fans Follower Iscritti Gaiaitalia.com Notizie Milano 23 Luglio 2021 31 0 Pubblicità Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ULTIME NOTIZIE L'OPINIONE MILANO Dunque Green Pass uguale “dittatura sanitaria” e pistola in tasca uguale “legittima difesa”… ho capito bene? di Redazione, #Milano MILANO YesMilano. Continua il Nel mese di luglio la campagna di YesMilano porta avanti la valorizzazione di Porta viaggio nei quartieri Porta Romana, Lambrate, Ortica e la zona Navigli e Ticinese. Il filo conduttore del racconto è Romana, Lambrate, Ortica, Navigli e Ticinese l’acqua in città, dove tuffarsi, simbolicamente o realmente, nel mese più caldo dell’anno. 35° FESTIVAL MIX MILANO Novità del mese la collaborazione con Parenti on Air che ha sviluppato un’idea di Andrée La 35ª edizione del MiX Festival arriva su Nexo+. Ruth Shammah e prodotto, sotto la cura di Tommaso Bernabei e Marco Armando Piccinini Dal 16 al 19 settembre 129258 una serie di cortometraggi inediti sui quartieri, coinvolgendo alcuni grandi attori che calcano la scena del teatro Franco Parenti in questa estate. Il primo cortometraggio BRESCIA “Ortica” vede Alessandro Haber alla scoperta dell’Ortica, storico quartiere milanese oggi Montirone (BS), l’Onda noto per essere un museo a cielo aperto, con opere murarie che ritraggono volti e storia Bianca ancora in piazza Fond. -

Lezione 12 – Da Montenapoleone in Duomo (Dia 1) Lasciamo Ancora Una Volta Montenapoleone Per Entrare a Sinistra in Via S
Lezione 12 – Da Montenapoleone in Duomo (Dia 1) Lasciamo ancora una volta Montenapoleone per entrare a sinistra in via S. Andrea dove al n, 6 troviamo (Dia 2) il PALAZZO MORANDO ATTENDOLO BOLOGNINI, al cui interno si trovano la COLLEZIONE COSTUME MODA E IMMAGINE e il MUSEO DI MILANO. Pare che la contessa Bolognini fosse addirittura l'amante del re Umberto I; Edificato nel ‘500, il Palazzo fu residenza di alcune tra le più importanti famiglie milanesi, tra cui i Villa che nel corso del XVIII secolo fecero eseguire sull’edificio numerosi interventi, conferendogli l’impronta rococò, che tuttora lo caratterizza. Nei primi anni del XX secolo la dimora, che allora apparteneva alla famiglia De Cristoforis, fu acquistata dai coniugi Gian Giacomo Morando Bolognini e Lydia Caprara Morando Bolognini, che riempirono le sale con un’ampia collezione di arredi e dipinti. (dia 3) La Contessa Lydia, rimasta vedova nel 1919, morì senza eredi nel 1945 e nel testamento volle donare la sua residenza milanese, con tutto il contenuto, al Comune di Milano, che secondo l’uso dell’epoca smembrò le collezioni per unirle a quelle di altri edifici comunali. Nel 1958, dopo un lungo restauro dovuto agli ingenti danni subiti dall’edificio durante la II Guerra Mondiale, Palazzo Morando aprì le sue porte al pubblico col nome di “Museo di Milano”. Al piano nobile fu collocata la collezione Beretta (tuttora esposta), una ricca raccolta di dipinti e disegni dedicata all’iconografia urbanistica e architettonica di Milano, anch’essa divenuta di proprietà del Comune grazie a una donazione. Al pian terreno invece trovò sistemazione nel 1963 il Museo della Guerra e della Resistenza, poi denominato Museo di Storia Contemporanea. -

Parco Sempione
Sesto San Giovann FSi Cormano SESTO SAN GIOVANNI BRESSO PARCO NORD Cormano Brusuglio Sesto Rondò TANGENZIALE NORD VIALE FULVIO TESTI RHO Comasina Bruzzano NOVATE Bignami 500 m A8 MILANO LAGHI A4 TORINO MILANO 500 m Sesto Marelli Rho A.V./S.F.R. Affori FNM Ponale Affori FNM PARCO NORD Cologno Sud VIA GIUDITTA PASTA Rho Fiera Quarto Oggiaro VIALE MONZA VIA ARGANINI VIA SBARBARO BIGLIA DEI CONTI VIA BRUSUGLIOVIA CHIANCIANO VIALE ESPERIA VIALE FULVIO TESTI Villa San Giovanni VIA ZANOLI Bicocca VIA PELLEGRINO ROSSI TEATRO VIA GREGOROVIUS ARCIMBOLDI A4 TORINO MILANO VIA VOCHIERI VIA ARMELLINI VIA E. MAJORANA VIA MONETA VIA Affori Centro VIA CAMOVALI VIA RACCONIGIMONTEROTONDO VIA SEMERIA VIA CHIASSERINI VIA VIA DON CARLO PORRO VIA GILINO Greco VIA BALZAC POZZUOLI VIA VIA PASTRO VIA CISLAGHI MPANA CORRADO VIA GRIOLI CA VIA SCIALOIA VIA BETTINI VIA CIRI VIA REBORA VIA DEI VIA Pirelli VIA ZAMBRINI VIA PONTE NUOVO VIA COZZI DUMAS VIA PEDRONI È VIA DEMONTE VIA BREDA VIA RUCELLAI I ZZIN VIA GIROLAVIA SANTHIÀ Precotto VIA LINATI A VIA DON LUIGI GUANELLA COR VIA PAVESE VIA VIA VIPITENO VIA APELLE VIA BAZZARO VIA TÜKORI VIA VIGNATI VIA VIA VAL GARDENA VIA SCARSELLINI VIA FRATELLI BRESSAN VIA POMPEO VIA CIALDINI VIA VAL DI FIEMME VIA G. B. VIA SAN BASILIO PALLETTA VIA MONCALIERI VIA VAL DI NON VIA BAVENO Cascina Gobba Pero VIA VAL MARIA VIALE DELL’INNOVAZIONE VIA EMILIO DE MARCHI VIA MAMBRETTI MAIRA VIA ERODOTO PIAZZALE B. GRAZIOLI VIA SALVATORE PIANELL MARTESANA VIA VAL CAMONICA VIA DEL RICORDO VIA CANDOGLIA VIA CHERASCO VIA I VIA EMILIO N I DE MARTINO L VIA TRIBONIANO VIA BELLAZZI VIA FRACASTORO VIA DON VIA VIA BREDA VIA CARLO MORESCHI VIALE CÀ GRANDA L VIA CAROLI VIA ARISTOTELE CIRENEI VIA PALIZZI VIA DON G. -

La Riapertura E La Valorizzazione Dei Navigli Come Progetto Di Paesaggio
La riapertura e la valorizzazione dei navigli come progetto di paesaggio e nuovo modello di vivibilità urbana per Milano ri-vista Antonello Boatti Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano [email protected] 01 2017 Abstract La riapertura dei navigli di Milano è una sfida ambiziosa per una città che vuole cambiare nel se- gno della vivibilità e della sostenibilità, e in particolare per Milano, che ha basato la sua storia e il suo sviluppo nel corso dei secoli come città d’acqua. La ricerca esplora tutto ciò che può essere coinvolto dalla riapertura del sistema dei navigli a Milano, dal nord-est della città dove il Marte- sana è ancora aperto, verso il centro della città, dove il canale ritrova il percorso circolare storico (la Cerchia dei Navigli) sul suo lato orientale, fino a raggiungere la Darsena recentemente riatti- vata per ricongiungersi alla fine con i navigli Pavese e Grande. Un progetto ambientale capace di garantire la navigabilità a piccole imbarcazioni, per un nuovo paesaggio e per il recupero dell’i- dentità storica di Milano, tutto proteso al futuro, ma anche pieno di poesia come raccontano le splendide immagini realizzate dall’Associazione Multiverso. Parole chiave Riapertura dei navigli a Milano, città d’acqua, un progetto ambientale, nuovo paesaggio, navi- gabilità. Abstract The reopening of the canals in Milan is an ambitious challenge for a city that wants to change the sign of liveability and sustainability, and in particular for Milan which has based its story and its development over the centuries on being a city of water. -

Vicende Collezionistiche, Oblio E Fortuna Del Ritratto Di Giovane Donna Di Piero Del Pollaiolo Del Museo Poldi Pezzoli, Fra Otto E Novecento
Vicende collezionistiche, oblio e fortuna del Ritratto di giovane donna di Piero del Pollaiolo del Museo Poldi Pezzoli, fra Otto e Novecento Il Ritratto di giovane donna di Piero del Pollaiolo del Museo Poldi Pezzoli, intorno al quale è stata ideata questa mostra, ha conosciuto una notevolissima fama a partire dalla fine degli anni settanta dell’Ottocento, quando viene acquisito da Gian Giacomo Poldi Pezzoli, della cui collezione diventa ben presto una delle opere più apprezzate e rinomate1. Già allo scadere del XIX secolo, per spontanea elezione della critica specialistica e dei visitatori, assurge al ruolo di vera e propria icona del Museo Poldi Pezzoli, aperto al pubblico nel 1881. È a partire da questi anni che il dipinto assume una valenza emblematica, che mantiene ancora oggi, quale simbolo ideale del fascino esercitato dal Rinascimento fiorentino. Fino all’ottavo decennio dell’Ottocento era però, abbastanza sorprendentemente, quasi del tutto sconosciuto, e si fa una certa fatica a rintracciarne delle menzioni, ancorché fugaci, nelle fonti manoscritte e a stampa. Nei decenni centrali dell’Ottocento il dipinto era già custodito a Milano, nella collezione Borromeo, come attesta Giovanni Battista Cavalcaselle: lo studioso lo raffigura, insieme ad alcune altre opere della collezione di Giberto VI (1815-1885), che evidentemente lo avevano colpito e che egli riteneva particolarmente rilevanti, in uno dei suoi tipici schizzi di riproduzione eseguiti a penna, che reca in calce la dicitura “Casa Borromeo / Milano”: nel foglio, non datato, sono appuntate dallo studioso, come d’abitudine, alcune osservazioni: il ritratto è “rilevato”; i “capelli”, su cui compaiono delle “perle”, sono “rilevati ad asfalto”; la veste, dal “panneggio naturale”, è di colore “verde”, com e il fondo del quadro; la manica è di colore “rosso” e decorata con “fiori”; il dipinto, in cui anche il “fondo” è “rilevato”, è eseguito con uno “smalto denso” e secondo Cavalcaselle “sente del Pietro [ della Francesca] ma è più duro”2. -

Immobili, Il Nuovo Skyline Di Milano Traina La Crescita
Relazioni con i media– tel. 02.8515.5224, 335 6413321 www.milomb.camcom.it Immobili, il nuovo skyline di Milano traina la crescita Porta Nuova supera anche Venezia – Monforte Vale di più la casa a Milano, 5 mila € al mq +1,4% in sei mesi e +2,6% in un anno Bene la cerchia semicentrale, trainata da Porta Nuova, Cinque Giornate, Pagano, Porta Genova, Sarpi, la zona Universitaria intorno al Politecnico (Abruzzi), Statale (Tribunale), Cattolica (Leopardi), le zone verdi intorno al Castello, Sarpi, Leopardi, Trenno, le zone economiche, da Inganni a Baggio Quinto Romano per i nuovi milanesi Case nuove, la top ten delle crescite, circa +5% in sei mesi: Ripamonti -Vigentino, Tribunale – Cinque Giornate (da 4 ai 7 mila euro al mq per case vecchie o nuove), Repubblica – Porta Nuova (dai 5 mila ai 10 mila euro per vecchio e nuovo), Greco (intorno ai 3 mila euro), Turro e Precotto (3 mila euro), Sarpi e Procaccini (4 – 5 mila euro), Baggio – Quinto Romano (da mille a 3 mila euro per vecchio e nuovo), Abruzzi - Romagna (5 mila), Gallaratese – Trenno ( 3 mila), Leopardi - Boccaccio – Pagano (cresce il nuovo a 8 mila). Le case vecchie da ristrutturare crescono più del 5% a Inganni – S. Cristoforo (mille euro), Istria – Maciachini (2 mila euro), Solferino – Garibaldi (5 mila), Conca del Naviglio - Porta Genova (3 mila), Fiera – Sempione (3 mila) Repubblica – Porta Nuova supera Venezia - Monforte , + 5% in sei mesi per il nuovo, quasi 10 mila euro al mq e +5% anche per le case vecchie da ristrutturare che valgono 5 mila euro al mq. -

Porta Romana Railway Yard: Updated Masterplan and Winter Olympic Village 2026 Unveiled
PORTA ROMANA RAILWAY YARD: UPDATED MASTERPLAN AND WINTER OLYMPIC VILLAGE 2026 UNVEILED SKIDMORE, OWINGS & MERRILL REVEALED AS ARCHITECTS FOR THE OLYMPIC VILLAGE • The Parco Romana masterplan, approved by the Supervisory Board of the Railway Stations Program Agreement, reflects suggestions received during the public consultation • The Masterplan and the Olympic Village are aligned with the parameters of the Italian National Recovery and Resilience Plan • The Village for Athletes, which will be delivered in July 2025, will have an open architecture that will allow permeability and integration with the surrounding area • The Village, with zero environmental impact, will be a blueprint for ESG- focused developments and, thanks to public/private collaboration, is designed to take into consideration usage requirements both during and after the competition • Timeline of the project is on track Milan, 15 July 2021 - The "Porta Romana" real estate investment fund - promoted and managed by COIMA SGR and subscribed by Covivio, Prada Holding and the COIMA ESG City Impact fund - in agreement with the FS Italiane Group and as auctioneer of the international competition for the preparation of the preliminary masterplan for the regeneration of the Porta Romana railway yard, prepared according to the guidelines of the Municipality of Milan, presents the updated Masterplan of the Railway Yard and the project for the Olympic Village, assigned to Skidmore, Owings & Merrill - SOM. The projects were unveiled today at a press conference attended by the President -

01PAR Relazione Norme Attua
Piano di Governo PGT del Territorio Piano per le Attrezzature Religiose Relazione e norme di attuazione Elaborato emendato a seguito della delibera di adozione n. 2 Seduta Consiliare 5 marzo 2019 Marzo 2019 Relazione 1. Premessa 5 2. Inquadramento normativo e percorso procedurale 6 3. L'istruttoria delle istanze pervenute 7 4. Il Piano per le attrezzature religiose 8 5. Elenco delle attrezzature religiose 10 5.1 Le attrezzature religiose esistenti 10 5.2 Le attrezzature religiose di nuova previsione 18 5.3 Le aree di proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature religiose 18 Norme di attuazione art. 1 Natura e contenuti 19 art. 2 Elaborati del Piano per le attrezzature religiose 19 art. 3 Ambito di applicazione 19 art. 4 Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione 20 art. 5 Disciplina delle attrezzature religiose esistenti 20 Relazione 5 1. Premessa 1 cfr. artt. 2, 3, 8 e 19 – Costituzione della Repubblica Nel rispetto del dettame costituzionale1 e legislativo2, il Comune di Milano italiana si impegna a riconoscere e garantire concretamente i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiedere 2 Legge n. 1159/1929, recante “Disposizioni l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul stabilendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’or- medesimi” e il R.D. -

1568984383.Pdf
The Architecture of Modern Italy SWITZERLAND AUSTRIA Italy 1750 Simplon Veneto Lombardy Belluno Gallarate Bergamo Possagno Monza Treviso Novara Brescia Verona Trieste Milan Venice Tur in Padua Mantua Piedmont Parma Ferrara Modena Genoa Bologna Liguria Faenza Carrara Pistoia San Marino Florence Urbino Livorno Ancona Tuscany Papal States ADRIATIC SEA Montalcino Follonica Perugia Elba Civitavecchia Tivoli Rome Subiaco Terracina Minturno Gaeta Caserta Naples Kingdom of Portici/Herculaneum Two Sicilies Amalfi SARDINIA Paestum TYRRHENIAN SEA Palermo The Architecture of Modern Italy Volume I:The Challenge of Tradition,1750–1900 Terry Kirk Princeton Architectural Press New York for marcello Published by Princeton Architectural Press 37 East Seventh Street New York,New York 10003 For a free catalog of books, call 1.800.722.6657. Visit our web site at www.papress.com. © 2005 Princeton Architectural Press All rights reserved Printed and bound in Hong Kong 08 07 06 05 5 4 3 2 1 First edition No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the publisher, except in the context of reviews. Every reasonable attempt has been made to identify owners of copyright. Errors or omissions will be corrected in subsequent editions. Project Coordinator: Mark Lamster Editing: Elizabeth Johnson, Linda Lee, Megan Carey Layout: Jane Sheinman Special thanks to: Nettie Aljian, Dorothy Ball, Nicola Bednarek, Janet Behning, Penny (Yuen Pik) Chu, Russell Fernandez, Clare Jacobson, John King, Nancy Eklund Later, Katharine Myers, Lauren Nelson, Scott Tennent,Jennifer Thompson, and Joseph Weston of Princeton Architectural Press —Kevin C. Lippert, publisher Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Kirk,Terry. -

Porta Romana Railway Yard: 6 Finalists Shortlisted for the Development of the Urban Rigeneration Masterplan
Press release PORTA ROMANA RAILWAY YARD: 6 FINALISTS SHORTLISTED FOR THE DEVELOPMENT OF THE URBAN RIGENERATION MASTERPLAN • 47 groups from 14 nations submitted proposals • Finalists increased from 5 to 6 in light of the quality of the applications • Launched the second phase of the competition with the delivery of the masterplans scheduled for the end of March 2021 Milan, 18 January 2021 – COIMA SGR S.p.A. on behalf of Porta Romana Fund – the Reserved Real Estate Alternative Investment Fund participated by COIMA ESG City Impact Fund, Covivio and Prada Holding S.p.A – in agreement with Gruppo FS, and in its capacity as implementer of the International Competition for the preparation of the Masterplan for the regeneration of the Porta Romana railway yard in Milan, announces the shortlisted finalists. The shortlisted finalists, who will now be required to draw up the masterplan of the Porta Romana railway yard in the second phase of the competition, are: • BIG - Bjarke Ingels Group, Buro Happold, Atelier Ten, MIC - Mobility in Chain, Atelier Verticale, Ubistudio, SCE Project • Cobe A/S, SD Partners S.R.L., TRM Group S.R.L., AKT II, Hilson Moran, Urban Foresight • John McAslan + Partners, Meinhardt, Barker Langham, Makower Architects, Urbn’ita, MVVA, ESA Engineering • OUTCOMIST, Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, Carlo Ratti Associati, Gross. Max, Nigel Dunnett Studio, Arup, Portland Design, Systematica, Studio Zoppini, Aecom, Land, Artelia • Skidmore, Owings & Merrill (Europe) LLP – SOM, Michel Desvigne Paysagiste (MDP), TSPOON, -

Futureberry X Comune Di Milano -Nuovi Negozi Di Quartiere
7 TITOLO CAPITOLO UNO. Introduzione L’obiettivo della ricerca • Studiare le nuove forme del commercio di prossimità a Milano • Individuare i protagonisti, per evidenziarne i tratti comuni e individuarne bisogni ricorrenti • Delineare le linee guida per azioni successive di supporto a questa tipologia di negozi Introduzione Le domande di ricerca 1 Come sta evolvendo il retail a livello globale? 2 Queste tendenze si ritrovano anche nel commercio di prossimità di Milano? 3 Milano è una piattaforma ricettiva per la sperimentazione di nuovi modelli di retail? 4 Qual è il ruolo dei negozi di quartiere all’interno del tessuto sociale della città? Globale La trasformazione del Retail 12% 6.800 850 Vendite online Negozi di vendita al Negozi fisici di rispetto al totale dettaglio che hanno aziende native delle vendite al chiuso nel 2017 negli digitali che apriranno dettaglio nel mondo USA entro il 2023 Corrispondente a 3.453 Appartenenti a grandi Da parte dei 100 retailer miliardi di dollari catene online più importanti Globale 7 trend globali del retail Personalizzazione Retail remix Da iper a micro Shopping per tutti Uno spazio, La prossimità consapevole tante identità è felicità A ciascuno il suo Prima di comprare vogliamo sapere One-Click-Shop Oltre la vendita Formazione continua Tutto, subito, ovunque Moltiplicazione dei Compra imparando, modelli di business impara comprando 7 TITOLO CAPITOLO UNO. Milano Il commercio di prossimità a Milano 32.973 +13,12% 13,5% Esercizi Crescita del Crescita del numero commerciali attivi numero di esercizi di