Menchelli-Buttini 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'opera Italiana Nei Territori Boemi Durante Il
L’OPERA ITALIANA NEI TERRITORI BOEMI DURANTE IL SETTECENTO V. 1-18_Vstupy.indd 2 25.8.20 12:46 Demofoonte come soggetto per il dramma per musica: Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento a cura di Milada Jonášová e Tomislav Volek ACADEMIA Praga 2020 1-18_Vstupy.indd 3 25.8.20 12:46 Il libro è stato sostenuto con un finanziamento dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca. Il convegno «Demofoonte come soggetto per il dramma per musica: Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento» è stato sostenuto dall’Istituto della Storia dell’Arte dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca con un finanziamento nell’ambito del programma «Collaborazione tra le Regioni e gli Istituti dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca » per l’anno 2019. Altra importante donazione ha ricevuto l’Istituto della Storia dell’Arte dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca da Johann Adolf Hasse-Gesellschaft a Bergedorf e.V. Prossimo volume della collana: L’opera italiana – tra l’originale e il pasticcio In copertina: Pietro Metastasio, Il Demofoonte, atto II, scena 9 „Vieni, mia vita, vieni, sei salva“, Herissant, vol. 1, Paris 1780. In antiporta: Il Demofoonte, atto II, scena 5 „Il ferro, il fuoco“, in: Opere di Pietro Metastasio, Pietro Antonio Novelli (disegnatore), Pellegrino De Col (incisore), vol. 4, Venezia: Antonio Zatta, 1781. Recensori: Prof. Dr. Lorenzo Bianconi Prof. Dr. Jürgen Maehder Traduzione della prefazione: Kamila Hálová Traduzione dei saggi di Tomislav Volek e di Milada Jonášová: Ivan Dramlitsch -

Opera Olimpiade
OPERA OLIMPIADE Pietro Metastasio’s L’Olimpiade, presented in concert with music penned by sixteen of the Olympian composers of the 18th century VENICE BAROQUE ORCHESTRA Andrea Marcon, conductor Romina Basso Megacle Franziska Gottwald Licida Karina Gauvin Argene Ruth Rosique Aristea Carlo Allemano Clistene Nicholas Spanos Aminta Semi-staged by Nicolas Musin SUMMARY Although the Olympic games are indelibly linked with Greece, Italy was progenitor of the Olympic operas, spawning a musical legacy that continues to resound in opera houses and concert halls today. Soon after 1733, when the great Roman poet Pietro Metastasio witnessed the premiere of his libretto L’Olimpiade in Vienna, a procession of more than 50 composers began to set to music this tale of friendship, loyalty and passion. In the course of the 18th century, theaters across Europe commissioned operas from the Olympian composers of the day, and performances were acclaimed in the royal courts and public opera houses from Rome to Moscow, from Prague to London. Pieto Metastasio In counterpoint to the 2012 Olympic games, Opera Olimpiade has been created to explore and celebrate the diversity of musical expression inspired by this story of the ancient games. Research in Europe and the United States yielded L’Olimpiade manuscripts by many composers, providing the opportunity to extract the finest arias and present Metastasio’s drama through an array of great musical minds of the century. Andrea Marcon will conduct the Venice Baroque Orchestra and a cast of six virtuosi singers—dare we say of Olympic quality—in concert performances of the complete libretto, a succession of 25 spectacular arias and choruses set to music by 16 Title page of David Perez’s L’Olimpiade, premiered in Lisbon in 1753 composers: Caldara, Vivaldi, Pergolesi, Leo, Galuppi, Perez, Hasse, Traetta, Jommelli, Piccinni, Gassmann, Mysliveek, Sarti, Cherubini, Cimarosa, and Paisiello. -

Milan, 26Th January, 1770
0158. MOZART TO HIS SISTER ,1 SALZBURG [Milan, 26 th January, 1770] I am truly and wholeheartedly glad that you enjoyed this sleigh ride so much 2 and I wish you a thousand opportunities for enjoyment so that you may live your life in truly high spirits. But one thing vexes me, [5] that you let Herr von Mölk 3 sigh and suffer so endlessly, and that you did not go on a sleigh ride with him so that he could have tipped it over for you. How many sniffle-handkerchiefs will he have needed that day for weeping over you? He will of course have taken 2 ounces of tartar 4 beforehand, which no doubt expelled from him the horrifying uncleanliness of body that he has. [10] I know of nothing new, except that Herr Gelehrt, 5 the poet in Leipzig, has died and has written no more poetry since his death. Just before I started this letter, I finished an aria from Demetrio ,6 which begins like this: Misero tu non sei: [15] Tu spieghi il tuo dolore; e se non desti amore; ritrovi almen pietà. * Misera ben son io Che nel segretto laccio [20] Amo, non spero e taccio E l’idol mio nol sà. 7 The opera in Mantua was fine, they played Denetrio .8 The leading lady sings well but quietly and, if you do not see her acting, but only singing, you think she is not singing, for she cannot open her mouth, [25] but whines her way through everything, but that is nothing new to us. -

Siroe Fondazione Teatro La Fenice Di Venezia
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL SIROE FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA SIROE Georg Friedrich Händel in un ritratto di Thomas Hudson. (Londra, National Portrait Gallery). 2 FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA SIROE musica di GEORG FRIEDRICH HÄNDEL VENEZIA - SCUOLA GRANDE S. GIOVANNI EVANG E LI STA Giovedì 28 dicembre 2000, ore 20.00 Sabato 30 dicembre 2000, ore 15.30 Martedì 2 gennaio 2001, ore 20.00 Giovedì 4 gennaio 2001, ore 20.00 3 —————— Edizioni dell’Ufficio Stampa del TEATRO LA FENICE Responsabile Cristiano Chiarot Hanno collaborato Pierangelo Conte, Giorgio Tommasi Ricerca iconografica Maria Teresa Muraro Copertina Tapiro Pubblicità AP srl Torino 4 SOMMARIO 7 LA LOCANDINA 11 I LIBRETTI 90 SIROE IN BREVE 92 ARGOMENTO - ARGUMENT - SYNOPSIS - HANDLUNG - 97 LORENZO BIANCONI L’“INTOLLERANTE” SIROE DA VENEZIA A HAYMARKET 102 HÄNDEL E METASTASIO 103 JORGE LAVELLI SIROE, RE DI PERSIA ALLA SCUOLA GRANDE S. GIOVANNI EVANGELISTA 104 GIORGIO GUALERZI UNA CITTÀ HÄNDELIANA 112 BIOGRAFIE 5 Lauro Crisman, modellino per Siroe. Venezia, Scuola Grande S. Giovanni Evangelista, dicembre 2000. 6 LA LOCANDINA SIROE musica di GEORG FRIEDRICH HÄNDEL libretto di NICOLA FRANCESCO HAYM da PIETRO METASTASIO prima rappresentazione in Italia personaggi ed interpreti Cosroe LORENZO REGAZZO Siroe VALENTINA KUTZAROVA Medarse ROBERTO BALCONI Emira PATR IZIA CIOFI Laodice JAHO ERMONELA Arasse DARIO GIORGELÉ maestro concertatore e direttore ANDREA MARCON regia JORGE LAVELLI scene LAURO CRISMAN costumi FRANCESCO ZITO assistente regia CARLO BELLAMIO effetti sonori JEAN MARIE BOURDAT light designer FABIO BARETTIN VENICE BAROQUE ORCHESTRA nuovo allestimento in coproduzione con APOLLONESQUE e in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del Terzo Centenario della nascita di Pietro Metastasio Si ringraziano l’Università di Birmingham – Centre of Early Music Performance and Research e la Dott.ssa Mary O’Neill per aver gentilmente fornito copia dei manoscritti originali del Siroe. -

Die Werke Georg Friedrich Händels in Göttingen
Die Werke Georg Friedrich Händels in Göttingen Eine Darstellung der Sammlung G. F. Händels in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen unter Berücksichtigung des identischen Bestandes in weiteren ausgewählten Göttinger Institutionen T e x t von Poupak Amirazodi Göttingen, November 2005 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite Vorwort Einleitung 1 1 Allgemeines 1.1 Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 4 1.1.1 Anfänge 5 1.1.2 Das 20. Jahrhundert 9 1.2 Die Musiksammlung 11 1.2.1 Umfang 12 1.2.2 Aufstellung – Signierung 15 2 Übersicht über die Kataloge der Universitätsbibliothek 17 2.1 Der Akzessionskatalog 18 2.2 Alphabetische Kataloge 21 2.3 Systematische und Sachkataloge 24 2.4 Sonderkataloge 26 2.5 Der Ars-Musica-Katalog 28 2.5.1 Der Ars Musica Catalogus realis 29 2.5.2 Der Ars Musica Catalogus alphabeticus 33 2.5.3 Besonderheiten der Katalogisierung im Göttinger Musikalienkatalog 36 3 Musikalien und Musikliteratur 38 3.1 Die Ära Notendrucke und musikalische Literatur 38 3.2 Musiksammlungen und Musikbibliotheken 40 3.3 Musik in der bibliothekarischen Praxis 43 4 Georg Friedrich Händel 45 4.1 Lebensgeschichte 46 4.2 Werke 49 5 Das Projekt G. F. Händel 50 5.1 Bericht über die Arbeit 51 5.2 Händel in der SUB Göttingen 55 5.2.1 Umfang des Händel-Bestandes 55 5.2.2 Aufbau und Erschließung 58 6 Musik und Händel in Göttingen 60 6.1 Musikwissenschaft und Musikpflege in Göttingen 61 6.2 Musikwissenschaftliche Institutionen 63 6.3 Das Musikwissenschaftliche Seminar der Universität Göttingen 64 6.3.1 Die Bibliothek 65 6.3.2 Der Händel-Bestand 67 6.4 Die Göttinger Händel-Gesellschaft 68 6.4.1 Entwicklung der Gesellschaft 69 6.4.2 Die Händel-Festspiele Göttingen 69 6.4.3 Bestandsaufbau und Erschließung 71 6.5 Das Stadtarchiv Göttingen 72 6.5.1 Geschichte des Stadtarchivs 72 6.5.2 Händel im Stadtarchiv 75 6.6 Die Werke Händels im Programm des Göttinger Symphonie Orchesters 75 7 Zusammenfassung 76 8 Literaturverzeichnis 8.1 Literatur 79 8.2 Internet-Veröffentlichungen 85 8.3 Unveröffentlichtes Material 87 9. -

METASTASIO COLLECTION at WESTERN UNIVERSITY Works Intended for Musical Setting Scores, Editions, Librettos, and Translations In
METASTASIO COLLECTION AT WESTERN UNIVERSITY Works Intended for Musical Setting Scores, Editions, Librettos, and Translations in the Holdings of the Music Library, Western University [London, Ontario] ABOS, Girolamo Alessandro nell’Indie (Ancona 1747) (Eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) (From London: British Library [Add. Ms. 14183]) Aria: “Se amore a questo petto” (Alessandro [v.1] Act 1, Sc.15) [P.S.M. Ital. Mus. Ms. Sec.A, Pt.1, reel 8] ABOS, Girolamo Artaserse (Venice 1746) (Mid-eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) (From London: British Library [Add. Ms. 31655]) Aria: “Mi credi spietata?” (Mandane, Act 3, Sc.5) [P.S.M. Ital. Mus. Ms. Sec.C, Pt.2, reel 27] ADOLFATI, Andrea Didone abbandonata (with puppets – Venice 1747) (Venice 1747) – (Venice: Luigi Pavini, 1747) – (Libretto) [W.U. Schatz 57, reel 2] AGRICOLA, Johann Friedrich Achille in Sciro (Berlin 1765) (Berlin 1765) – (Berlin: Haude e Spener, 1765) – (Libretto) (With German rendition as Achilles in Scirus) [W.U. Schatz 66, reel 2] AGRICOLA, Johann Friedrich Alessandro nell’Indie (as Cleofide – Berlin 1754) (Berlin 1754) – (Berlin: Haude e Spener, [1754]) – (Libretto) (With German rendition as Cleofide) [W.U. Schatz 67, reel 2] ALBERTI, Domenico L’olimpiade (no full setting) (Eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) (From London: British Library [R.M.23.e.2 (1)]) Aria: “Che non mi disse un dì!” (Argene, Act 2, Sc.4) [P.S.M. Ital. Mus. Ms. Sec.B, Pt.4, reel 73] ALBERTI, Domenico Temistocle (no full setting) (Eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) 2 (From London: British Library [R.M.23.c.19]) Aria: “Ah! frenate il pianto imbelle” (Temistocle, Act 3, Sc.3) [P.S.M. -

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Ospedale della Pietà in Venice Opernhaus Prag Antonio Vivaldi (1678-1741) Complete Opera – Antonio Vivaldi – Complete Opera – Index - Complete Operas by Antonio Vivaldi Page Preface 3 Cantatas 1 RV687 Wedding Cantata 'Gloria e Imeneo' (Wedding cantata) 4 2 RV690 Serenata a 3 'Mio cor, povero cor' (My poor heart) 5 3 RV693 Serenata a 3 'La senna festegiante' 6 Operas 1 RV697 Argippo 7 2 RV699 Armida al campo d'Egitto 8 3 RV700 Arsilda, Regina di Ponto 9 4 RV702 Atenaide 10 5 RV703 Bajazet - Il Tamerlano 11 6 RV705 Catone in Utica 12 7 RV709 Dorilla in Tempe 13 8 RV710 Ercole sul Termodonte 14 9 RV711 Farnace 15 10 RV714 La fida ninfa 16 11 RV717 Il Giustino 17 12 RV718 Griselda 18 13 RV719 L'incoronazione di Dario 19 14 RV723 Motezuma 20 15 RV725 L'Olimpiade 21 16 RV726 L'oracolo in Messenia 22 17 RV727 Orlando finto pazzo 23 18 RV728 Orlando furioso 24 19 RV729 Ottone in Villa 25 20 RV731 Rosmira Fedele 26 21 RV734 La Silvia (incomplete) 27 22 RV736 Il Teuzzone 27 23 RV738 Tito Manlio 29 24 RV739 La verita in cimento 30 25 RV740 Il Tigrane (Fragment) 31 2 – Antonio Vivaldi – Complete Opera – Preface In 17th century Italy is quite affected by the opera fever. The genus just newly created is celebrated everywhere. Not quite. For in Romee were allowed operas for decades heard exclusively in a closed society. The Papal State, who wanted to seem virtuous achieved at least outwardly like all these stories about love, lust, passions and all the ancient heroes and gods was morally rather questionable. -
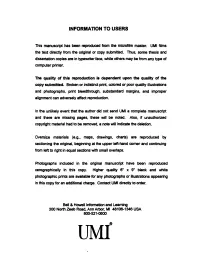
Operatic Reform in Turin
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter tece, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, If unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. Bell & Howell Information and Learning 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 NOTE TO USERS This reproduction is the best copy available. UMI OPERATIC REFORM IN TURIN: ASPECTS OF PRODUCTION AND STYLISTIC CHANGE INTHEI760S DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Margaret Ruth Butler, MA. -

Il Complesso Barocco Edition
Handel: ADMETO (1726) Full score and piano-vocal Vivaldi: ERCOLE SUL TERMODONTE (1723) Full score and piano-vocal ISMN 979-0-2025-3382-6 Alan Curtis’ 1977 performance in Amsterdam‘s Concertgebouw, This important opera, performed in Rome a year earlier than DVD recorded by EMI with René Jacobs singing the title role, has now itself Il Giustino, was long thought to be lost. Nearly all the arias have Stains / Nesi / Cherici / become historical. Curtis has gone over the work and its sources again however been found, some missing their orchestral accompaniments, Dordolo / Bartoli / Scotting / and come up with new conclusions. Although the opera is published in various locations, and the lost recitatives and other missing parts Il Complesso Barocco / complete, he suggests ways to emend, cut, or compensate for the have been composed by Alessandro Ciccolini. Alan Curtis / directed by weaknesses of the outmoded libretto and restore Admeto to the John Pascoe (Spoleto position it deserves, as musically one of Handel’s greatest operas. Festival, 2006) Dynamic (2007) D. Scarlatti: TOLOMEO E ALESSANDRO (1711) Full score and piano-vocal Universally admired for his keyboard music, the vocal music of CD Domenico Scarlatti has until very recently been largely ignored. Hallenberg / Ek / Tolomeo e Alessandro was known only from a manuscript of Act I Invernizzi / Baka / Milanesi / in a private collection in Milan. Recently the entire opera turned up Nesi / Il Complesso Traetta: BUOVO D’ANTONA (1758) Full score and piano-vocal NEW in England and surprisingly revealed that Domenico was after all Barocco / Alan Curtis A charmingly light-hearted libretto by the well-known Venetian CD a very fi ne dramatic composer, perhaps even more appealingly so Universal Music Spain / playwright Carlo Goldoni, was set to music by the as-yet- Trogu-Röhrich / Russo- than his father Alessandro. -

Gluck's London Operas
GLUCK'S LONDON OPERAS By WILLIAM BARCLAY SQUIRE Downloaded from ITH the conspicuous exception of Horace Walpole's letters, we are singularly deficient in social chronicles W of the later years of the reign of George II. For con- temporary accounts of the invasion of England by Prince Charles Edward in 1745, of his surprising inarch to Derby and the http://mq.oxfordjournals.org/ consternation it created in London—when the news arrived on a day long remembered as 'Black Friday*—Walpole's letters, which are our chief authority, have to be supplemented by reference to the newspapers of the day. Although London in 1745 did not, as at the present day, suffer from the plethora of papers—each anxious to go one better than the others in purveying 'news' of doubtful authenticity—enough can be gathered from the collection made by Dr. Burney and now preserved in the British Museum to show that at University of California, Santa Barbara on June 27, 2015 the alarm in the South of England was very real. Stories of spies and of poisoned wells were rife then, just as they have been in our own time, but the chief scare raised successfully by the Hanoverians was that the return of the House of Stuart would mean the spread, if not actually the establishment, of the Roman Catholic religion. It seems impossible to realize that London should have believed that the English Catholics, after a century and a hah* of cruel suppression, were sufficiently numerous or powerful to be a real source of danger, but the metropolis—as in the time of the Civil War—was the head- quarters of the bitterest form of Puritanism, and though it may not have been specially devoted to the House of Hanover, nor remarkably zealous in attending the churches of the Establishment, at least it was unfaltering and sincere in its hatred of Papacy. -

Amadis De Gaule, the Culmination of an Operatic Career
Amadis de Gaule , the culmination of an operatic career Didier Talpain Unlike any other member of his illustrious family before him, Johann Christian Bach (who was to marry the soprano Cecilia Grassi) maintained a lifelong connection with the world of opera. He was, incidentally, also the only member who converted from Lutheranism to Catholicism. He first really came into contact with opera during the years he spent in Berlin (175 0- 1754), where he went to stay – and train – with his half- brother, Carl Philipp Emmanuel, after their father’s death. At that time he frequently had the opportunity to attend performances at the Royal Berlin Opera House, founded by the musical king Frederick II (who was noted as a flautist). There he heard fine works composed in the Italian style by Carl Heinrich Graun (Kappellmeister to Frederick II), Johann Adolf Hasse or Niccolò Jommelli. But it was in Italy, where he went next, that he really learned how to compose operas. As a student of the famous Padre Martini in Bologna, he began by composing religious music. But there was only a very fine dividing line between church and stage music in Italy at that time. Take, for example, the ‘Tuba mirum’ for soprano and orchestra from his Dies Irae of 1757: with other words, it could be a per - fectly convincing anger aria in an opera. Bach’s operatic career took over more or less from his career as a church musician. In all, during his life - time, he produced eleven operas, sometimes in quick succession: Artaserse (1760), Catone in Utica (1761), Alessandro nell’Indie (1762), Orione (1763), Zanaïda (1763), Adriano in Siria (1765), Carattaco (1767), Temistocle (1772), Lucio Silla (1775), La Clemenza di Scipione (1778), Amadis de Gaule (1779). -
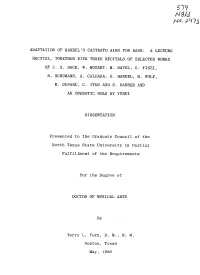
Adaptation of Handel's Castrato Airs for Bass: a Lecture Recital, Together with Three Recitals of Selected Works of J
57? NS/d Ho, ADAPTATION OF HANDEL'S CASTRATO AIRS FOR BASS: A LECTURE RECITAL, TOGETHER WITH THREE RECITALS OF SELECTED WORKS OF J. S. BACH, W. MOZART, M. RAVEL, G. FINZI, R. SCHUMANN, A. CALDARA, G. HANDEL, H. WOLF, H. DUPARC, C. IVES AND S. BARBER AND AN OPERATIC ROLE BY VERDI DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS By Terry L. Fern, B. M., M. M. Denton, Texas May, 1986 Fern, Terry Lee, Adaptation of Handel's Castrato Airs for Bass, A Lecture Recital Together With Three Recitals of Selected Works of J. S. Bach, W. Mozart, M. Ravel, G. Finzi, R. Schumann, A. Caldara, G. Handel, H. Wolf, H. Duparc, C- Ives and S. Barber and an Operatic Role by Verdi. Doctor of Musical Arts (Vocal Performance), May, 1986, 31 pp., 5 illustrations, bibliography, 52 titles. The lecture recital was given on April 18, 1977. The subject was Adaptation of Handel's Castrato Airs for Bass, and it included a discussion of conventions peculiar to Handelian opera seria, concerns regarding adaptation of Handel's castrato airs and a comparison of adaptation practices in eighteenth- and twentieth-century presentations of Handel's operas. Three coloratura castrato airs and two virtuoso bass airs were performed at the conclusion of the lecture. In addition to the lecture recital, one operatic role and three recitals of solo literature for voice, piano and chamber ensemble were publicly performed. These included the role of "Samuele" in A Masked Ball, by Verdi, performed in English on March 19, 1975 with the Opera Theatre of North Texas State University, a program presented on November 24, 1975,of solo literature for voice, piano, and chamber ensemble, including works by J.