Curzel Chiese Trentine.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Róża Różańska
Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ No. 32 (4/2017), pp. 59–78 DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.010.7839 www.ejournals.eu/kmmuj Róża Różańska JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW Leone Leoni as a Forgotten Composer of the Early Baroque Era Abstract The article is a pioneer attempt in Polish literature to develop a syn- thetic resume and the characteristics of the work of the Italian Baroque composer Leone Leoni. Leoni was highly valued in his time; also, he is said to be one of the creators of dramma per musica genre, and his religious compositions served as model examples of counterpoint for many centuries. The first part of the text presents the state of research concerning the life and work of the artist; then, the second part con- tains his biography. The last part discusses Leoni’s works. Finally, the rank of his output is regarded. Keywords Leone Leoni, small-scale concerto, madrigal, early Baroque The following article is a pioneer attempt in Polish literature to develop a synthetic resume of life and art of Leone Leoni (ca. 1560–1627), an Italian composer. Today forgotten, he was a highly valued artist in his epoch. He is regarded as one of the pioneers of dramma per musica and, 59 Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, No. 32 (1/2017) through the centuries, his church music was used by music theorists as models of music rhetoric and concertato style in the compositions for small ensemble. The paper has been planned as an introduction to the cycle of arti- cles dedicated to Leone Leoni, and because of that it is general in the character. -

RETROSPETTIVE Anno 24 - N° 47 Dicembre 2012 - Aut
RETROSPETTIVE Anno 24 - n° 47 dicembre 2012 - Aut. Tribunale di Trento n° 572 del 6.2.1988 Trento di Tribunale Aut. Anno 24 - n° 47 dicembre 2012 Autorizzazione n. NE/8296/2012 1 RETROSPETTIVE SOMMARIO Editoriale Pag. 3 I luoghi madruzziani “ 5 La Valle dei Laghi nell’epoca di Gian Gaudenzio, Cristoforo e Ludovico Madruzzo (1539-1600) “ 14 Intervista al reduce Luigi Beatrici classe 1919 “ 25 Duecento anni di storia della custodia forestale “ 30 Inaugurazione dell’I.R. casino di bersaglio “Arciduchessa Gisella” “ 38 Piazza Roma “ 42 Piazza Roma un tempo “ 47 Attilio Zanolli, Garibaldino “ 49 “RetrospettIve” indirizzo e-mail: [email protected] Periodico semestrale - Anno 24 - n° 47 - dicembre 2012 - Aut. Tribunale di Trento n° 572 del 6.2.1988 Editore: Associazione Culturale della Valle di Cavedine “Retrospettive” - Cavedine (Tn) - Piazza Don Negri, 5 Distribuzione gratuita ai soci. La quota associativa è di Euro 10,00 e può essere versata sul c/c postale n° 14960389 oppure sul c/c bancario IBAN:IT 89 L 08132 34620 000311053388 presso Cassa Rurale della Valle dei Laghi intestati ad “Associazione Culturale Retrospettive” - 38073 Cavedine (Trento) - Piazza Don Negri, 5 Indicare nella causale del versamento bancario l’indirizzo per la spedizione. Numeri arretrati Euro 7,00. Direttore responsabile: Mariano Bosetti Comitato di redazione: Attilio Comai, Silvia Comai, Luigi Cattoni, Tiziana Chemotti, Teodora Chemotti, Paola Luchetta, Mariano Bosetti, Lorena Bolognani, Verena Depaoli, Ettore Parisi, Silvano Maccabelli, Rosetta Margoni. Disegni: Maria Teodora Chemotti. Stampa: Litografia Amorth Trento - tel 0461.960240 - fax 0461.961801 Realizzato in collaborazione con i Gruppi Culturali “La Ròda” di Padergnone e “N.C. -

Brentanima 2021
Vivere bene nelcuore delle Dolomiti di Brenta Dolomiti 2021 UN NUOVO STILE DI VACANZA “Siamo 10 terapisti olistici. Ogni giorno ci prendiamo cura del tuo benessere per stimolare l’energia vitale, l’equilibrio di corpo, mente e anima, rafforzare il sistema immunitario e far ritrovare l’armonia”. BRENT ANIMA RESPIRA l’aria di montagna ossigena mente e corpo CAMMINA questa terra sprigiona energia positiva ASCOLTA la natura parla al cuore di tutti ANNUSA la montagna ha sempre un buon profumo GUARDA paesaggi e panorami che sorprendono di bellezza HOLISTIC EXPERIENCE SENTIRE IL CORPO Stretching dei meridiani e Yoga dell’allineamento Con Alissa Shiraishi e Mattia Cornella - MattariVita Pratica rigenerativa ed energetica per ascoltare il proprio corpo in profondità, per una nuova percezione di sé. Percepire il Ki (Energia Vitale), osservare dove passa e stimolarlo, distribuirlo, incrementarlo, per armonizzare corpo, mente e spirito. € 14,00 | € 12,00 con card MEDITAZIONE ZAZEN E DO-IN Meditazione osservando il respiro, auto-massaggio e stiramenti Con Alissa Shiraishi e Mattia Cornella - MattariVita Zazen, seduti per meditare, con semplicità, respirando profondamente, per essere nel momen- to presente, per entrare in contatto con la dimensione del corpo. Una ricerca dentro noi stessi. Do-In, esercizi per ripristinare un’armoniosa circolazione del Ki (Energia Vitale) con movimenti del corpo, allungamenti, stiramenti e tecniche di automassaggio. HOLISTIC EXPERIENCE PERCEPTION WALKING Passeggiata sensoriale Con Alissa Shiraishi e Mattia Cornella - MattariVita Passeggiata guidata a occhi chiusi nel borgo e nel bosco per sviluppare una relazione profonda con l’ambiente attraverso i semplici gesti del camminare, sentire e toccare. Un’esperienza sensoriale, capace di risvegliare e toccare in profondità l’anima. -

San Lorenzo Dorsino
DA GIOVEDÌ 1 LA CIUÌGA NEL PIATTO A DOMENICA 4 NOVEMBRE Dove assaggiare i menù degustazione dedicati alla ciuìga e ai prodotti tipici trentini nei ristoranti del borgo. I prezzi COMUNE DI variano a seconda del menù. È gradita la prenotazione SAN LORENZO DORSINO AGRITURISMO FATTORIA HOTEL OPINIONE RISTORANTE PIZZERIA DIDATTICA ATHABASKA Tel: 0465 734039 BAR ERICA SAN LORENZO DORSINO - TN Tel: 333 1328490 Lasagnette al ragù di ciuìga, funghi e verdu- Tel: 0465 734400 Ciuìga del Banale, insalata di cavolo cappuc- re paesane gratinate al forno con scaglie di Foiade caserecce con farina di canapa “de Frazioni di BERGHI, PERGNANO E SENASO cio con mele, speck e noci, pane casereccio Trentingrana, tortino croccante di patate del Manton” al sugo di ciuìga e porri, porchetta con farine del Bleggio, zucca al rosmarino, Lomaso accompagnato da fagioli paesani in di maialino alla piastra e capùsi dell’orto formaggella di malga con pesto di cavolo Bronzon e rondelle di ciuìga spadellate conciadi dall’1 al 4 nero, assaggio di mosto d’uva Zaibel, chee- novembre 2018 secake della fattoria con composta di ribes HOTEL SAN LORENZO RIFUGIO ALPENROSE rosso Tel: 0465 734012 Tel: 0465 734363 - 340 3229213 Strudel di pasta sfoglia farcito con patate Il tradizionale pane fatto in casa con taglie- AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA del Bleggio, ciuìga e formaggio fondente, rino di ciuìga, polenta (farina di mais nostra- IL RITORNO spaghetti di patate fatti in casa saltati con no) con patate e ciuìga, pasta di salame e Tel: 340 3175054 granella di ciuìga fumè, ciuìga del -

I Segni Dell'uomo
CAI SEZIONE DI VARALLO COMMISSIONE SCIENTIFICA ‘PIETRO CALDERINI’ I SEGNI DELL’UOMO ISCRIZIONI SU ROCCE, MANUFATTI E AFFRESCHI DELL’ARCO ALPINO, UNA FONTE STORICA TRASCURATA 6-7 OTTOBRE 2018 VARALLO E RIMA (VALSESIA) ATTI DEL CONVEGNO E GUIDA ALL’ESCURSIONE a cura di Riccardo Cerri e Roberto Fantoni con contributi di Marco Avanzini, Nicoletta Barazzuol, Marta Bazzanella, Battista Beccaria, Antonio Biganzoli, Daniel Borettaz, Sergio Camerlenghi, Guido Canetta, Riccardo Cerri, Piergiorgio Cesco Frare, Raul Dal Tio, Roberto Fantoni, Anna Gattiglia, Guido Gentile, Vittorio Grassi, Vincenzo Nanni, Gianni Pizzigoni, Carlo Raiteri, Claudine Remacle, Maria Cristina Ronc, Maurizio Rossi e Riccardo Valente 2019 In copertina: la data sulla pietra di una casera all’alpe Campo di Alagna (1562) © CAI Sezione di Varallo, Commissione scientifica ‘Pietro Calderini’ – 2019 È consentita la riproduzione e la diffusione dei testi purché non abbia scopi commerciali e siano correttamente citate le fonti. INDICE I segni dell’uomo. Iscrizioni su rocce, manufatti e affreschi dell’arco alpino, una fonte storica trascurata Riccardo Cerri e Roberto Fantoni p. 5 ISCRIZIONI SU ROCCE DELL’ARCO ALPINO Iscrizioni rupestri: una prospettiva geo-archeologica per una fonte immediata di storia ambientale Maurizio Rossi e Anna Gattiglia p. 9 Le pietre incise del Monte Cimolo (Bèe, VB) Guido Canetta p. 13 La memoria di pietra. Testi raccolti nella Terra tra i due laghi Vittorio Grassi p. 19 “Io sono passato di qua”. Graffiti e segni tra protostoria ed età contemporanea nel Massiccio del Pasubio (Trento) Marco Avanzini p. 25 Incisioni pastorali su roccia in Alpago (BL) Nicoletta Barazzuol e Piergiorgio Cesco Frare p. 33 I segni dell’uomo pastore sulle rocce del Monte Cornón in valle di Fiemme Marta Bazzanella p. -

KNIGHTHOOD in the GRAND DUCHY of LITHUANIA from the LATE FOURTEENTH to the EARLY SIXTEENTH CENTURIES* Rimvydas Petrauskas In
3 9 LITHUANIAN HISTORICAL STUDIES 11 2006 ISSN 1392-2343 pp. 39–66 KNIGHTHOOD IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA FROM THE LATE FOURTEENTH TO THE EARLY SIXTEENTH CENTURIES* Rimvydas Petrauskas ABSTRACT The main aim of this article is to collect and assess all accessible data about the early development of chivalric culture in the GDL and to identify possible trends. This phenomenon is perceived as part of the history of the European knighthood in the late Middle Ages. The article also seeks to investigate the meaning of the conception of the knight in the GDL documents of the fifteenth century in order to determine the spread of knighthood in the nobility of the Grand Duchy. In the research of these aspects the flourishing of the knighthood culture at the court of Grand Duke Vytautas in the early-fifteenth century is distinguished as a period when high-ranking representatives of the country’s nobility were awarded titles; and a new enhancement is noticeable in the times of Alexander Jogailaitis when an initiative, a unique phenomenon in Poland-Lithuania, was undertaken to establish a brotherhood of knights. In the analysis of the use of the concept of knighthood, emphasis is placed on the difference between the singular use of the knightly title and the pluralistic estate conception. In 1446 the grand master of the Teutonic Order sent a letter of credence to Grand Duke Casimir and the palatine of Vilnius, Jonas Goštautas, to the effect that that the noble knights Hans Marschalk and Jenichen von Tergowitz were going to visit the courts of the Lithuanian ruler, and other nobles and dukes in order to gain knowledge of knighthood there: Die edelen und vesten Hans Marschalk und Jenichen von Tergouitz…haben liebe und lust und sint geneiget euwer grosmechtikeit und andern hern und fursten hoeffe, landt und gegenaten zcu besuchen, sich darinne zcu sehen und * This article is part of the project ‘Political, Ethnic, and Religious Confrontations in Lithuania in the Thirteenth – Fifteenth Centuries’ financed by the Lithuanian State Foundation for Research and Studies 2006. -

Kérelem Közzététele a Mezőgazdasági Termékek És Élelmiszerek Földrajzi Jelzéseinek És Eredetmegjelöléseinek Oltalmáról Szóló 510/2006/EK Tanácsi Rendelet 6
C 185/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.6.25. EGYÉB JOGI AKTUSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján (2011/C 185/05) Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet ( 1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz. EGYSÉGES DOKUMENTUM A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE „SUSINA DI DRO” EK-sz.: IT-PDO-0005-0779-30.06.2009 OFJ ( ) OEM ( X ) 1. Elnevezés: „Susina di Dro” 2. Tagállam vagy harmadik ország: Olaszország 3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása: 3.1. A termék típusa: 1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva 3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik: A „Susina di Dro” oltalom alatt álló eredetmegjelölés a helyi „Prugna di Dro”, közismertebb nevén „Susina di Dro” termesztett fajta friss gyümölcsét jelöli. A forgalomba kerülő friss gyümölcs ép, friss és egészséges kinézetű, tiszta, idegen anyagoktól és szagoktól mentes, ovális, enyhén nyújtott alakú, húsa tömör, héját a jellegzetes, fehéres hamvasság borítja. A friss gyümölcs színére a következők jellemzőek: — a héj a lilásvöröstől a kékeslila sötét árnyalatáig változhat, hamvas bevonattal, esetenként kisebb zöldes felületek láthatók rajta, — a gyümölcs húsa sárga vagy zöldessárga. ( 1 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o. 2011.6.25. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 185/11 Kémiai tulajdonságok: A gyümölcs cukortartalma szedéskor legalább 9,0 Brix-fok Polifenolok – legalább 900 mg/kg Organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságait tekintve a „Susina di Dro” OEM finom édes-savanykás, aromás ízéről és kellemesen lágy állagáról ismerhető fel. -
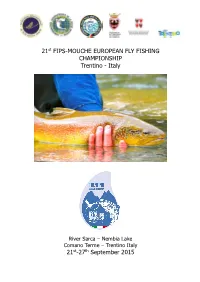
Programm-Depliant En
21st FIPS-MOUCHE EUROPEAN FLY FISHING CHAMPIONSHIP Trentino - Italy River Sarca – Nembia Lake Comano Terme – Trentino Italy 21st-27th September 2015 COMPETITION PROGRAM 21st FIPS-MOUCHE EUROPEAN FLY FISHING CHAMPIONSHIP Comano Terme, Italy 21st -27th September 2015 Date Schedule Activities Monday from 13.00 Arrival of the teams and registration at Grand Hotel Terme 21 Sep 2015 15.00 Captains’ meeting at Sala Meeting of Grand Hotel Terme 17.00 parade and opening ceremony in Parco al Sarca 19.00 welcome dinner at Comano Cattoni Holiday Hotel Tuesday from 5.00 Breakfast at the hotels 22 Sep 2015 6.30 meeting at Grand Hotel Terme 7.00 departure for the official training by minibus 9.00-12.00 official practice 1 12.00-15.00 lunch 15.00-18.00 official practice 2 19.00 return of teams to the hotels from 20.00 dinner at the hotels Wednesday from 5.00 Breakfast at the hotels 23 Sep 2015 6.00-6.30 meeting at Grand Hotel Terme 6.00 departure for the competition sector n.5 (Nembia Lake) by minibus 7.00 departure for the competition sectors n.1, 2, 3, 4 by minibus 8.00-11.30 1st session of the competition including four rotations on sector n.5 (Nembia Lake) 9.00-12.00 1st session of the competition on sectors 1, 2, 3, 4 12.00-15.00 lunch and departure for the next fishing area 15.30-19.00 2nd session of the competition including four rotations on sector n.5 (Nembia Lake) 15.30-18.30 2nd session of the competition on sectors 1, 2, 3, 4 19.00 return of teams to the hotels from 20.00 dinner at the hotels Thursday from 5.00 Breakfast at the hotels 24 -

Archivio Di Stato Di Trento. Archivio Del Principato Vescovile. Atti Trentini
Archivio di Stato di Trento. Archivio del Principato Vescovile. Atti Trentini. Schedatura a cura di Alessandro Cont, Rossella Ioppi Fondazione Bruno Kessler L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Premessa Coordinamento scientifico della dottoressa Katia Occhi, Istituto storico italo-germanico. La schedatura è stata eseguita nel corso del progetto di ricerca "Atti trentini. Una sezione dell’Archivio del Principato Vescovile di Trento (XVI-XVIII secolo)" promosso dall’Istituto storico italo-germanico della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Trento e con la Soprintendenza per i Beni culturali. Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Provincia Autonoma di Trento. Riversamento delle schede nel sistema "Archivi Storici del Trentino" a cura della dottoressa Rossella Ioppi. 2 Albero delle strutture Archivio di Stato di Trento. Archivio del Principato vescovile di Trento. Atti Trentini, 1325 - 1850 I Serie, 1325 - 1806 II Serie, 1519 - 1850 Appendice, 1401 - 1826 3 Albero dei soggetti produttori 4 fondo ASTn, APV, Atti Trentini, bb. 1-152 Archivio di Stato di Trento. Archivio del Principato vescovile di Trento. Atti Trentini, 1325 - sec. XIX prima metà (con documenti dal 1027 in copia) bb. 152 Bibliografia BEIMROHR W., Das Tiroler Landesarchiv und seine Bestände (Tiroler Geschichtsquellen, 47), Innsbruck 2002 BELLABARBA M., Giurisdizioni e comunità: Folgaria contro Lastebasse. Un caso di conflitto confinario fra Impero asburgico e repubblica di Venezia (XVII-XVIII secolo), in "Acta Histriae", 7, 1999, pp. 236-237 BONAZZA M., Il fisco in una statualità divisa: impero, principi e ceti in area trentino-tirolese nella prima età moderna, Bologna 2001 CAGOL F., GROFF S., STENICO M. -

Droughts in the Area of Poland in Recent Centuries in the Light of Multi- 2 Proxy Data
1 Droughts in the area of Poland in recent centuries in the light of multi- 2 proxy data 3 4 Rajmund Przybylak1 ORCID: 0000-0003-4101-6116, Piotr Oliński2 ORCID: 0000-0003-1428- 5 0800, Marcin Koprowski3 ORCID: 0000-0002-0583-4165, Janusz Filipiak4 ORCID: 0000-0002- 6 4491-3886, Aleksandra Pospieszyńska1 ORCID: 0000-0003-2532-7168, Waldemar 7 Chorążyczewski2 ORCID: 0000-0002-0063-0032, Radosław Puchałka3 ORCID: 0000-0002- 8 4764-0705, and Henryk P. Dąbrowski5 ORCID:0000-0002-8846-5042 9 1 Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University, Toruń, 10 Poland 11 2 Department of Medieval History, Institute of History and Archival Sciences, Faculty of History, Nicolaus 12 Copernicus University in Toruń, Poland 13 3 Department of Ecology and Biogeography, Faculty of Biology and Environmental Protection, Nicolaus Copernicus 14 University, Toruń, Poland 15 4 Department of Meteorology and Climatology, Institute of Geography, Faculty of Oceanography and Geography, 16 University of Gdansk, Poland 17 5 Dendroarchaeological Laboratory, Archaeological Museum in Biskupin, Biskupin, Poland 18 19 Correspondence to: R. Przybylak ([email protected]) 20 21 Abstract: The history of drought occurrence in Poland in the last millennium is poorly known. To improve this 22 knowledge we have conducted a comprehensive analysis using both proxy data (documentary and 23 dendrochronological) and instrumental measurements of precipitation. The paper presents the main features of 24 droughts in Poland in recent centuries, including their frequency of occurrence, coverage, duration and intensity. The 25 reconstructions of droughts based on all the mentioned sources of data covered the period 996–2015. -

To Vote a King
CONTRACTUAL MAJESTY ELECTORAL POLITICS IN TRANSYLVANIA AND POLAND-LITHUANIA 1571-1586 A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History By Felicia Roşu, M.A. Washington, DC May 1, 2009 Copyright 2009 by Felicia Roşu All Rights Reserved ii CONTRACTUAL MAJESTY ELECTORAL POLITICS IN TRANSYLVANIA AND POLAND-LITHUANIA, 1571-1586 Felicia Roşu, M.A. Thesis Advisor: Andrzej S. Kamiński, Ph.D. ABSTRACT Stefan Báthory (1533-1586) was chosen by the orders and estates of Transylvania to be their ruler in May 1571; in December 1575 he was also elected king of the Polish- Lithuanian Commonwealth and was crowned as such in May 1576. Although Báthory never returned to his homeland after he took hold of his Polish-Lithuanian throne, he maintained control over the affairs of Transylvania and ruled both countries simultaneously until his death in December 1586. This dissertation analyzes Báthory’s two elections while comparing them to similar phenomena in the rest of Europe and placing them in the larger framework of early modern constitutionalism and civic republicanism. The goals of this dissertation are to unveil the dynamics of electoral politics in sixteenth-century East Central Europe; to illuminate the political language at play during elections; and to clarify the values, intentions, and motivations of political actors—both candidates and voters—in the electoral context. Research findings indicate that electoral politics not only reflected, but also affected the identity, values, and behavior of citizens and rulers in elective constitutional monarchies, particularly at moments when citizens had to rule themselves and prospective rulers had to comply with the conditions of citizens in order to be able to occupy their thrones. -

Zugangsbedingungen Für Die Strukturen
ALLEGATO 1 CONDIZIONI DI ACCESSO PER LE STRUTTURE RICETTIVE (art. 2 del Protocollo d’Intesa per il riconoscimento dell’attestazione carta europea del turismo sostenibile per le strutture ricettive attestate con il marchio qualità parco) La struttura ricettiva che intende aderire alla Carta Europea del Turismo Sostenibile dovrà: - essere ubicata o svolgere la propria attività nell’ambito di applicazione della CETS del Parco, ambito definito nel momento della certificazione e contenuto nel Dossier di Candidatura inviato alla EUROPARC Federation; nello specifico si fa riferimento al territorio dei seguenti comuni: Andalo, Bocenago, Breguzzo, Caderzone Terme, Campodenno, Carisolo, Cavedago, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Cunevo, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Dorsino, Flavon, Giustino, Massimeno, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Pelugo, Pinzolo, Ragoli, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Strembo, Tassullo, Terres, Tione di Trento, Tuenno, Vigo Rendena e Villa Rendena; - osservare la legislazione vigente; - realizzare attività e azioni che siano compatibili con la strategia di turismo sostenibile del territorio (normativa, pianificazione e strumenti di gestione, strategia della CETS); - prendere parte ai forum della promossi dal Parco nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Questa partecipazione deve essere attiva, a titolo individuale oppure attraverso un’associazione turistica. Requisiti aggiuntivi dal Parco Naturale Adamello Brenta, specifici per la sua realtà: - essere attestata con marchio “Qualità Parco”. Inoltre l’attestazione CETS viene assegnata a singole strutture e non ad organizzazioni; questo significa che, in presenza di una società a cui appartengono più strutture, essa non potrà ottenere il marchio come società, ma bensì come singola struttura con la denominazione specifica della stessa. .