N. 22 Ottobre-Novembre-Dicembre 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Economic and Social Council
UNITED NATIONS E Distr. Economic and Social LIMITED Council E/CN.4/1998/INF.1 23 April 1998 ENGLISH/FRENCH/SPANISH COMMISSION ON HUMAN RIGHTS FIFTY-FOURTH SESSION FINAL LIST OF ATTENDANCE I. Members of the Commission ARGENTINA Representantes: Sra. Teresa de Sola Sr. Juan Carlos Sánchez Arnau Representantes suplentes: Sr. Hernán Plorutti Sr. Manuel Benítez Miembros: Sr. Victor Ramos Sr. Pablo Chelia Sr. Mariano Simón Padros Sr. Jorge Cardozo Sra. Nadia Dziewczapolski Asesores especiales: Sra. Inés Pérez Suarez Sra. Mónica Pinto GE.98-12547 - 2 - AUSTRIA Representatives: Mr. Christian Strohal Mr. Harald Kreid Alternates: Mr. Engelbert Theuermann Mr. Michael Desser Ms. Elisabeth Schiefermair Advisers: Ms. Elizabeth Bertagnoli Mr. Robert Zischg Mr. Franz Josef Homann- Herimberg Ms. Suzanne Giendl Ms. Ingrid Kircher Mr. Gerd Oberleitner Mr. Stefan Pehringer BANGLADESH Representative: Mr. Iftekhar Ahmed Chowdhury Members: Mr. Abdul Mannan Mr. Mijarul Quayes Mr. Shahidul Islam Mr. Khalilur Rahman Mr. Abu Bakr Molla BELARUS Representative: Mr. Stanislau Agurtsou Aternates: Ms. Alena Kupchyna Ms. Elena Gritsenko BHUTAN Representative: Mr. Jigmi Y. Thinley Members: Mr. Kinga Singye Mr. Ugyen Tshewang Mr. Sonam Tobgay BOTSWANA Representative: Mr. Legwaila J.M.J. Legwaila Members: Mr. Elvidge Mhlauli Mr. Eric Molale Mr. Tebelelo Boang - 3 - BRAZIL Representative: Mr. Gilberto Vergne Saboia Members: Mr. Carlos Alberto Simas Magalhaes Mr. Frederico S. Duque Estrada Meyer Mr. Antonio Carlos do Nascimento Pedro Ms. Ana Candida Perez Mr. Fernando de Mello Vidal Ms. Maria Helena Pinheiro Penna de Mello Barreto Mr. Benoni Belli Mr. Hélio Bicudo CANADA Representative: Mr. Ross Hynes Alternates: Mr. Andrew McAlister Ms. Adele Dion Advisers: Mr. Robert Lawrence Mr. -

The 37Th Session of the OIC Council of Foreign Ministers
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan The 37th Session of the OIC Council of Foreign Ministers Dushanbe 2010 BBK 86.38+87.717+87.3 (2Tadis) K-64 The 37th Session of the OIC Council of Foreign Ministers Edited by Hamrokhon Zarifi The Minister of Foreign Affairs of the Repulic of Tajikistan Dushanbe, “Vizaprint”, 2010, 172 pages, illustrated Series: Tajikistan Foreign Policy ISBN 978-99947-801-6-7 © Information Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan 2010 Introduction The Republic of Tajikistan, which pursues an «open door» foreign policy, is a member of many international and regional organizations and makes continuous efforts to develop closer and integrated relationship and cooperation with member states of these organizations. In this context, after gaining the state independence, the Republic of Tajikistan placed a particular emphasis on the issues of restoring and strengthening friendly and partnership relations with Muslim countries and took necessary measures in further developing these ties both on bilateral and multilateral levels. The Organization of the Islamic Conference (OIC) as an effective mechanism of multilateral relations among Muslim countries is becoming increasingly important in the process of ensuring well-being and development of its member states, as well as bringing peace and stability in the Islamic world. Today, OIC as a collective voice of the Islamic world is urged to provide Muslim solidarity in social, economic and political spheres. The Organization is the guarantor of protection of interests of the Islamic world in the spirit of promoting international peace and harmony among nations around the globe. -

US Islamic World Forum 2013
US-Islamic World Forum Participant Information Brief CONFIRM Total Participants 247 No. Of Countries 31 No. Of Organizations 1 S Name Country Partici. Type Position Place of Work 1 H.E. Hamid Karzai Afghanistan* Speaker President of the Country 2 HE.Dr. Zalmai Rassoul Afghanistan* Participant Minister Ministry of Foreign Affairs 3 HE.Dr. Rangin Dadfar Spanta Afghanistan* Participant -Minister & National Security Advisor 4 H.E. Ibrahim Spinzada Afghanistan* Participant -Deputy National Security Advisor 5 H.E. Hamid Siddiq Afghanistan* Participant -Chief of Protocol Ministry of Foreign Affairs 6 H.E. Mohammad Qasim Hemmat Participant -Charge d'affaires Embassy of Afghanistan in Afghanistan* Doha 7 Ms. Humira Ludin Etemadi Participant -Deputy Director Office of the Presidency of Afghanistan* the Republic 8 Mr. Nazir Hussain Rahimi Afghanistan* Participant -Secretary Presidency of the Republic 9 Mr. Timor Alam Afghanistan* Companion -Doctor of the President 10 Mr. Shahir Binwa Afghanistan* Participant - Protocol Department 11 Mr. Mohamed Yassin Haidary Afghanistan* Participant - Protocol Department 12 Mr. Mohamed Dawood Tayeb Afghanistan* Participant - Presidency of the Republic 13 Mr. Mohammad Zaki Bashiry Afghanistan* Participant - Ministry of Foreign Affairs 14 Mr. Mahbooburahman Daudzai Afghanistan* Participant - Ministry of Foreign Affairs 15 Mr. Meer Abduljabar Rahimi Afghanistan* Participant - Protocol Department 16 Mr. Khairullah Safiy Afghanistan* Participant - Protocol Department 17 Mr. Khaja Masoom Sharif Afghanistan* Participant - Presidency of the Republic 18 Mr. Mirwais Rahmani Afghanistan* Participant - Presidency of the Republic 19 Mr. Ahmad Jawd Fawad Afghanistan* Security -Security Presidency of the Republic 20 Mr. Najibullah Boble Afghanistan* Press -Media Presidency of the Republic 21 Mr. Javed Wali Afghanistan* Press -Media Presidency of the Republic 22 Mr. -

25 Th Session of the COMCEC
OIC/COMCEC/25-09/REP COMCEC Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Conference REPORT TWENTY-FIFTH SESSION OF THE COMCEC AND COMCEC ECONOMIC SUMMIT İstanbul, 5-9 November 2009 COMCEC Coordination Office Ankara, November 2009 Address: COMCEC Coordination Office State Planning Organization Necatibey Cad. 108 Ankara-TURKEY Phone : 90-312-294 55 10 Fax : 90-312-294 55 77 Website: http://www.comcec.org e-mail : comcec @ dpt.gov.tr TABLE OF CONTENTS P A R T O N E Page RESOLUTIONS OF THE OIC FORMING THE BASIS AND GUIDING THE ACTIVITIES OF THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE OIC I. Resolution adopted at the Third Islamic Summit Conference Establishing the Standing Committees of the OIC chaired by Heads of States .......................................... 9 II. Final Communique of the Fourth Islamic Summit Conference Entrusting the Chairmanship of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation to the President of the Republic of Turkey ............................. 11 III. Resolution No. 1/11-E (IS) on the Activities of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) .................................................... 12 P A R T T W O LIST OF BASIC DOCUMENTS AND REPORT OF THE TWENTY-FIFTH SESSION OF THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION I. List of Basic Documents Considered and/or Presented at the Twenty-fifth Session of the COMCEC.......................... 23 II. Report of the Twenty-fifth Session of the COMCEC.......... 29 3 Page A N N E X E S 1. List of Participants of the Twenty-fifth Session of the COMCEC..................................................................................... -
Comrade Tafcam Gen.Ziahom Talksim
f T THE Ml MmVol. XVII, No. 10; 1B78, 136. Sunday, Sept. Sunbula 19, 1357, SH. PRICE AF. 8 " f " wwwwt fi j x jwmvn Afghan Comrade TafcaM delegation arrives in j Gen.ZiahoM talks Im f Pyongyong j KABUL, Sept. 10, (Ba-khtar- ). According to a report reacting here the Meinidlly party and government atmosphere delegation of the Demo- - i i cratic Republic of Afgh KABUL, Sept. 10, (Ba-khta- r). had, Pakistani Ambassa-- i report H.E. General' Zia-- anistan neaded by Comr- Comrade Noor dor and some members, of iil-Ha- q Chief' ; Martial- - ade Dastagir Panjshiri, Mohammad Taraki, Pre- -- the Pakistani Embassy Law . Administrator' ofr member of the Political sident of the Revolution- in Kabul. Pakistan while his plane M Bureau of the Central ary Council and Zia-ul-Ha- q Prime H.E. General was leaving the . airspace' ; Committee of the Pennl- - Minister met His Excelle- e's and his entourage left of Afghanistan in a teleg - - P Democratic Party of ncy General q, Kabul for Tehran at 2:40 ram addressed to Comrade - Afghanistan and Minis Chief Martial Law p.m. yesterday. Noor Mohammad Taraki, ter of Public Works arriv Administrator of Pakistan , Present at the Kabul President of the Revolu-tionar- y ed in Pyongyang last Th- at Tapa-i-Paghma- n at International Airport to Council and 'Pr ursday and was welcomed 10:40 a.m. yesterday. Ge- bid farewell were Comr- ime Minister expressed by DeiQvoiv-Mon- . iPres-- Zia-ul-H- neral arrived ade Hafizullah Amin, gratitude for .the. hospita-'-. ident of Political Bureau 9:50 A i .. -

The UN and Capacity-Building in Afghanistan
Negotiating the 'governance gap': The UN and Capacity-building in Afghanistan For the UN Capacity-building Task Force ACKU Nicholas Leader Islamabad, 24 November, 2000 [email protected] Managed by UNCHS Habitat. Funded by UNDP, UNHCR and UNICEF l3lt~ ~ACKU~l~t llii 00011175t[li tmil~tt ~~~mr 6 Negotiating the 'governance gap': The UN and Capacity-building in Afghanistan For the UN Capacity-building Task Force ACKU Nicholas Leader Islamabad, 24 November, 2000 [email protected] Managed by UNCHS Habitat. Funded by UNDP, UNHCR and UNICEF Table of Contents Acronyms .......................................................................................................... 3 Executive Summary ........................................................................................... 4 1. Background and scope ................................................................................... 7 2. Process ........................................................................................................... 7 3. The problem ................................................................................................... 8 4. The concept of 'capacity-building' and its relevance to the problem ............ 12 5. UN and Donor policy on 'capacity-building' ............................................... 14 5.1 UN policy ................................................... ~ ............................................ 14 5.2 Donor policy .......................................................................................... -

General Assembly Distr
UNITED NATIONS A General Assembly Distr. GENERALE A/AC.96/877/Rev.1 11 octobre 1996 ORIGINAL: FRANCAIS/ANGLAIS COMITE EXECUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE Quarante-septième session (Genève,7-11octobre 1996) EXECUTIVE COMMITTEE OF THE HIGH COMMISSIONER’S PROGRAMME Forty-seventh session (Geneva,7-11October 1996) LISTE DES PARTICIPANTS LIST OF PARTICIPANTS GE.96-03150 A/AC.96/877/Rev.1 page 2 TABLE DES MATIERES Page I. ETATS 3 A. Etats membres 3 B. Etats représentés par des observateurs 32 II. AUTRES OBSERVATEURS 56 III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 58 A. Système des Nations Unies 58 1. Nations Unies 58 2. Institutions spécialisées 61 B. Autres organisations intergouvernementales 63 IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 65 TABLE OF CONTENTS I. STATES 3 A. States members 3 B. States represented by observers 32 II. OTHER OBSERVERS 56 III. INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 58 A. United Nations system 58 1. United Nations 58 2. Specialized agencies 61 B. Other intergovernmental organizations 63 IV. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 65 A/AC.96/877/Rev.1 page 3 I. ETATS - STATES A. Etats membres/States members ALGERIE - ALGERIA Représentant S.E. M. Mohamed-Salah Dembri Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à Genève Représentants suppléants M. Mahieddine Messaoui Ministre plénipotentiaire, Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève Mme Anissa Bouabdallah Conseiller, Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève M. Abdelhamid Bendaoud Conseiller, Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève M. Mohamed Hassaine Conseiller, Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève ALLEMAGNE - GERMANY Representative H.E. -

LIST of PARTICIPANTS of the TWENTY-FIFTH SESSION of the COMCEC (Istanbul, 5 – 7 November 2009)
OIC/COMCEC/25–09/LP Original : English LIST OF PARTICIPANTS OF THE TWENTY-FIFTH SESSION OF THE COMCEC (Istanbul, 5 – 7 November 2009) A. MEMBER STATES OF THE OIC ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN - H.E. Dr. MUHAMMED CELİL SHAMS Minister of Economy - ABDUL QADIER NUR - Director , Multilateral Relations and IFIs , Ministry of Foreign Affairs REPUBLIC OF ALBANIA - Mr. DURIM KRAJA Secretary General - Mr. DRITAN HYLLI General Director of Politics PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA - H.E. LACHEMI DJAABOUB Minister of Trade - Mr. SIDI MOHAMED GAOUAR Chief Supervisor of Regional Trade Agreements and Cooperation, Ministry of Commerce - Mr. SAID DJELLAB Director, Ministry of Commerce - Mr. OMAR GUETARNI Deputy Director, Free Zone, Ministry of Foreign Affairs - Mr. ENWER BENGUERNANE Deputy Director of Trade Relations - Mr. BORHEN EDDINE MESSAADIA Head of Department - Melle HADDA TOUATI Diplomatic Advisor in Charge of Economic Affairs - Mr. ABBES BELFATMI Deputy Chairman in Istanbul - Mr. HADJ MAKHLOUFI Protocol Relations 49 OIC/COMCEC/25–09/LP REPUBLIC OF AZERBAIJAN - Mr. ABID SERIFOV Deputy Prime Minister of Republic of Azerbaijan - H.E. SEVINC HASANOVA Deputy Minister of Economic Development - Mr. SAMIR AHMEDOV Consul of the Consulate General in Istanbul KINGDOM OF BAHRAIN - H.E. Dr. EBRAHIM YOUSEF AL-ABDULLAH Ambassador of the Kingdom of Bahrain in Turkey - H.E. FOUAD ALI DARWISH Ambassador, Acting Director of International Organizations Directorate - Mr. HAMAD WAHEED SAYYAR Second Secretary at the Embassy of Bahrain in Ankara - Mr. MOHAMED AHMED AL-HEJAZEY Third Secretary - Mr. HASAN RASHDAN Diplomatic Attaché PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH - H.E. MOHAMMAD ISHTIAQ Ambassador of Republic of Bangladesh in Turkey - Mr. -

4 ECO Ministerial Meeting on Commerce/Foreign Trade
Economic Cooperation Organization (ECO) REPORT 4th ECO Ministerial Meeting on Commerce/Foreign Trade (Kabul, I.R. of Afghanistan, July 11-13, 2011) ECO Secretariat, Tehran The 4th ECO Ministerial Meeting on Commerce/Foreign Trade (Kabul, I.R. of Afghanistan, July 11-13, 2011) Report 1. The 4th ECO Ministerial Meeting on Commerce/Foreign Trade was held on July 13, 2011 in Kabul, Islamic Republic of Afghanistan. The Ministerial Meeting was preceded by the Senior Officials’ Meeting (SOM) on 11 – 12 July, 2011, under the chairmanship of Mr. Mozammil Shinwari, Director General of International Trade, Ministry of Commerce and Industries of Afghanistan. 2. The Ministerial Meeting was attended by delegations of the Islamic Republic of Afghanistan (the host), the Islamic Republic of Iran, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Tajikistan, the Republic of Turkey, Turkmenistan, the Republic of Uzbekistan as well as the Secretary General of ECO along with other officials of the ECO Secretariat and ECO Trade and Development Bank (ECOTDB). The delegates of Islamic Development Bank (IDB) Jeddah also attended the meeting. The list of participants is placed at Annex-I. Agenda Items No. 1 Inauguration of the Meeting 3. The Meeting was inaugurated by His Excellency Dr. Anwar-ul-Haq Ahady, Minister of Commerce and Industries of the Islamic Republic of Afghanistan who made the welcoming remarks. A copy of the statement is placed at Annex-II. 4. The message of the His Excellency Mr. Hamid Karzai, the President of the Islamic Republic of Afghanistan on the occasion of the 4th ECO Ministerial Meeting on Commerce/Foreign Trade was read by Dr. -

Rep Eport Of
ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECO) SECRETARIAT (TEHRAN) Report of the First Meeting of the Heads of ECO National Civil Registration Organizationss/Centers (Tehran, 3-4 October 2011) Report of the First Meeting of the Heads of ECO National Civil Registration Organizations/Centers (Tehran, 3-4 October 2011) *** The First Meeting of Heads of National Civil Registration Organizations/Centers of ECO Member States was held on 3-4 October 2011 in Tehran, Islamic Republic of Iran, hosted by the Iranian National Organization for Civil Registration (NOCR). The meeting was attended by delegates of the Islamic Republic of Afghanistan, Republic of Azerbaijan, Islamic Republic of Iran (host), Kyrgyz Republic, Islamic Republic of Pakistan, Republic of Tajikistan and Republic of Turkey as well as the ECO Secretary General along with the relevant staff of the Secretariat. The list of participants is attached as Annex-I. Agenda Item No. 1 Inauguration of the Meeting The meeting started with the recitation from the Holy Quran and demonstration of Film giving introduction to the NORC. His Excellency Mr. Nazemi Ardakani, Deputy Interior Minister and Head of NOCR of the Islamic Republic of Iran delivered welcoming remarks. He welcomed the participants in Tehran. He said that a balanced and sustainable development and progress could be made through planning based on precise and accurate statistics particularly in population scope and the relevant changes. He said that the motto of the Meeting is "Modern Civil Registration - Pre-requite for Security and Development". He further said that owing to one century of activities, benefiting from services of professional experts and having modern facilities and technology, particularly in implementing electric civil status registry, the Civil Status Registration Organization of the Islamic Republic of Iran is ready to cooperate with other members, particularly the ECO Member States . -

List of Embassies and Consulates Worldwide
List of Embassies and Consulates Worldwide AUSTRALIA AUSTRIA Embassy of Afghanistan in Canberra Embassy of Afghanistan in Vienna PO Box 155 Lackierergasse 8 Top 9 Deakin West ACT 2600 1090 Vienna Tel: (+61-2) 6282 7311 Tel.: (+43-1) 524 7806 Fax: (+61-2) 6282 7322 Fax: (+43-1) 524 7807 Email: [email protected] Email: [email protected] Website: www.afghanembassy.net Ambassador: H.E. Zia NEZAM Ambassador: T.B.A non-resident envoy to Hungary & Bosnia- Non-resident envoy to: New Zealand and Herzegovina Brunei Dar-El-Salam BANGLADESH BELGIUM Embassy of Afghanistan in Dhaka Embassy of Afghanistan in Brussels & House No. CWN (C) - 2A General Delegation to the European Union Road No. 24, Culshan, Dhaka 61, avenue de Wolvendael Tel.: (+8802) 989 5994 B-1180 Bruxelles Fax: (+880-2) 988 4767 Tel: (+32-2) 761 3166 Email: [email protected] Fax: (+32-2) 761 3167 Ambassador: H.E. Akmal GHANI Email: [email protected] Ambassador: H.E. Homayoun TANDAR Non-resident envoy to: Slovakia, Estonia, Lithuania, Latvia BULGARIA CANADA Embassy of Afghanistan in Sofia Embassy of Afghanistan in Ottawa 61 "Boryana" Street 246 Queen Street, Suite 400 Bl. 216-A App. 15, Ovcha Kupel Ottawa Ontario K1P 5E4 1618 Sofia Tel: (+1 613) 563-4223/65 Tel.: (+359-2) 9556196, 9554030 Fax: (+1 613) 563-4962 Fax: (+359-2) 955 9976 Email: [email protected] Email: [email protected] Website: www.afghanemb-canada.net Ambassador: H.E. Zahida ANSARY Ambassador: H.E. Omar SAMAD Non-resident envoy to: Peru, Chile, Nicaragua, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Paraguay CANADA CHINA CONSULATE GENERAL OF Embassy of Afghanistan in Beijing AFGHANISTAN IN TORONTO 8 Tung Chih Men Wia 1131 A Leslie Street, Suite 201 Chao Yang District, Beijing Toronto, ON M3C 3L8 Tel.: (+86-10) 653 21532 Tel: +1-416- 385-1033 Fax: (+86-10) 653 226603 Fax: +1-416-385-3810 Email: [email protected] Email: [email protected] Ambassador: H.E. -
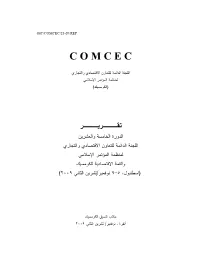
Comcec/25-09/Rep
OIC/COMCEC/25-09/REP C O M C E C () ! " (-..* , /%+ *(' #$%&) +,,- * ' /%& $ !"# . Necatibey Cad. 108 Ankara-TURKEY Phone : 90-312-294 55 10 90-312-294 55 03 Fax : 90-312-294 55 77 Website : http://www.comcec.org e-mail : [email protected] ! " # $ # %&$ ' () * ............................................................................. ! " # $ % & ............+ , '# ( ()* " 2) 34 5$0 $ 1 # --/- .(9+) 6 !70 6 ( ()* + , - ./ (12) ! " # %&$- ' .9+ $" " < ,6 2 ;/ 0 1 ) ............................................. 9+ $" & < () * ...............................9+ $" & < 6 +$ ) + , = > &4 ?6* @5& .........................................................?6* 4? 6 =9+ A" 0 =B; ?# +; 6 " + ....................................................................?6* 4? 6 ?6* 4? 6 = 9 = ? ?; + " + = < 6E =+ > C D$ " + ....................................................................?6* 4? 6 ...............................................9+ $" & < ; + 6 % FE ? =B; '+? 2"6 30 @5& 0 + " = , 30 @5& ........................................................................... () .......................... – 9+ 0 G # ..................................9+ $" & < ) .............................................< $ & H* 6 3E 0 II" E " ; 5 ? $ 5& ................................................ 6 !70 + , 6 I I 2 30 " & ........................................................... & < <I ....9+ )*