Il Paesaggio Del Leccio Tra S. Agapito E Monteroduni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria E Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare
REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare ELENCO DEGLI ALLEVATORI CHE COMPRANO IL MANGIME DA SOMMINISTRARE AGLI ANIMALI E CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DEPOSITO E STOCCAGGIO (art. 5, comma 1 Reg. (CE) n. 183/2005) ASREM - SEDE OPERATIVA DI AGNONE N. Cod_Aziendale Nome e Cognome o Ragione Sociale SEDE CODIFICA 1 002IS012 DE SIMONE VANDALINA AGNONE 4 2 002IS022 DI SABATO ROCCO AGNONE 4 3 002IS030 MARCOVECCHIO GELSUMINA AGNONE 4 4 002IS043 CELLILLI FILOMENA AGNONE 4 5 002IS044 CELLILLI FLORINDO AGNONE 4-6 6 002IS053 DI PIETRO GIANLUCA AGNONE 4 7 002IS059 GUALDIERI GIUSEPPINA AGNONE 4 8 002IS061 DI MARIO CARMINE AGNONE 4 9 002IS063 D'AGNILLO LUCIA AGNONE 4 10 002IS066 LONGHI GIOVINA AGNONE 4 11 002IS068 DI PINTO ANNAMARIA AGNONE 4 12 002IS070 LONGO IDA AGNONE 4 13 002IS079 PANNUNZIO GINO AGNONE 4-6 14 002IS081 PANNUNZIO NICOLA AGNONE 4-6 15 002IS082 PANNUNZIO TONINO AGNONE 4-6 16 002IS084 PANNUNZIO GENUINO AGNONE 4-6 17 002IS086 MARCOVECCHIO RACHELINA AGNONE 4 18 002IS087 PANNUNZIO ANGIOLINA AGNONE 4-6 19 002IS090 PALLOTTO DILIA AGNONE 4 20 002IS091 BUOSCIO GIUSEPPE AGNONE 4-6 21 002IS092 DI MENNA BINA AGNONE 4 22 002IS095 DIANA ERCOLINO AGNONE 4 23 002IS096 DIANA MICHELE AGNONE 4-6 24 002IS098 DIANA SANDRA AGNONE 4 25 002IS099 LAURIENTE BRUNO AGNONE 4 26 002IS100 ORLANDO ROCCO AGNONE 4 27 002IS101 ORLANDO ANGELO AGNONE 4-6 28 002IS103 ORLANDO CESARE AGNONE 4 29 002IS105 ORLANDO GIUSEPPE AGNONE 4 30 002IS106 ORLANDO MERCEDE AGNONE 4 31 002IS107 ORLANDO -
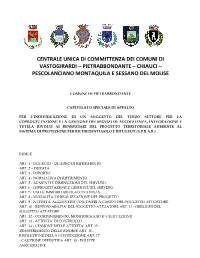
Comune Di Pescopennataro
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI – PESCOLANCIANO MONTAQUILA E SESSANO DEL MOLISE COMUNE DI PIETRABBONDANTE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTIASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). INDICE ART. 1 - OGGETTO - QUADRO DI RIFERIMENTO ART. 2 – DURATA ART. 3 - IMPORTO ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO ART. 6 - COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 7 - UNITA' IMMOBILIARI DI ACCOGLIENZA ART. 8 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ART. 9 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE ART. 11 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTATORE ART. 12 - COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE ART. 13 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ART. 14 - CESSIONE DELLE ATTIVITA' ART. 15 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ART. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 18 - POLIZZE ASSICURATIVE ART. 19 - DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA ART. 20 - STIPULA DELLA CONVENZIONE ART. 21 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE ART. 1 - OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO Con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo il nostro Paese ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32, c. 1sexies) ed ha previsto, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria. -

Guardia Medica Is
SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA) Provincia di ISERNIA ACQUAVIVA D’ISERNIA SEDE RIONERO SANNITICO V. ROMA 0865 848528 AGNONE V. MARCONI,22 0865 7221 BAGNOLI DEL TRIGNO SEDE CIVITANOVA DEL SANNIO V. PIAVESE 0865 830482 BELMONTE DEL SANNIO SEDE AGNONE V. MARCONI,22 0865 7221 CANTALUPO NEL SANNIO V. TAVERNA 0865 814357 CAPRACOTTA V. S. FALCONI, 3 0865 949121 CAROVILLI V. FONTE RITANA,1 0865 838266 CARPINONE SEDE SESSANO DEL MOLISE V. RIMEMBRANZA 0865 930320 CASTEL DEL GIUDICE SEDE CAPRACOTTA V. S. FALCONI, 3 0865 949121 CASTEL SAN VINCENZO SEDE ROCCHETTA AL VOLTURNO P. S.DOMENICO 0865 955385 CASTELPETROSO SEDE CANTALUPO NEL SANNIO V. TAVERNA 0865 814357 CASTELPIZZUTO SEDE MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 CASTELVERRINO SEDE AGNONE V. MARCONI,22 0865 7221 CERRO AL VOLTURNO SEDE ROCCHETTA AL VOLTURNO P. SAN DOMENICO 0865 955385 CHIAUCI SEDE SESSANO DEL MOLISE V. RIMEMBRANZA 0865 930320 CIVITANOVA DEL SANNIO V. PIAVESE 0865 830482 COLLI AL VOLTURNO V. G. MATTEOTTI 0865 957228 CONCA CASALE SEDE VENAFRO C/O OSPEDALE 0865 907743 FILIGNANO SEDE VENAFRO C/O OSPEDALE 0865 907743 FORNELLI SEDE COLLI AL VOLTURNO V. G. MATTEOTTI 0865 957228 FROSOLONE SEDE CIVITANOVA DEL SANNIO V. PIAVESE 0865 830482 ISERNIA V. S.IPPOLITO, 1 0865 442429 LONGANO SEDE MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 MACCHIAGODENA SEDE CANTALUPO NEL SANNIO V. TAVERNA 0865 814357 MIRANDA SEDE ISERNIA V. S.IPPOLITO, 1 0865 442429 MONTAQUILA SEDE VENAFRO C/O OSPEDALE 0865 907743 MONTENERO VAL COCCHIARA SEDE RIONERO SANNITICO V. ROMA 0865 848528 MONTERODUNI SEDE MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 PESCHE SEDE ISERNIA V. -
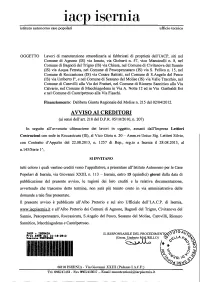
Lacp Iserllla
lacp• ISerllla• • istituto autonomo case popolari ufficio tecnico OGGETIO Lavori di manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà dell'IACP, siti nel Comune di Agnone (IS) via Ionata, via Gioberti n. 57, vico Mancinelli n. 8, nel Comune di Bagnoli del Trigno (IS) via Chiusa, nel Comune di Civitanova del Sannio (IS) via Acqua Ferrata, nel Comune di Pescopennataro (IS) via S. Pellico n. 15, nel Comune di Roccasicura (IS) via Cesare Battisti, nel Comune di S.Angelo del Pesco (IS) via Umberto l°, e nel Comune di Sessano del Molise (IS) via Valle Tracchio, nel Comune di Carovilli alla Via dei Frattari, nel Comune di Rionero Sannitico alla Via Calvario, nel Comune di Macchiagodena in Via A. Notte 12 ed in Via Garibaldi Est e nel Comune di Castelpetroso alla Via Fiaschi. Finanziamento: Delibera Giunta Regionale del Molise n. 215 del 02/0412012. AVVISO AI CREDITORI (ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207) In seguito all'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall'Impresa Lettieri Costruzioni con sede in Roccasicura (IS), al Vico Gioia n. 20 - Amm.re Unico Sig. Lettieri Silvio, con Contratto d'Appalto del 22.08.2013, n. 1257 di Rep., reg.to a Isernia il 28.08.2013, al n.145/Serie 1", SI INVITANO tutti coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore, a presentare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Isernia, via Giovanni XXIII, n. 113 - Isernia, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, avvertendo che trascorso detto termine, non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate. -

The Secret Italy: Discovering Molise by Foot
Dear I viaggi dell’origano’s traveller, we’re happy to invite you to take a look at the travels calendar 2020, constantly looking for nature, history, art, culture and delicious food and beverage in Molise. Beyond its typical shepherd’s tracks and paths (concerning history and culture), we propose to discover the soul of Molise (meetings with locals, natural landscapes, old villages, rural life, archaeological areas, traditional cuisine and more). Our mission is: to give you an experience of high-quality sustainable tourism in a cosy atmosphere that you will never forget. Currently, we includes all the areas of Molise: high valley of Volturno River (hills and mountains), high Molise (mountains), low Molise (hills close Adriatic Sea), Matese (mountains), Mainarde (mountains), central Molise (hills), Montagnola Molisana (mountains) and valley of Fortore River (hills). Nine available treks for the season 2020, that start from a minimum of four to a maximum of five days, including two day for the way back journey to Molise: “Into the green of high Molise“; “Molise between nature and history“; “Trekking by Molise lakes“; “Trails of Matese on snowshoes“; “In the heart of Molise“; “Up and down through the mountains of Matese“; “On shepherd’s tracks in Molise“; “On the wool roads of Molise“. In addition, two weekend treks (two walking days and one night): “Trekking by the lake of Occhito“; “Trekking on tracks of Samnites in Molise“. We are waiting you to spend an amazing experience! Our mission is to make sure the customer will have an high-quality holiday, with a friendly and cosy atmosphere, and to let people know Molise, showing its history, nature and landscapes. -

Bando E Disciplinare
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI – PESCOLANCIANO SESSANO DEL MOLISE CASTELVERRINO BELMONTE DEL SANNIO POGGIO SANNITA SCAPOLI PESCO PENNATARO E LONGANO COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS) Prot. n. 4216 del 09/11/2020 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016. REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOPENNATARO NELL’AMBITO DEL SIPROIMI “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” – 10 OSPITI - FAMIGLIE – – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO 1.1.2021/30.06.2023 – CUP I61E20000270005 CIG 84525565DE SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Comune di PESCOPENNATARO Via Rio Verde n.16 86080 PESCOPENNATARO tel.0865.941131; fax 0865.941365, posta elettronica: [email protected] Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA pagina 1 di 33 DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI – PESCOLANCIANO SESSANO DEL MOLISE – CASTELVERRINO – BELMONTE DEL SANNIO – POGGIO SANNITA – SCAPOLI – PESCOPENNATARO E LONGANO -

Circoscrizioni Dei Collegi Uninominali P R Ovinciali Del Molise
MINISTERO DELL’INTERNO Di p a rtimento per gli Affari Interni e Te r r i t o r i a l i Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Elezioni comunali, provinciali e reg i o n a l i Pubblicazione n.2 XI - M O L I S E Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale Circoscrizioni dei collegi uninominali p r ovinciali del Molise AN N O 2 0 0 4 A V V E R T E N Z E Le circoscrizioni dei collegi uninominali per l’elezione dei consigli delle province del Molise sono state approvate con i decreti del Presidente della Repubblica di seguito specificati: - per la provincia di Isernia, D.P.R. 15 febbraio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 feb- braio 1995; - per la provincia di Campobasso, D.P.R. 16 dicembre 2003, pubblica- to nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004. In relazione ad eventi intervenuti successivamente alla emanazione dei suddetti decreti presidenziali: 1) i comuni di nuova costituzione saranno indicati in carattere corsivo e si intenderanno far parte del collegio in cui sono compresi i comuni di origine; 2) i comuni soppressi saranno indicati in carattere normale, tra parentesi; 3) per i comuni che hanno cambiato denominazione o che hanno dato origine ad altri comuni cambiando altresì denominazione, mentre la nuova denominazione sarà indicata in carattere corsivo, quella vecchia sarà indicata in carattere normale e tra parentesi; 4) per le vie, piazze, quartieri, frazioni, ecc. -

A TUTTO MOLISE! Resoconto Di Viaggio: Il Selvatico Ed Accogliente Molise
A TUTTO MOLISE! Resoconto di viaggio: il selvatico ed accogliente Molise Equipaggio: Il Principe, Eva Kant, Gigetto (il v.r.) Percorso: dal Piemonte al Molise e ritorno Periodo: Giugno 2011 04/06/11 Principe: Allora, ripartiamo? Eva: No! Percorso: Pallavicino-Suvereto-Sasso Pisano A bordo di Gigetto partiamo da Pallavicino, frazione di Cantalupo Ligure (AL), in direzione del Molise! Attraversiamo la Liguria e come prima tappa ci fermiamo in Toscana, a Suvereto, uno dei Borghi più belli d’Italia. Il paese trae il proprio nome dalle piante di sughero (Quercus Suber) di cui sono ricchi i boschi circostanti ed affascina per il ben conservato borgo, dentro le mura, con le case e le botteghe medievali del colore della pietra locale. http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=315&codice=elenco&pag e=1 Subito dopo rotta, verso Sasso Pisano per un bel bagno rigenerante al lavatoio di acqua termale! http://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Pisano#Lavatoi_medievali_alimentati_con_acqua_ termale_di_Sasso_Pisano 1 05/06/11 Eva: Quest’anno si va in Puglia? Principe: Sì! Percorso: Sasso Pisano-Civitavecchia-A1-GRA (Grande Raccordo Anulare Roma)- uscita S.Vittore-Castel San Vincenzo, via Venafro Giornata di puro viaggio: da Sasso Pisano si procede per Civitavecchia, si continua attraverso la A1 ed il GRA (Grande Raccordo Anulare) romano , si esce a S.Vittore e si arriva in Molise a Castel San Vincenzo, via Venafro. Ci fermiamo in sosta per la notte in una bella piazzetta con vista lago all’inizio del paese! 06/06/11 Eva: Il camper non parte, problemi con la batteria? Principe: Figurati! Percorso: Castel San Vincenzo-Pescopennataro-Capracotta-Prato Gentile Al mattino ci dirigiamo a piedi verso Castel San Vincenzo: visitiamo la bella abbazia di San Vincenzo e la relativa area archeologica. -

N. Autorizzazione COMUNE OGGETTO DITTA 150088/Is Prot. N
n. autorizzazione COMUNE OGGETTO DITTA progetto per la 150088/is prot. n. realizzazione di una 38777/2015 del PESCOPENNATARO COMUNE scalinata interna al 07/04/2015 centro urbano costruzione di una linea di BT in cavo aereo in località Colle Guardia (a 150089/is prot. n. margine strada comunale 41128/2015 del MIRANDA ENEL DISTRIBUZIONE S. Lucia), per allaccio 13/04/2015 fornitura richiesta da Istituto Nazionale di Geofisica lavori di realizzazione 150090/is prot. n. dell'impianto di pubblica 41631/2015 del VENAFRO COMUNE illuminazione su Via Sesto 14/04/2015 Giulio Frontino 150091/is parere realizzazione di una negativo prot. n. CIVITANOVA DEL rimessa attrezzi attinenti la SPUGNARDI 42528/2015 del SANNIO gestione del fondo Giuseppe 15/4/2015 agricolo 150092/is prot. n. pratica n.00371870940- COOPERATIVA 42530/2015 del MONTERODUNI 22022015-1843-SUAP 7987- SERVIZI SANITARI 15/4/2015 00371870940 C.S.S. ONLUS SCIA n. 31598 del 150093/is prot. n. 24/12/2014 - Costruzione DE CRESCENTE 42533/2015 del ISERNIA della recinzione del Maria - ESPOSITO 15/4/2015 terreno sito alla C/da Le Emilio Piane. 150094/is prot. n. realizzazione di un box 42535/2015 del FORLÌ DEL SANNIO per cavalli e accessori e TECNOVERDE srls 15/4/2015 sistemazione dell'area. costruzione ricovero 150095/is prot. n. provvisorio per cavalli alla 42536/2015 del LONGANO CARANCI Nicandro contrada 15/4/2015 Campocarosello. PSR Molise 2007/2013 - 150096/is prot. n. MONTENERO VAL misura 1.2.5 azione c - 42538/2015 del COMUNE COCCHIARA realizzazione acquedotto 15/4/2015 rurale "La Fonte". interventi urgenti sul territorio comunale - 150097/is prot. -

L'alto Molise
L’ALTO MOLISE Un territorio, anzi una pluralità di territori L'area n 8 del Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta comprende l'intero territorio della Comunità Montana "Alto Molise" di Agnone, che si estende su una superficie di circa 45.000 Ha, compreso l'agro del Comune di Pescolanciano. Geograficamente il territorio è ubicato a settentrione della provincia di Isernia ed è costituito da tredici comuni: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pescolanciano, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco e Vastogirardi. L'orografia si presenta molto varia e tormentata. L'altitudine media prevalente si aggira sui 1.000 metri di quota, con un'altitudine massima di 1.746 metri nel Comune di Capracotta (Monte Campo) e un'altitudine minima di 337 metri nel Comune di Poggio Sannita (confluenza Trigno-Verrino). Vi è una linea di cresta delimitante due versanti: quello del Sangro e quello del Verrino, costituita dall'allineamento dei monti Castellano, Roccalabate, Sant'Onofrio, Del Cerro, San Nicola, Campo, Civetta, Capraro, Cavallerizzo, Forte e di Montagna Fiorita, Serrone di Staffoli, Guado Ogliraro, Colle Giovenchi, Colle Fauglie, Rocca Tamburri e Monte Caraceno. Su tale cresta sono ubicati i centri abitati di Pescopennataro, Capracotta, Vastogirardi, Pietrabbondante. Tali centri sono caratterizzati da arroccamenti di abitazioni a ridosso di speroni rocciosi ovvero di scogliere montane anche di notevoli altezze. L'ambiente è fortemente caratterizzato dalle creste, da altopiani (Monte Forte, San Mauro, Prato Gentile, Rio Verde-Quarto), dai boschi di notevole valore naturalistico e biologico (Abetina di Montecastelbarone, Abetina degli Abeti Soprani, Abetaia di Collemeluccio, Fustaia di Monte Campo e Monte Capraro). -

Comune Di Sant'angelo Del Pesco Statuto
COMUNE DI SANT’ANGELO DEL PESCO STATUTO Approvato con deliberazione consiliare n° 24 del 24/11/2006 PRINCIPI GENERALI ART. 1- PRINCIPI FONDAMENTALI - 1. Il Comune di Sant’Angelo del Pesco è ente territoriale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana e del presente statuto. 2. Realizza, con gli istituti e con i poteri del presente Statuto l’autogoverno della comunità. ART. 2- FINALITA’ 3. Il Comune, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione, promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, salvaguarda l’ambiente e valorizza le risorse naturali, culturali e storiche presenti nel territorio per garantire alla. collettività una migliore qualità della vita, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini. 4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla vita politica e sociale della Comunità; in particolare, sostiene e valorizza il rapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni; valorizza e promuove le attività culturali e sportive quali strumenti che favoriscono la crescita delle persone; promuove la tutela, la conservazione e la promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; sostiene adeguatamente, anche mediante la partecipazione diretta, le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale; 5. -

LEGGE 2 Febbraio 1970, N. 20 (GU N.41 Del 16-2-1970)
LEGGE 2 febbraio 1970, n. 20 Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise. (GU n.41 del 16-2-1970) Vigente al: 3-3-1970 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' istituita la provincia di Isernia. La regione Molise, con capoluogo Campobasso, comprende le province di Campobasso e di Isernia. Art. 2. La provincia di Campobasso, con capoluogo Campobasso, comprende i seguenti comuni: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia. Ripabottoni. Ripamolisani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polomatese,