20200908 Carta Del Carnaro.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
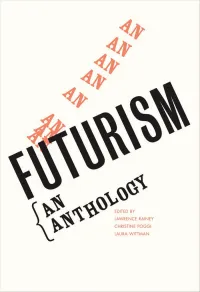
Futurism-Anthology.Pdf
FUTURISM FUTURISM AN ANTHOLOGY Edited by Lawrence Rainey Christine Poggi Laura Wittman Yale University Press New Haven & London Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Published with assistance from the Kingsley Trust Association Publication Fund established by the Scroll and Key Society of Yale College. Frontispiece on page ii is a detail of fig. 35. Copyright © 2009 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Designed by Nancy Ovedovitz and set in Scala type by Tseng Information Systems, Inc. Printed in the United States of America by Sheridan Books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Futurism : an anthology / edited by Lawrence Rainey, Christine Poggi, and Laura Wittman. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-08875-5 (cloth : alk. paper) 1. Futurism (Art) 2. Futurism (Literary movement) 3. Arts, Modern—20th century. I. Rainey, Lawrence S. II. Poggi, Christine, 1953– III. Wittman, Laura. NX456.5.F8F87 2009 700'.4114—dc22 2009007811 A catalogue record for this book is available from the British Library. This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48–1992 (Permanence of Paper). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CONTENTS Acknowledgments xiii Introduction: F. T. Marinetti and the Development of Futurism Lawrence Rainey 1 Part One Manifestos and Theoretical Writings Introduction to Part One Lawrence Rainey 43 The Founding and Manifesto of Futurism (1909) F. -

A British Reflection: the Relationship Between Dante's Comedy and The
A British Reflection: the Relationship between Dante’s Comedy and the Italian Fascist Movement and Regime during the 1920s and 1930s with references to the Risorgimento. Keon Esky A thesis submitted in fulfilment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences. University of Sydney 2016 KEON ESKY Fig. 1 Raffaello Sanzio, ‘La Disputa’ (detail) 1510-11, Fresco - Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican. KEON ESKY ii I dedicate this thesis to my late father who would have wanted me to embark on such a journey, and to my partner who with patience and love has never stopped believing that I could do it. KEON ESKY iii ACKNOWLEDGEMENTS This thesis owes a debt of gratitude to many people in many different countries, and indeed continents. They have all contributed in various measures to the completion of this endeavour. However, this study is deeply indebted first and foremost to my supervisor Dr. Francesco Borghesi. Without his assistance throughout these many years, this thesis would not have been possible. For his support, patience, motivation, and vast knowledge I shall be forever thankful. He truly was my Virgil. Besides my supervisor, I would like to thank the whole Department of Italian Studies at the University of Sydney, who have patiently worked with me and assisted me when I needed it. My sincere thanks go to Dr. Rubino and the rest of the committees that in the years have formed the panel for the Annual Reviews for their insightful comments and encouragement, but equally for their firm questioning, which helped me widening the scope of my research and accept other perspectives. -

Gabriele D'annunzio (1863-1938) Y El Japonismo
Artigrama, núm. 4, 009, 775-787 — I.S.S.N.: 013-1498 Gabriele d’Annunzio (1863-1938) y el Japonismo María Pilar Araguás Biescas* Resumen Italia fue una nación con estrechas relaciones diplomáticas y culturales con Japón. Entre los italianos que sirvieron de puente entre la cultura nipona y la europea abordamos en este artículo una aproximación a la figura de Gabriele d’Annunzio (1863-1938) que fue un literato, militar y político italiano, símbolo del Decadentismo. En su trayectoria mostró un destacado interés por el Japonismo y el arte del Extremo Oriente. Su principal aportación en esta materia fue su obra Il piacere (El placer) de 1889. Sus controvertidas ideas políticas fueron la base para el movimiento artístico del Futurismo. Italy enjoyed close relationships with Japan. Gabriele d’Annunzio (1863-1938) was an Italian poet, soldier and political, member of Decadent movement and an example of this rela- tionship between Italy and Japan. He was very interested in the Japonisme and the art of the Far East. His main success was the novel Il piacere (The Child of Pleasure, 1889). His role in politics is controversial due to his influence on the Futurism movement. Palabras clave Gabriele d’Annunzio, Japonismo, El placer, Futurismo. Gabriele d’Annunzio, Japonisme, The Chile of Pleasure, Futurism. * * * * * Introducción La figura del literato italiano Gabriele d’Annunzio (1863-1938) es una de las personalidades más estudiadas, pero a la vez una de las más complejas ya que su carrera engloba múltiples aspectos como: la literatura, el perio- dismo, la política, el cine, el teatro,1 la música, las incursiones militares,3 * Licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. -

The Myth of the New Man in Italian Fascist Ideology
fascism 5 (2016) 130-148 brill.com/fasc The Myth of the New Man in Italian Fascist Ideology Jorge Dagnino Universidad de los Andes, Chile [email protected] Abstract This article addresses the key concept of the New Man within Fascist ideology, often considered as means and end of the Fascist revolution by the Fascists. Usually dismissed as an empty slogan by historians, it is argued in the following pages that the myth of the New Man is essential for a better understanding of the regime’s totalitarian and revolutionary aspirations along with its quest of creating an alterna- tive modernity and a post-liberal and post-socialist type of civilisation based on the primacy of the collectivity - a realm where Italians could realise their full potential as human beings. Keywords Italy – Fascism – ideology – myth – New Man This article sets out to address, within the realm of the history of political ideol- ogies, Fascism’s attempt to refashion humankind. The central thesis is that the myth of the New Man can enhance our understanding of Fascism as a revolu- tionary and totalitarian experiment, along with its modern nature; that is, how Fascism, through this myth, sought the revolutionary and ultimate objective of commencing time anew, with the intent of creating a novel type of civilisation and human being based on the collectivity and the state. The myth of the New Man was a key feature in the ideological evolution of the Fascist movement and regime. Indeed, in an interview in late May 1924, Mussolini declared that * Acknowledgment: The article forms part of my FONDECYT project N.3140039, Chile. -

De “Caballeros De La Muerte” a La “Lucha Por La Vida”. Los Arditi Italianos, De La Guerra a La Militancia Antifascista Pasado Y Memoria
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea ISSN: 1579-3311 [email protected] Universidad de Alicante España Francescangeli, Eros De “caballeros de la muerte” a la “lucha por la vida”. Los arditi italianos, de la guerra a la militancia antifascista Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 15, 2016, pp. 73-97 Universidad de Alicante Alicante, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521555004004 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto De “caballeros de la mUerte” a la “lUcha por la vida”. Los arditi italianos, de la gUerra a la militancia antifascista 1 From ‘Death Knights’ to the ‘StrUggle for Life’. Italian Arditi, from War to Anti-fascism Eros Francescangeli Università di PeruGia [email protected] Recibido: 31-I-2016 Aceptado: 5-IX-2016 ResUmen El artículo aborda la historia de los arditi en la Italia posterior a la Primera Guerra Mundial: tropas de elite desarrolladas en el ejército italiano desde 1917. Los arditi en la posGuerra se convirtieron en un violento Grupo político que suele relacionarse en la historioGrafía de manera unidireccional con el fascismo. El artículo demuestra una realidad mucho más compleja, centrándose en la trayectoria de Grupos antifascistas llamados Arditi del popolo , creados en reacción a la amenaza fascista. Se examinan las características de las mentalidades de los arditi durante la posGuerra italiana en el marco de las asociaciones de excombatientes, señalando concomitancias y puntos de ruptu ra entre aquellos ex- arditi que decidieron apoyar el fascismo, y aquellos que se convir tie - ron al antifascismo. -

N. 42, Ottobre 2017 La Socializzazione Fascista E Il Comunismo
n. 42, ottobre 2017 La socializzazione fascista e il comunismo Editoriale: L'immane mistificazione, pag. 1 – Articoli: La socializzazione fascista e il comunismo, pag. 2; Cento anni dall'Ottobre, pag. 77 – Rassegna: Uragani d'America; Irma o della crescita esponenziale dei danni, pag. 81; Ricordate Katrina?, pag. 82; Oc- cupy Wall Street non nasce dal niente, pag. 83; Gli orti urbani, pag. 85; Catastrofe sociale dei lavoretti, pag. 86 – Terra di confine: La dimora dell'uomo (domani), pag. 88 – Spaccio al bestione trionfante: Coppi, Bartali e i vaccini, pag. 89 – Recensione: Lavorare è bello, pag. 90 – Doppia direzione: Riscontro "psicologico", pag. 92; Fazioni in lotta, pag. 94. Indice del numero quarantuno Direttore responsabile: Diego Gabutti Editoriale: Non possiamo ingannare la natura – Articoli: Assalto al pianeta rosso; Il secondo principio: Il grande col- Registrazione: lasso; Capitale e teoria dello sciupio – Rassegna: Ancora Tribunale di Torino n. 8752 del 22 agosto 2017. Trump; Fuga nel sub mondo – Terra di confine: Buoni di non lavoro – Recensione: Che cosa c'è dopo il capitalismo? Sede di Torino (amministrazione, redazione, – Doppia direzione: Neoluddismo – Spaccio al bestione pubblicazioni, abbonamenti): trionfante: Dieci punti per demolire Trump. Via F. Rismondo 10 - 10127 Torino – Riunioni Indice del numero quaranta aperte a tutti il venerdì dalle ore 21. Editoriale: Sedici anni, numero quaranta – Articoli: Il bien- nio rosso; Verso la singolarità storica – Rassegna: Donald Sede di Roma: Trump e la miseria relativa crescente; Donald Trump e l'iso- Via Galileo 57, 00185 Roma – Riunioni aperte a lazionismo americano; Donald Trump e la politica estera di tutti il 1° venerdì del mese dalle ore 21. -

La Mostra 23 Marzo 1919 È Inserita in Un Ciclo Di Tre Incontri Organizzati
La mostra 23 marzo 1919 è inserita in un ciclo di tre incontri organizzati dal Comune di Milano (Gabinetto del Sindaco e Presidenza del Consiglio Comunale) e dall’Università degli Studi di Milano, in collaborazio- ne con l’Istituto nazionale "Ferruccio Parri", la Fondazione Isec, l’Istituto lombardo di storia contempo- ranea, la Fondazione Milano e la Fondazione Anna Kuliscioff. Gli eventi centrali dell’immediato primo dopoguerra si svolsero tutti, nell’arco di poche settimane, a Milano. Il 5 gennaio 1919, nel corso del suo viaggio verso Parigi per partecipare alla Conferenza della pace, Mi- lano tributava un’accoglienza trionfale al presidente degli Stati Uniti d'America. Per l’occasione, Woo- drow Wilson venne ricevuto dal sindaco socialista Emilio Caldara a Palazzo Marino. L’11 gennaio 1919 a Leonida Bissolati, convinto wilsoniano, che proponeva di rinunciare al Tirolo, alla Dalmazia e al Dodecaneso in nome di una nuova Europa democratica, venne impedito di parlare al Tea- tro della Scala da una gazzarra organizzata da Mussolini con il concorso di arditi e futuristi. Il 23 marzo 1919 sempre Mussolini dava vita, in piazza San Sepolcro, ai fasci di combattimento, che negli anni successivi il regime avrebbe considerato atto fondativo del fascismo. Il 15 aprile 1919 l’assalto alla sede del quotidiano socialista Avanti! in via san Damiano 16 rappresentava il primo atto di squadrismo in Italia. Questa mostra, presentata il 23 marzo 2019 all’interno della corte del commissariato di piazza San Se- polcro, è stata realizzata nell’ambito delle attività del Master in Public History promosso dal Dipartimen- to di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano e dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. -

The Legacy of Antonio Sant'elia: an Analysis of Sant'elia's Posthumous Role in the Development of Italian Futurism During the Fascist Era
San Jose State University SJSU ScholarWorks Master's Theses Master's Theses and Graduate Research Spring 2014 The Legacy of Antonio Sant'Elia: An Analysis of Sant'Elia's Posthumous Role in the Development of Italian Futurism during the Fascist Era Ashley Gardini San Jose State University Follow this and additional works at: https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses Recommended Citation Gardini, Ashley, "The Legacy of Antonio Sant'Elia: An Analysis of Sant'Elia's Posthumous Role in the Development of Italian Futurism during the Fascist Era" (2014). Master's Theses. 4414. DOI: https://doi.org/10.31979/etd.vezv-6nq2 https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/4414 This Thesis is brought to you for free and open access by the Master's Theses and Graduate Research at SJSU ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of SJSU ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. THE LEGACY OF ANTONIO SANT’ELIA: AN ANALYSIS OF SANT’ELIA’S POSTHUMOUS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ITALIAN FUTURISM DURING THE FASCIST ERA A Thesis Presented to The Faculty of the Department of Art and Art History San José State University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts by Ashley Gardini May 2014 © 2014 Ashley Gardini ALL RIGHTS RESERVED The Designated Thesis Committee Approves the Thesis Titled THE LEGACY OF ANTONIO SANT’ELIA: AN ANALYSIS OF SANT’ELIA’S POSTHUMOUS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ITALIAN FUTURISM DURING THE FASCIST ERA by Ashley Gardini APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF ART AND ART HISTORY SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY May 2014 Dr. -

Futurismo Italiano Y Fascismo Paradigmático: Estética Y Política Una Convergencia Problemática
FUTURISMO ITALIANO Y FASCISMO PARADIGMÁTICO: ESTÉTICA Y POLÍTICA UNA CONVERGENCIA PROBLEMÁTICA. ENCUENTRO Y DESENCUENTRO DE DOS FENÓMENOS CONTRADICTORIOS (1909-1922) TESIS DOCTORAL AITOR AURREKOETXEA JIMÉNEZ Donostia 2015 2 FUTURISMO ITALIANO Y FASCISMO PARADIGMÁTICO: ESTÉTICA Y POLÍTICA UNA CONVERGENCIA PROBLEMÁTICA. ENCUENTRO Y DESENCUENTRO DE DOS FENÓMENOS CONTRADICTORIOS (1909-1922) AITOR AURREKOETXEA JIMÉNEZ Tesis realizada para la obtención del Grado de Doctor, dirigida por el Prof. Dr. Mikel Iriondo Aranguren. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social Donostia 2015 3 4 AGRADECIMIENTOS La elaboración de esta tesis doctoral no habría sido posible sin el aliento y la colaboración de algunas personas que me espolearon en todo momento para que no me desanimara, en la creencia sincera de que este trabajo merecía la pena. En primer lugar, quisiera mencionar al profesor Javier San Martín, que prendió en mí el interés por el futurismo italiano y al que debo en gran medida haberme, en última instancia, decantado por esta opción para elaborar mi tesis doctoral, una vez descartada otras. También quería agradecer, como no puede ser de otra manera, el apoyo de mi familia durante el tiempo que ha durado este viaje, de mis padres y de un modo muy particular de Ainhoa y de Maddi, que son quienes permanentemente han estado a mi lado en esta pequeña singladura. Todos ellos me han ayudado a disfrutar del clima propicio para acometer con ánimo este trabajo de investigación. No querría olvidar al personal de todas las bibliotecas y fondos varios que he consultado para la elaboración de la tesis y en especial querría hacer mención a las personas que se encargan del funcionamiento de la bien surtida biblioteca de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, y que han sido más que pacientes conmigo y con mis habituales tardanzas en la devolución de algunos libros y documentos por ellos prestados. -
The Myth of the New Man in Italian Fascist Ideology
fascism 5 (2016) 130-148 brill.com/fasc The Myth of the New Man in Italian Fascist Ideology Jorge Dagnino Universidad de los Andes, Chile [email protected] Abstract This article addresses the key concept of the New Man within Fascist ideology, often considered as means and end of the Fascist revolution by the Fascists. Usually dismissed as an empty slogan by historians, it is argued in the following pages that the myth of the New Man is essential for a better understanding of the regime’s totalitarian and revolutionary aspirations along with its quest of creating an alterna- tive modernity and a post-liberal and post-socialist type of civilisation based on the primacy of the collectivity - a realm where Italians could realise their full potential as human beings. Keywords Italy – Fascism – ideology – myth – New Man This article sets out to address, within the realm of the history of political ideol- ogies, Fascism’s attempt to refashion humankind. The central thesis is that the myth of the New Man can enhance our understanding of Fascism as a revolu- tionary and totalitarian experiment, along with its modern nature; that is, how Fascism, through this myth, sought the revolutionary and ultimate objective of commencing time anew, with the intent of creating a novel type of civilisation and human being based on the collectivity and the state. The myth of the New Man was a key feature in the ideological evolution of the Fascist movement and regime. Indeed, in an interview in late May 1924, Mussolini declared that * Acknowledgment: The article forms part of my FONDECYT project N.3140039, Chile. -

Castor Oil and the Intelligentsia La Inteligencia Y El Aceite De Ricino
CASTOR OIL AND THE INTELLIGENTSIA LA INTELIGENCIA Y EL ACEITE DE RICINO by JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI translated from the Spanish by JUAN CARLOS AGUIRRE 1. The source of this When fascism won over the state and the Eter- quotation about D’An- nunzio is not clear. Else- where, however, Mariáte- nal City, it also won over most of Italy’s intellec- gui quotes at length from the historian Adriano tuals. Some yoked themselves without reserve Tilgher’s analysis of D’An- nunzio’s cultural impact on Italian nationalism. to its wagon and fortunes; others gave it their For more information on Gabriele D’Annunzio, see footnote 4 in Mariátegui’s implicit consent; still others, the most prudent “Scenes from a Civil War” of the lot, adopted a benevolent neutrality to- in this collection. ward it. The Intelligentsia takes pleasure in 2. Filippo Marinetti letting itself be taken by Force. Especially when founded the futurist movement with the pub- lication of “Fondazione e force, as in the case of fascism, is young, dar- Manifesto del futurismo” on the front page of the ing, warriorlike, and adventure-seeking. Parisian daily Le Figaro in February of 1909. This manifesto, which would There was, moreover, a convergence of come to be influential across Europe, demanded a break with the compla- specifically Italian factors in the backing that cency of tradition, and envisioned a new, revo- artists and intellectuals gave fascism. All the lutionary aesthetic em- bracing speed, dynamism, industrialism, aggression, latest chapters of Italian history are steeped war, and misogyny as in the discourse of Gabriele D’Annunzio: “The some of its guiding values. -

The Rape of Europa 1
Introduction: the rape of Europa 1 Introduction: the rape of Europa The machine has become more than a mere adjunct to life. It is really part of human life – perhaps the very soul. (F. Picabia, cit. in ‘French artists spur on American art’, The New York Tribune, 1915) 0.1 Ivo Pannaggi, Il ratto d’Europa (The rape of Europa), 1963–68 The dynamic image in Figure 0.1, projecting energetically forward, is a modern representation of a classical theme: the rape of Europa. The artist is Ivo Pannaggi, the Bauhaus-trained painter, metalworker and architect. This mixed media oil on canvas was completed in the course of five years, drawing on several reworkings, e.g. Centaur (1931) and an etching of 1959. Europa, the beautiful, naked nymph, is cruelly abducted and transported westwards, as is related in the classical myth by Apollodorus. Her rapist, a lusty, tribal Zeus, assaulting his victim in the archaic guise of a bull, undergoes here a modern metamorphosis into a helmet-clad, goggle- wearing centaur, riding a powerful, roaring motorcycle – ‘I motorised Zeus’, Pannaggi proudly declared. Mechanical features and details are on display, from the prominent wheels to handlebars and headlights. Thick fumes exhale from a visible exhaust pipe. 2 Italian futurism and the machine Pannaggi’s polemic against neoclassical figurative painting, betrayed by this parody, is framed within a representational space dominated by an arresting motorcy- cle, magnified in its dazzling mechanical appearance. This is more than a motorcycle. Kidnapping and ensconcing a symbolic Europa, it is modernity itself hurling towards the viewer at infernal speed.