P.G.T. Valutazione Ambientale Strategica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo
comunità montana dell'oltrepò pavese comunità montana dell'o ltrepò pavese Ambito Territoriale: BRALLO DI PREGOLA, S. MARGHERITA STAFFORA, MENCONICO, ROMAGNESE, ZAVATTARELLO, BAGNARIA, RUINO, FORTUNAGO, MONTESEGALE, GODIASCO, ROCCA SUSELLA, BORGO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, CANEVINO, MONTALTO PAVESE, OLIVA GESSI, REDAVALLE, MONTESCANO, CANNETO PAVESE, GOLFERENZO, MORNICO LOSANA, S. MARIA DELLA VERSA, VOLPARA, ZENEVREDO. REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI FRESCHI ANNO 2006 Legge 352 del 23/03/1993 e l.r. 24 del 23/06/1997 Nel territorio dei Comuni sopraindicati è regolamentata da parte della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, la raccolta dei funghi epigei freschi, limitatamente ai corpi fruttiferi indicati nelle leggi in oggetto. MODALITA’ DI RACCOLTA 1. La raccolta è regolamentata nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre unicamente ai possessori di apposito tesserino stagionale o giornaliero, rilasciato dai Comuni o da strutture dagli stessi autorizzate. 2. La raccolta è ammessa dall’alba al tramonto con una limitazione pari a 3 kg. Per persona, tranne che il peso non venga superato da un singolo esemplare, oppure si tratti di un unico carpoforo di Armillaria mellea. 3. La raccolta deve essere effettuata in modo esclusivamente manuale, senza quindi attrezzi ausiliari quali rastrelli, uncini od altro, fatta salva la raccolta di Armillaria mellea per la quale è consentito il taglio del gambo. 4. E’ obbligatorio effettuare una pulitura sommaria dei funghi eduli sul luogo di raccolta. La raccolta dei funghi da sottoporre al riconoscimento presso gli Ispettorati Micologici è necessario avvenga cogliendo esemplari interi o completi di tutte le parti utili alla determinazione della specie. 5. E’ vietato il trasporto dei funghi raccolti in contenitori di plastica ed è obbligatorio l’uso di contenitori atti alla dispersione delle spore. -

Giorgio Negrini
CURRICULUM PROFESSIONALE GIORGIO NEGRINI Geologo/Geotecnico/Idrogeologo Via S. Ambrogio, 24 - 27058 Voghera (PV) Tel. 0383.44546 - Fax 0383.360917 e-mail - [email protected] Giorgio NEGRINI Nato a Voghera (PV) il 22 aprile 1956 Residente a Voghera (PV) in via Giuseppe Garibaldi n°75 Iscritto all’Ordine dei Geologici della Lombardia n°585AP dal 1988 Studio Via S. Ambrogio, 24 - 27058 Voghera (PV) Telefono 0383.44546 Fax 0383.360917 Portatile 3485107524 e-mail [email protected] e-mail certificata PEC [email protected] P. IVA 01137380182 C.F. NGRGRG56D22M109Q Pagina 1 Giorgio NEGRINI Geologo/Geotecnico Nato a Voghera (PV) il 22 aprile 1956 Laureato in Scienze Geologiche (Indirizzo Applicativo) presso l'Università degli Studi di Pavia iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia (Albo Professionale Sezione A) dal 1988 con numero di riferimento 585 AP Sufficiente conoscenza parlata e scritta della lingua inglese Buona conoscenza dei sistemi informatici operativi e dei software più diffusi Coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzione (D.lgs. 494/96) conseguito con un corso abilitante di 120 ore. Esperto in materia di tutela paesistico e ambientale – conseguito nel 1998 con corso abilitante della Regione Lombardia. Iscritto all'Albo regionale dei Collaudatori della Regione Lombardia n°2851 per le categorie: 1. Ponti e gallerie 2. Opere di sistemazione forestale 3. Opere stradali Qualificato prestatori di servizi di ingegneria RFI-Rete Ferroviaria Italiana Cat. B8 “Studi geologi e geotecnici” - classe di importo 3 (fino a € 100.000) Qualificato prestatori di servizi di ingegneria FRN-Ferrovie Nord Milano - Nord_Ing Cat. H “Supporto per geologia e geotecnica” - classe di importo 2 (fino a € 100.000) Cat. -

Elenco Comuni Lombardia – Classificazione Istat Zona Altimetrica
ELENCO COMUNI LOMBARDIA – CLASSIFICAZIONE ISTAT ZONA ALTIMETRICA Provincia Codice ISTAT Denominazione Comune Zona altimetrica ISTAT Comune Comune Bergamo 016001 Adrara San Martino Montagna Bergamo 016002 Adrara San Rocco Montagna Bergamo 016003 Albano Sant'Alessandro Collina Bergamo 016004 Albino Montagna Bergamo 016005 Almè Collina Bergamo 016006 Almenno San Bartolomeo Collina Bergamo 016007 Almenno San Salvatore Collina Bergamo 016008 Alzano Lombardo Collina Bergamo 016009 Ambivere Collina Bergamo 016010 Antegnate Pianura Bergamo 016011 Arcene Pianura Bergamo 016012 Ardesio Montagna Bergamo 016013 Arzago d'Adda Pianura Bergamo 016014 Averara Montagna Bergamo 016015 Aviatico Montagna Bergamo 016016 Azzano San Paolo Pianura Bergamo 016017 Azzone Montagna Bergamo 016018 Bagnatica Pianura Bergamo 016019 Barbata Pianura Bergamo 016020 Bariano Pianura Bergamo 016021 Barzana Collina Bergamo 016022 Bedulita Montagna Bergamo 016023 Berbenno Montagna Bergamo 016024 Bergamo Collina Bergamo 016025 Berzo San Fermo Montagna Bergamo 016026 Bianzano Montagna Bergamo 016027 Blello Montagna Bergamo 016028 Bolgare Pianura Bergamo 016029 Boltiere Pianura Bergamo 016030 Bonate Sopra Pianura Bergamo 016031 Bonate Sotto Pianura Bergamo 016032 Borgo di Terzo Montagna Bergamo 016033 Bossico Montagna Bergamo 016034 Bottanuco Pianura Bergamo 016035 Bracca Montagna Bergamo 016036 Branzi Montagna Bergamo 016037 Brembate Pianura Bergamo 016038 Brembate di Sopra Pianura Bergamo 016040 Brignano Gera d'Adda Pianura Bergamo 016041 Brumano Montagna Bergamo 016042 Brusaporto -
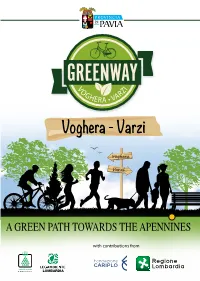
Greenway V O I G Rz Hera • Va
GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Voghera Varzi A GREEN PATH TOWARDS THE APENNINES with contributions from Credits Voghera - Varzi Greenway: a green path towards the Apennines • The guide to the route is a project promoted by Provincia di Pavia in partnership with Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese and Legambiente Lombardia, with contributions from the Fondazione Cariplo and Regione Lombardia. Editing, design, graphics, text, layout and printing: Bell&Tany, Voghera, bell-tany.it. Finished printing in the month of June 2021. ©Province of Pavia 2021 ©Bell&Tany 2021 All rights reserved. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited. www.provincia.pv.it www.visitpavia.com www.greenwayvogheravarzi.it This guide is printed respecting the environment on recycled paper. discovering the OLTREPÒ PAVESE 2044 0053 AT / 11 / 002 GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Exploring Walking Cycling Savouring discovering the OLTREPÒ PAVESE 2 The Voghera - Varzi Greenway is ready. It is a 33 kilometers long dream, begone when dreaming cost nothing. When thinking of recovering the old railway line was a romantic, good and appealing idea, yet so unlikely. Still we succeeded. With passion, persistence, and a lot of good will. If it is true, as Eleanor Roosevelt wrote, “that the future belongs to the ones who believe in the beauty of their dreams”, therefore today we are giving Oltrepò a little something to hope a different, better future. Discovering the territory, experiencing the natural beauty, sharing the pleasure of good food, letting the silence of unexpected and magical places conquer ourselves, being together with friend hoping the time will never pass. -

Comune Di Miradolo Terme
COMUNE DI MIRADOLO TERME PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 6 DdP Documento di Piano IL PAESAGGIO ED IL RAPPORTO Fascicolo CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del SINDACO PROGETTISTA Gianpaolo Troielli dott. arch. Mario Mossolani COLLABORATORI dott. urb. Sara Panizzari dott. Ing. Giulia Natale SEGRETARIO dott. ing. Marcello Mossolani Dott. Flavia Fulvio geom. Mauro Scano TECNICO COMUNALE Geom. Orazio Pacella STUDI NATURALISTICI dott. Massimo Merati dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it PGT del Comune di Miradolo Terme PAESAGGIO COMUNE DI MIRADOLO TERME Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO Il Paesaggio INDICE 1..PAESAGGIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ..................................................................................................... 8 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................. 8 1.2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO .......................................................................... 9 PARTE I IL PIANO DEL PAESAGGIO DI MIRADOLO TERME SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ..................... 11 2..IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE PPR ............................................... 12 2.1. CONTENUTI DEL PPR ...................................................................................... -

P.G.T. Valutazione Ambientale Strategica
P.G.T. Valutazione Ambientale Strategica Comune di BAGNARIA SINTESI NON TECNICA Adeguamento novembre 2011 VAS – SINTESI NON TECNICA INDICE 1. Obiettivi e contenuti del Rapporto Ambientale VAS 3 2. Il contesto di riferimento ambientale 8 3. Scenario di riferimento per il PGT 11 4. Proposte di Progetto: le azioni strategiche 15 5. Criteri ambientali e misure di mitigazione per l’attuazione del PGT 18 6. Sistema di monitoraggio 28 PGT BAGNARIA 2 VAS – SINTESI NON TECNICA Sintesi non tecnica 1. Obiettivi e contenuti del Rapporto Ambientale VAS Questo documento rappresenta la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale VAS del Documento di Piano di Bagnaria Il Rapporto Ambientale è realizzato ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato I della Direttiva europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica e conforme agli Indirizzi generali per la valutazione ambientalie di piani e programmi, deliberati dal consiglio regionale della Regione Lombardia con d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007 e della DGR 6420 del 30 dicembre 2007, aggiornata dalla DGR 10971 del 30/12/2009. Il documento è predisposto nell’intento di aumentare la comprensione delle ricadute ambientali derivanti dalle azioni antropiche e di favorire la partecipazione collettiva ai processi di pianificazione. La documentazione prodotta nell’ambito della VAS è parte integrante del Documento di Piano nonché del PGT. La procedura di VAS, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto agli obiettivi di sostenibilità del PGT e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus 151-1
Orari e mappe della linea bus 151-1 151-1 Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 151-1 () ha 2 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) : 05:05 - 20:35 (2) : 05:10 - 20:10 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 151-1 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 151-1 Direzione: Orari della linea bus 151-1 46 fermate Orari di partenza verso : VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:05 - 20:35 martedì 05:05 - 20:35 Voghera Autostazione Via dello Scalo, Voghera mercoledì 05:05 - 20:35 Voghera Minzoni/Cagnoni (Istituto) giovedì 05:05 - 20:35 106 Via Don Giovanni Minzoni, Voghera venerdì 05:05 - 20:35 Voghera Gramsci/Meardi sabato 05:05 - 20:35 1 Via Antonio Gramsci, Voghera domenica 07:10 - 19:10 Voghera Della Repubblica/Gramsci 7 Viale Repubblica, Voghera Voghera Della Repubblica/Foscolo 25 Viale Repubblica, Voghera Informazioni sulla linea bus 151-1 Direzione: Voghera Della Repubblica/Morelli Di Popolo Fermate: 46 79 Viale Repubblica, Voghera Durata del tragitto: 44 min La linea in sintesi: Voghera Autostazione, Voghera Rivanazzano Europa/Baracca (Aeroporto) Minzoni/Cagnoni (Istituto), Voghera SP461, Rivanazzano Terme Gramsci/Meardi, Voghera Della Repubblica/Gramsci, Voghera Della Repubblica/Foscolo, Voghera Della Rivanazzano Europa/Molinetti Repubblica/Morelli Di Popolo, Rivanazzano Europa/Baracca (Aeroporto), Rivanazzano Rivanazzano Europa/Caifango Europa/Molinetti, Rivanazzano Europa/Caifango, Rivanazzano Europa/Bagnolo, Rivanazzano Della Rivanazzano Europa/Bagnolo Repubblica/Mandelli -
Estratto Valli Del Vino
UN ITINERARIO TRA LE VALLI E I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA PER CONOSCERE UNA TERRA DI VINI PREGIATI A GUIDE TO THE MOST PICTURESQUE VALLEYS AND VILLAGES IN ITALY AND THEIR FINE WINES Itineraries VALLI VERSA, COPPA E SCUROPASSO The Wine Valleys THE VERSA, COPPA AND SCUROPASSO VALLEYS LA PROVINCIA DI PAVIA, THE PROVINCE OF PAVIA, con la forza della qualità e della bellezza, ha selezionato Confident of the beauty of the territory and what it has con gli operatori del territorio 4 itinerari che favoriscono to offer visitors, the provincial authorities have joined with la scoperta di luoghi di grande attrattiva. various organisations operating in the area to draw up four itineraries that will allow travellers to discover intriguing Sono 4 itinerari che suggeriscono approcci diversi new destinations. e che valorizzano le diverse vocazioni di un territorio poco conosciuto e proprio per questo contraddistinto Four different itineraries that present the varied vocations da una freschezza tutta da scoprire. of a little-known territory just waiting to be discovered. Un turismo intelligente fruibile tutti i giorni dell’anno, Intelligent tourism accessible all year-round in the heart vissuto nel cuore del territorio lombardo, fra pianura, of Lombardy - ranging from the plains to the hills and the colline e Appennino, ideale per scoprire la storia, Appenine Mountains, a voyage into the history, the culture la cultura e la natura a pochi passi da casa. and the natural beauty that lies just around the corner. • VIGEVANO • MEDE • PAVIA • MIRADOLO TERME • -

PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016
PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016 Cassolnovo Gravellona Lomellina Confienza Siziano Cilavegna Vigevano Casorate Primo Landriano Bascape' Robbio XW Palestro Rognano Alb$+onese Vidigulfo Nicorvo Trovo Parona " A@ ) Giussago Torrevecchia Pia BattudaVellezzo Bellini Bornasco Castelnovetto Trivolzio Zeccone Gambolo' ! Ceranova Rosasco Bereguardo Ceretto Lomellina MarcignagoCertosa di Pavia Marzano Mortara Borgo San Siro Sant'angelo Lomellina ! Borgarello Lardirago San Genesio Ed Uniti Torre d'Arese Castello d'Agogna Roncaro Villanterio Torre d'Isola Sant'alessio Con Vialone Langosco Magherno Zerbolo' Cozzo Tromello Vistarino Olevano di Lomellina Cura Carpignano Garlasco Gerenzago Cergnago Pavia Copiano Inverno E Monteleone Zeme Albuzzano A@*# Filighera Candia Lomellina San Giorgio di Lomellina Gropello Cairoli Carbonara Al Ticino Miradolo Terme Valle Salimbene XW$+ Alagna Villanova d'Ardenghi Corteolon$+a e Genzone Velezzo Lomellina San Martino Siccomario Valle Lomellina Ottobiano Santa Cristina E Bissone Linarolo ! Valeggio Dorno )"* Travaco' Siccomario Chignolo Po BelgioiosoTorre De'Negri Semiana Costa De' Nobili Breme Scaldasole Zinasco Mezzanino Monticelli Pavese Cava Manara Badia Pavese Lomello Sommo Spessa Rea Albaredo Arnaboldi Verrua Po San Zenone Al Po Monticelli Pavese San Cipriano Po Zerbo Sartirana Lomellina Ferrera Erbognone Pieve Albignola Pieve Porto Morone Mezzana Rabattone Mede Sannazzaro De'Burgondi Bastida Pancarana Portalbera Galliavola Pancarana Casanova LonatiCampospinoso Villa Biscossi Silvano -

Rideterminazione Ambiti Territoriali Di Assistenza Primaria E Di Pediatria Di Libera Scelta a Seguito Di Fusione Di Comuni
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187 DECRETO N. 495/DGi DEL 08/11/2019 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI OGGETTO: Rideterminazione ambiti territoriali di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta a seguito di fusione di comuni. Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA (Firmato digitalmente) DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI (Firmato digitalmente) DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Responsabile F.F. UOC Rete Assistenza Primaria e Continuità delle Cure Dr.ssa Raffaella Brigada (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amministrativo Franco Brasca L'anno 2019 addì 08 del mese di Novembre IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia; Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. -

Denominazione E Ragione Sociale Sede Legale Sede
SEDE SECONDARIA CON DATA PRESENTAZIONE STORICO E RICHIESTE DI RINNOVO DENOMINAZIONE E RAGIONE CODICE FISCALE PARTITA STATO DELLA SCADENZA SEDE LEGALE RAPPRESENTANZA STABILE IN ISTANZA DI ISCRIZIONE O ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN ISTRUTTORIA (*BDNA=banca dati SOCIALE IVA PRATICA ISCRIZIONE ITALIA DI RINNOVO nazionale antimafia) TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - 27100 Pavia, Via ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E 5 M AUTOTRASPORTI S.R.L. 01483150189 02/11/2018 ISCRITTA 14/02/2020 Sagliona n. 240 MATERIALI INERTI- NOLLI A CALDO - AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Parona Lomellina, via ABONECO RECYCLING S.R.L. 02194460180 25/09/2018 ISCRITTA 06/03/2020 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI S.S. km.35 SNC TRASPORTO MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - Parona Lomellina, Strada TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ABONECO S.R.L. 01280780188 15/01/2019 ISCRITTA 07/03/2020 Statale 494 Km 35 s.n.c. SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI - NOLI A CALDO - AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 27043 Broni, via A. da In corso istruttoria per rinnovo ACHILLE GIANCARLO CHLGCR65D16B201P 30/10/2019 IN AGGIORNAMENTO AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Giussano n. 46 iscrizione Ferrera Eerbognone, TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ACTA S.R.L. 02386550186 15/05/2019 ISCRITTA 09/07/2020 Cascina Gallona snc SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI Pieve del Cairo, Via ESTRAZIONE,FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E AEP COSTRUZIONI S.R.L 12053840158 30/04/2018 ISCRITTA 10/05/2020 RINNOVO CON BDNA Guasca n.1 MATERIALI INERTI - NOLI A CALDO ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO TERRA E Mezzana Bigli, Via SCADUTA MATERIALI INERTI - CONFEZIONAMENTO FORNITURA E AGEST COSTRUZIONI S.R.L. -

Dottore Architetto Marcello Passerini
dottore architetto marcello passerini A GENERALITÀ A1 Dott. arch. Marcello Passerini nato a Pavia il 12.10.1968 A2 Residenza a Noli (SV), contrada Monte, 2a Studio a Pavia, corso A. Manzoni, 100 tel. 0382/309582 –335/455763 - fax 0382/537113 e - mail: [email protected] A3 Codice fiscale PSS MCL 68R12 G388I P.IVA 01237930092 A4 Iscrizione all’Albo degli Architetti della provincia di Savona al n° 483. A5 Condizione professionale: A5.1.0 Libero professionista B TITOLI B1 Laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nell’anno 1998 con tesi riguardante l’evoluzione del dettaglio Tecnologico nell’architettura nord Europea e, in particolare, nell’esperienza architettonica di Alvar Aalto. B2 Esame di Stato presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano nell’anno 1998. B3 Altre specializzazioni o Aggiornamenti: B3.1 Corso di 120 ore per specializzazione in Sicurezza nel coordinamento della progettazione e direzione dei lavori a sensi del D.L.vo 494/96 presso l’Ente Scuola Edile di Pavia B3.2 Corso di aggiornamento presso la Scuola Edile di Pavia per l’aggiornamento in materia di Sicurezza nei cantieri edili ex D.Lgs. 81/2008 (5 moduli) B6 Lingue straniere conosciute INGLESE parlato e scritto a livello avanzato C INCARICHI DI CONSULENZA E ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 C2 Esperienza trimestrale di applicato esterno presso la fondazione Alvar Aalto – Muunkiniemi – Helsinki – Finlandia. C4 Incarichi pubblici di consulenza od assimilabili: • 2006 - 2009 Responsabile del servizio Tecnico comprendente