Memorie Della Accademia Delle Scienze Di Torino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Esercitati GRATIS On-Line! N
N. Domanda A B C D 885 DA CHI ERA COMPOSTO IL SERRISTORI, RICASOLI, PERUZZI, GUERRAZZI, LAMBRUSCHINI, GOVERNO PROVVISORIO RIDOLFI, CAPPONI PUCCIONI MONTANELLI, GIORGINI, MORDINI TOSCANO PROCLAMATO L'8 MAZZONI FEBBRAIO 1849 IN SEGUITO ALLA FUGA DA FIRENZE DI LEOPOLDO II? 886 NEL MARZO 1849, DURANTE LA A NOVARA A MONCALIERI A MAGENTA A CUSTOZA SECONDA FASE DELLA PRIMA GUERRA DI INDIPENDENZA, IN QUALE LOCALITA' LE TRUPPE DEL REGNO DI SARDEGNA FURONO SCONFITTE DALLE TRUPPE AUSTRIACHE? 887 IN QUALE LOCALITA' VITTORIO A VIGNALE A VILLAFRANCA A CUSTOZA A NOVARA EMANUELE II ACCETTO' LE CONDIZIONI ARMISTIZIALI DEL FELDMARESCIALLO RADETZKY? 888 QUALE TRA I SEGUENTI FRANCESCO CARLO PISACANE SILVIO PELLICO DANIELE MANIN PERSONAGGI PRESE PARTE ALLA DOMENICO DIFESA DI ROMA NEL 1849? GUERRAZZI 889 IN SEGUITO ALLA RESA DELLA PORTARE AIUTO PORTARE AIUTO AL ATTACCARE I ASSEDIARE PIO IX REPUBBLICA ROMANA, CON ALLA DIFESA DI GOVERNO FRANCESI A A GAETA QUALE OBIETTIVO GARIBALDI, VENEZIA PROVVISORIO CIVITAVECCHIA INSIEME A 4000 UOMINI, LASCIO' TOSCANO ROMA? 890 CHI E' L'AUTORE DELL'OPUSCOLO GIUSEPPE GIUSEPPE GIUSTI GIUSEPPE FERRARI GIUSEPPE MAZZINI "LA FEDERAZIONE MONTANELLI REPUBBLICANA", PUBBLICATO A CAPOLAGO NEL 1851? 891 QUALI POTENZE INTERRUPPERO SPAGNA E PRUSSIA E RUSSIA E IMPERO FRANCIA E LE RELAZIONI DIPLOMATICHE CON PORTOGALLO AUSTRIA OTTOMANO INGHILTERRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE NEL 1856? 892 QUALE DIPLOMATICO SABAUDO EMILIO VISCONTI LUIIG AMEDEO COSTANTINO LUIGI PRINETTI COLLABORO' IN MODO DECISIVO VENOSTA MELEGARI NIGRA CON CAVOUR NELLE TRATTATIVE -

Delpaese E Le Forze Armate
L’ITALIA 1945-1955 LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE STATO MAGGIORE DELLA DIFESA UFFICIO STORICO E LE Commissione E LE FORZE ARMATE Italiana Storia Militare MINISTERO DELLA DIFESA CONGRESSOCONGRESSO DIDI STUDISTUDI STORICISTORICI INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI CISM - Sapienza Università di Roma ROMA, 20-21 NOVEMBRE 2012 Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) Palazzo Salviati ATTI DEL CONGRESSO PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione © 2014 • Ministero della Difesa Ufficio Storico dello SMD Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma [email protected] A cura di: Dott. Piero Crociani Dott.ssa Ada Fichera Dott. Paolo Formiconi Hanno contribuito alla realizzazione del Congresso di studi storici internazionali CISM Ten. Col. Cosimo SCHINAIA Capo Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD Ten. Col. Fabrizio RIZZI Capo Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD CF. Fabio SERRA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD 1° Mar. Giuseppe TRINCHESE Capo Segreteria dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Francesco D’AURIA Addetto alla Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Giovanni BOMBA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD ISBN: 978-88-98185-09-2 3 Presentazione Col. Matteo PAESANO1 Italia 1945-1955 la ricostruzione del Paese el 1945 il Paese è un cumulo di macerie con una bassissima produzione industriale -

Memorie Della Accademia Delle Scienze Di Torino
Memorie della Accademia delle Scienze di Torino Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche Serie V, Volume 37, fasc. 2 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO 2013 2013 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO Via Accademia delle Scienze, 6 10123 Torino, Italia Uffi ci: Via Maria Vittoria, 3 10123 Torino, Italia Tel. +39-011-562.00.47; Fax +39-011-53.26.19 Tutti i saggi che appaiono nelle «Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino» sono valutati da referees anonimi attraverso un sistema di peer review. L’Accademia vende direttamente le proprie pubblicazioni. Per acquistare fascicoli scrivere a: [email protected] Per contattare la Redazione rivolgersi a [email protected] I lettori che desiderino informarsi sulle pubblicazioni e sull’insieme delle attività dell’Accademia delle Scienze possono consultare il sito www.accademiadellescienze.it ISSN: 1120-1622 ISBN: 978-88-908669-2-0 Fig. 1. PIETRO LUIGI ALBINI (1807-1863) Biblioteca Patetta, Università degli Studi di Torino. (Ritratto a olio, dono del Dott. Lino Vetere). Ringraziamenti Per la cortese collaborazione e per l’autorizzazione a riprodurre i documenti qui di se- guito indicati un vivo ringraziamento va all’Università degli Studi di Torino (Biblioteca F. Patetta del Dipartimento di Giurisprudenza, fi g. 1 e 7, e Rettorato, fi g. 2); all’Accade- mia delle Scienze di Torino (fi g. 3), alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera (fi g. 6 e 8) e a Daniele Pennavaria per la documentazione fotografi ca. Acc. Sc. Torino Memorie Sc. Mor. 37, 2 (2013), 5-102 DIRITTO E STORIA DEL DIRITTO Alle origini della fi losofi a del diritto a Torino: Pietro Luigi Albini Con due documenti sulla collaborazione di Albini con Mittermaier Memoria del Socio corrispondente MARIO G. -

Enjoy Your Visit!!!
declared war on Austria, in alliance with the Papal States and the Kingdom of the Two Sicilies, and attacked the weakened Austria in her Italian possessions. embarked to Sicily to conquer the Kingdom of the Two Sicilies, ruled by the But Piedmontese Army was defeated by Radetzky; Charles Albert abdicated Bourbons. Garibaldi gathered 1.089 volunteers: they were poorly armed in favor of his son Victor Emmanuel, who signed the peace treaty on 6th with dated muskets and were dressed in a minimalist uniform consisting of August 1849. Austria reoccupied Northern Italy. Sardinia wasn’t able to beat red shirts and grey trousers. On 5th May they seized two steamships, which Austria alone, so it had to look for an alliance with European powers. they renamed Il Piemonte and Il Lombardo, at Quarto, near Genoa. On 11th May they landed at Marsala, on the westernmost point of Sicily; on 15th they Room 8 defeated Neapolitan troops at Calatafimi, than they conquered Palermo on PALAZZO MORIGGIA the 29th , after three days of violent clashes. Following the victory at Milazzo (29th May) they were able to control all the island. The last battle took MUSEO DEL RISORGIMENTO THE DECADE OF PREPARATION 1849-1859 place on 1st October at Volturno, where twenty-one thousand Garibaldini The Decade of Preparation 1849-1859 (Decennio defeated thirty thousand Bourbons soldiers. The feat was a success: Naples di Preparazione) took place during the last years of and Sicily were annexed to the Kingdom of Sardinia by a plebiscite. MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY LABORATORY Risorgimento, ended in 1861 with the proclamation CIVIC HISTORICAL COLLECTION of the Kingdom of Italy, guided by Vittorio Emanuele Room 13-14 II. -

Antonio Rosmini on Property It Showed Itself As a Part of God’S Calling
Journal of Markets & Morality Volume 7, Number 1 (Spring 2004): 63–97 Copyright © 2004 A Sphere Around Alberto Mingardi Policy Director the Person: Istituto Bruno Leoni (Turin, Italy) Antonio Rosmini and Visiting Fellow Centre for the New Europe on Property* (Brussels, Belgium) Father Antonio Rosmini-Serbati (1797–1855) is an author of growing interest and curiosity to his fellow churchmen, as well as to secular intellectuals, as a philosopher who successfully reconciled reason and faith. Nevertheless, the political nuances of his thought have barely been explored by English-speaking scholars, and even among his Italian followers these have not been fully appre- ciated. This article attempts to present an overview of Rosmini’s political philoso- phy, focusing on his concern for the protection of private property rights and arguing that it is precisely his advocacy of private property that determines his attitude toward the general organization of associated life, government, and democracy. The organization of this investigation consists of four parts. The first pro- vides a brief biographical sketch of Antonio Rosmini. The second tentatively enlists the main influences in the development of Rosmini’s thought as far as politics and economics are concerned. The third is devoted to examining his approach toward property. The fourth examines his definition of social justice in the light of his justification of property. Introduction In this article, I introduce the reader to the figure of Antonio Rosmini, provide a biographical sketch, and subsequently approach his thought on private prop- erty. As a priest and a devout Catholic, religious faith was central to every aspect of Rosmini’s philosophy. -

Radici Della Costituzione Materiale
Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze Politiche ________ Tesi di dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale Curriculum in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate XXVIII ciclo ALLE RADICI DELLA COSTITUZIONE MATERIALE Dottorando: Simone Ferraro anno accademico 2015-2016 ii a Gabriella Lubrano iii iv INDICE INTRODUZIONE IX CAPITOLO I. Forme politiche e Costituzione I. 1 La Costituzione materiale fra passato e presente 3 I. 2. I processi di democratizzazione ed istituzionalizzazione dei corpi intermedi 15 durante la “crisi dell’ordine liberale”: i loro sviluppi nell’immediato dopoguerra, e, nella loro interpretazione, le possibili influenze del costituzionalismo liberale I. 3. L’interpretazione offerta dal costituzionalismo liberale dei concetti di Stato, 27 Società, Costituzione CAPITOLO II. 1848-1860 La nascita della Carta albertina e le sue modifiche II.1. Tendenze e caratteri nella storia costituzionale italiana del periodo 51 statutario II. 2. Corsi e ricorsi storici: la questione costituzionale e la Carta albertina 59 II. 3. (Segue) le modifiche della Carta albertina 89 CAPITOLO III. Popolo e potere elettorale: dal Regio decreto 17 marzo 1848, n. 680 al Regio decreto 21 settembre 1882, n. 999 III.1. La legislazione elettorale nella Carta albertina 113 III.2 La riforma del sistema elettorale del 1882 123 III.3. Il potere legislativo e la rappresentanza nella riflessione della 135 giuspubblicistica nazionale CAPITOLO IV. 1912-1919 L’organizzazione del corpo elettorale e la sua influenza sull’assemblea rappresentativa e sulla sua evoluzione IV.1. Rappresentanza e forma di governo in evoluzione 149 IV.2. Analisi storica “dell’arena”: le Camere e le Commissioni parlamentari 165 IV.3. -

Kazdan Pak Dissertation
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Italy's Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 Permalink https://escholarship.org/uc/item/7fh45860 Author Pak, Julie Kazdan Publication Date 2012 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Italy’s Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Julie Kazdan Pak 2012 © Copyright by Julie Kazdan Pak 2012 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Italy’s Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 by Julie Kazdan Pak Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2012 Professor Geoffrey Symcox, Chair This dissertation concerns the feminization of the Italian teaching profession between the introduction of pre-Unification schooling in 1859 and the nationalization of that system in 1911. By feminization, this dissertation refers both to the gradual assumption of the majority of elementary teaching positions by women and to a transformation in the nature of the position itself. Through an examination of educational periodicals, school records, government inquests, and accounts by teachers and pedagogical theorists, it argues that rather than the unintended consequence of economic constraints or shifting labor patterns, feminization was fundamentally connected to larger processes of centralization and modernization in the Italian school system. Following an introductory chapter outlining the major national, religious, and gender debates of ii the Unification era, the second chapter of the dissertation argues that the figure of the female elementary teacher became embroiled in the contest between local and national interests, furthering the drive toward centralization. -

Cavour 02 Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina I
Cavour 02_Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina I NEL NOME DEL GRANDE STATISTA Le Logge “Cavour” a Torino dall’Unità ai giorni nostri Cavour 02_Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina II Cavour 02_Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina III MARCO NOVARINO NEL NOME DEL GRANDE STATISTA Le Logge “Cavour” a Torino dall’Unità ai giorni nostri Cavour 02_Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina IV Tutti i diritti riservati © 2011, Sottosopra Edizioni Corso Vittorio Emanuele II, 41 10125 Torino (Italia) Prima edizione ISBN 978-88-89724-36-1 È vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale o a uso interno e didattico con qualsiasi mezzo effettuata. IV Cavour 02_Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina V In ricordo di Ferdinando Cordova, maestro e amico Cavour 02_Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina VI Cavour 02_Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina VII Sommario PREMESSA DI GUSTAVO RAFFI .......................................................................................................................... IX PREFAZIONE DI SANTI FEDELE ......................................................................................................................... XI RINGRAZIAMENTI ...................................................................................................................................................... XV 1. LA NASCITA E L’OPERA DELLA PRIMA LOGGIA “CAVOUR” ALL’ORIENTE DI TORINO ........................................................................................................................ 1 1.1 Gli antecedenti .................................................................................................................................... -
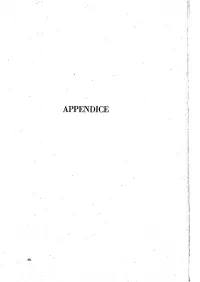
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

1 “Le Riforme Nella Scuola Italiana Dal 1859 Al 2003”
“Le riforme nella scuola italiana dal 1859 al 2003” SCHEDE a cura di Elena Bertonelli e Giaime Rodano con la consulenza di Giorgio Chiosso e Giuseppe Tognon settembre 2003 1 Indice n “Le riforme nella scuola italiana dal 1859 al 2003” n Questo corso n 1. La scuola nella prima fase dello Stato unitario n 1.1 La legge Casati n 1.2 La legge Coppino n 1.3 L’età giolittiana n 2. La scuola fra le due guerre n 2.1 La riforma Gentile n 2.2 I “ritocchi” e la fascistizzazione della scuola n 2.3. La “Carta della scuola” n 3. La scuola della Costituzione n 3.1 La scuola alla Costituente n 3.2. La scuola negli anni ’50 n 3.3 La Scuola media unica n 3.4. I Decreti Delegati e le sperimentazioni n 4. La scuola verso una riforma di sistema n 4.1 Il “mosaico” della XIII legislatura n 4.2. Le novità della XIV legislatura 2 Questo corso mira a ricostruire nei suoi tratti essenziali i mutamenti più significativi che hanno contraddistinto - lungo un arco di quasi 150 anni - il modo di essere. di vivere e di operare della scuola italiana. Saranno considerati sia gli interventi di carattere ordinamentale che - a partire dalla riforma Casati sino a quelle dei nostri giorni - hanno modificato l’architettura complessiva del nostro sistema di istruzione e di formazione, sia quelle innovazioni di segno metodologico e organizzativo - ad esempio i Decreti Delegati e il Regolamento dell’autonomia - che hanno di volta in volta contribuito a mutare il rapporto della scuola con la società civile. -

The Invisible Bridge Between the United Kingdom and Piedmont
The Invisible Bridge between the United Kingdom and Piedmont The Invisible Bridge between the United Kingdom and Piedmont By Andrea Raimondi With a contribution by Giorgio Rossi Accastello The Invisible Bridge between the United Kingdom and Piedmont By Andrea Raimondi This book first published 2019 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2019 by Andrea Raimondi All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-2806-5 ISBN (13): 978-1-5275-2806-2 TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ................................................................................... vii Acknowledgements ................................................................................. viii Introduction ................................................................................................ 1 Chapter One .............................................................................................. 12 The Vercelli Book Chapter Two ............................................................................................. 23 Guala Bicchieri Chapter Three .......................................................................................... -

Rocce Cristalli Meteoriti
ROCCE A cura di Margherita Bongiovanni Carlo Clerici CRISTALLI Alessandro Delmastro Lorenzo Mariano Gallo METEORITI Elisa Vanin ROCCE CRISTALLI METEORITI Le collezioni storiche geomineralogiche e minerarie del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino ROCCE CRISTALLI METEORITI POLITECNICO BIBLIOM DI TORINO Area Bibliotecaria e Museale www.polito.it DIATI Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture Catalogo mostra 210x210+3.indd 2 27/09/2018 15:04:17 ROCCE CRISTALLI METEORITI Le collezioni storiche geomineralogiche e minerarie del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino A cura di Margherita Bongiovanni Carlo Clerici Alessandro Delmastro Lorenzo Mariano Gallo Elisa Vanin POLITECNICO BIBLIOM DI TORINO Area Bibliotecaria e Museale DIATI Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture 1 Catalogo mostra 210x210+3.indd 1 27/09/2018 15:04:17 Catalogo mostra 210x210+3.indd 2 27/09/2018 15:04:17 In copertina. POLITECNICO BIBLIOM Galena: DI TORINO Area Bibliotecaria e Museale cristalli fino a 15 mm di spigolo. DIATI Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, Miniera di Traversella, Torino. del Territorio e delle Infrastrutture Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. Foto Roberto Appiani. Rocce, Cristalli, Meteoriti Le collezioni storiche geomineralogiche e minerarie del Dipartimento di