Memorie Della Accademia Delle Scienze Di Torino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Memorie Della Accademia Delle Scienze Di Torino
1 Memorie della Accademia delle Scienze di Torino Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche Serie V, Volume 38, fasc. 3 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO 2014 Memorie Morali_32mi - seg 1 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO Via Accademia delle Scienze, 6 10123 Torino, Italia Uffici: Via Maria Vittoria, 3 10123 Torino, Italia Tel. +39-011-562.00.47; Fax +39-011-53.26.19 Tutti i saggi che appaiono nelle «Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino» sono valutati da referees anonimi attraverso un sistema di peer review. L’Accademia vende direttamente le proprie pubblicazioni. Per acquistare fascicoli scrivere a: [email protected] Per contattare la Redazione rivolgersi a: [email protected] I lettori che desiderino informarsi sulle pubblicazioni e sull’insieme delle attività dell’Accademia delle Scienze possono consultare il sito www.accademiadellescienze.it In copertina: Busto di Pietro Luigi Albini nel Loggiato del Rettorato, Università degli Studi, Torino. ISSN: 1120-1622 ISBN: 978-88-99471-01-9 Busto di Pietro Luigi Albini nel Palazzo Civico di Vigevano. Ringraziamenti Un vivo ringraziamento va anzitutto all’Accademia delle Scienze di Torino, all’Ar- chivio della Universitätsbibliothek di Heidelberg e alla Biblioteca Norberto Bobbio, Sezione Patetta – Antichi e Rari, Università degli Studi, Torino, che hanno autorizzato la pubblicazione delle lettere di Albini, di Sclopis e di Mittermaier conservate nei loro archivi. Inoltre, nell’impossibilità di ringraziare individualmente le persone che -
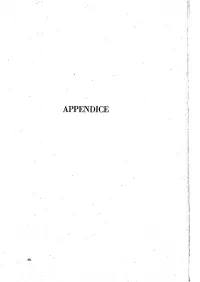
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

The Invisible Bridge Between the United Kingdom and Piedmont
The Invisible Bridge between the United Kingdom and Piedmont The Invisible Bridge between the United Kingdom and Piedmont By Andrea Raimondi With a contribution by Giorgio Rossi Accastello The Invisible Bridge between the United Kingdom and Piedmont By Andrea Raimondi This book first published 2019 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2019 by Andrea Raimondi All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-2806-5 ISBN (13): 978-1-5275-2806-2 TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ................................................................................... vii Acknowledgements ................................................................................. viii Introduction ................................................................................................ 1 Chapter One .............................................................................................. 12 The Vercelli Book Chapter Two ............................................................................................. 23 Guala Bicchieri Chapter Three .......................................................................................... -

Parte Ii Da Vittorio Emanuele Ii a Umberto I
FEDERICO BONA STEMMI DEI CAVALIERI DELL’ANNUNZIATA DA CARLO EMANUELE IV A UMBERTO II **** PARTE II DA VITTORIO EMANUELE II A UMBERTO I (1849 – 1900) LUGLIO 2012 Vittorio Emanuele II XXIV Gran Maestro dell’Ordine 1849 1849 1849 Napoleone III Francesco d’Assisi Ferdinando II imperatore dei Francesi re di Spagna re del Portogallo 1850 1850 1850 1850 Giovanni Federico Augusto di Federico di Prussia3 Carlo Maffei di Boglio Nepomuceno Sassonia2 di Sassonia1 1850 1850 1850 1850 Federico Guglielmo Carlo Giuseppe Pietro Vivaldi Pasqua Angelo Michele Crotti di Prussia4 Beraudo di Pralormo di Costigliole 1853 1853 Carlo Ferrero Roberto Saluzzo di Masserano di Monesiglio 1 poi Giovanni, re di Sassonia. 2 poi Alberto re di Sassonia. 3 poi Federico III, imperatore di Germania e re di Prussia. 4 poi Guglielmo I, re di Prussia e imperatore di Germania. 14 (segue Vittorio Emanuele II) 1855 1855 1855 1855 Giuseppe Sanjust di Leopoldo del Belgio Pietro V Luigi di Portogallo San Lorenzo principe reale del Belgio5 re di Portogallo duca di Oporto6 1855 1855 1856 Napoleone Gerolamo Napoleone Camillo Benso di 7 Giuseppe Carlo Bonaparte Cavour Bonaparte 1857 1857 Michele Costantino granduca di Russia granduca di Russia 1858 1858 1858 Ettore de Gerbaix Cesare Alfieri di Alfonso Ferrero della de Sonnaz Sostegno Marmora 5 Poi Leopoldo II, re dei Belgi. 6 Poi Luigi I, re di Portogallo. 7 Già re di Westfalia. 15 (segue Vittorio Emanuele II) 1859 1859 1859 1859 Umberto di Savoia Napoleone Giuseppe Nicola Alberto Edoardo principe di Piemonte8 Bonaparte granduca ereditario di principe di Gran principe imperiale di Russia Bretagna e Irlanda9 Francia 1859 1859 1859 1859 Giovanni Battista Enrico Morozzo della Alessandro Colonna Achille Baraguay Vaillant Rocca Waleski d'Hilliers 1859 1859 1859 1859 Francesco Certain Augusto Michele Edmondo Maurizio di Adolfo Niel Canrobert Regnault Mac Mahon10 di Saint-Jean d'Angély 1859 1859 Alessandro Giacomo Luigi Gortshakoff Randon 8 Poi Umberto I, re d’Italia. -
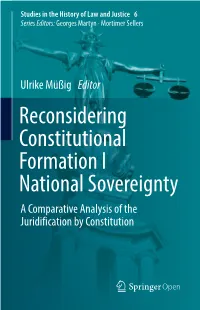
Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty a Comparative Analysis of the Juridification by Constitution Studies in the History of Law and Justice
Studies in the History of Law and Justice 6 Series Editors: Georges Martyn · Mortimer Sellers Ulrike Müßig Editor Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty A Comparative Analysis of the Juridification by Constitution Studies in the History of Law and Justice Volume 6 Series editors Georges Martyn University of Ghent , Gent , Belgium Mortimer Sellers University of Baltimore , Baltimore , Maryland, USA Editorial Board António Pedro Barbas Homem, Universidade de Lisboa Emanuele Conte, Università degli Studi Roma Tre Gigliola di Renzo Villata, Università degli Studi di Milano Markus Dirk Dubber, University of Toronto William Ewald, University of Pennsylvania Law School Igor Filippov, Moscow State University Amalia Kessler, Stanford University Mia Korpiola, Helsinki Collegium for Advanced Studies Aniceto Masferrer, Universidad de Valencia Yasutomo Morigiwa, Nagoya University Graduate School of Law Ulrike Muessig, Universität Passau Sylvain Soleil, Université de Rennes James Q.Whitman, Yale Law School The purpose of this book series is to publish high quality volumes on the history of law and justice. Legal history can be a deeply provocative and infl uential fi eld, as illustrated by the growth of the European universities and the ius commune, the French Revolution, the American Revolution, and indeed all the great movements for national liberation through law. The study of history gives scholars and reformers the models and cour- age to question entrenched injustices, by demonstrating the contingency of law and other social arrangements. Yet legal history today fi nds itself diminished in the universities and legal academy. Too often scholarship betrays no knowledge of what went before, or why legal institutions took the shape they did. -

I Cattolici Democratici Nella Storia Politica Italiana – Di Francesco Malgeri
Civitas Rivista quadrimestrale di ricerca Registrazione storica e cultura politica Tribunale Civile di Roma • Fondata e diretta da Filippo Meda n. 152 dell’8.04.2004 (1919-1925) • Diretta da Guido Gonella (1947) Civitas è una pubblicazione • Diretta da Paolo Emilio Taviani dell’Istituto Luigi Sturzo (1950-1995) Quarta serie Presidente • Diretta da Gabriele De Rosa Roberto Mazzotta (2004-2007) • Diretta da Franco Nobili (2007-2008) «Civitas» “riprenderà il difficile impegno con la serietà Direttore Responsabile ed il rigore che l’hanno contraddistinta nei momenti Agostino Giovagnoli più travagliati e complessi. Coordinatore Editoriale I temi riguarderanno problemi, eventi, prospettive Amos Ciabattoni della politica internazionale con un particolare riguardo alla vita italiana ed all’unità europea. Comitato Redazione ... Il XX secolo ha lasciato tracce e impronte in Italia, Andrea Bixio in Europa e nel mondo, che sono in gran parte da scoprire e, Walter E. Crivellin per un certo verso, se non addirittura, da correggere, Mario Giro da meglio interpretare. Flavia Nardelli Sarà anche questo un importante compito della nuova «Civi- Ernesto Preziosi tas»”. [Paolo Emilio Taviani, 18 febbraio 2000] Giuseppe Sangiorgi Segreteria Redazione Costo di un numero 10,00 € Rita Proietti, Serena Torri Abbonamento a tre numeri €25,00 Abbonamento sostenitore €250,00 Sede (Equivalente a 10 abbonamenti) Via delle Coppelle, 35 00186 Roma C/c postale Tel. 06.68809223-6840421 15062888 intestato a Rubbettino Editore, Viale Rosario Fax 06.45471753 Rubbettino, 10 - 88049 Soveria Mannelli (Catanzaro) [email protected] www.rivistacivitas.it Bonifico bancario Banca Popolare di Crotone - Agenzia di Serrastretta Editore C/C 120418 ABI 05256 CAB 42750 Rubbettino Carte di credito Viale R. -

17 Marzo 2011 1861 - 2011 Le Celebrazioni Dell’Unità D’Italia
1861 - 2011 Le ceLebrazioni deLL’Unità d’itaLia 17 marzo 2011 1861 - 2011 Le ceLebrazioni deLL’Unità d’itaLia 17 marzo 2011 In copertina: Giulio Aristide sArtorio (elaborazione grafica su particolare del fregio dell’Aula di Montecitorio). Copyright © Camera dei deputati Segreteria generale - Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico Roma, 2011 La presente raccolta di testi e documenti è stata predisposta in occasione della cerimonia solenne del 17 marzo 2011 nell’Aula di Palazzo Montecitorio, dedicata al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La prima sezione illustra l’inaugurazione dell’VIII legislatura del Regno (la prima del Parlamento italiano) con il discorso della Corona e gli indirizzi di risposta delle due Camere. Segue la discussione parlamentare della legge 17 marzo 1861, n. 4671, che proclamava il Regno d’Italia, conferendo a Vittorio Emanuele II e ai suoi successori il titolo di Re d’Italia. Le successive due sezioni hanno per oggetto, rispettivamente, le celebrazioni del 1911 e 1961. Nell’ultima sezione è riportata la conferenza svolta dal Presidente della Repubblica presso l’Accademia Nazionale dei Lincei il 12 febbraio 2010, in vista delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Indice 1861 AperturA dellA sessione pArlAmentAre del 1861 Discorso della Corona (18 febbraio 1861) . 3 Indirizzo di risposta del Senato del Regno al discorso della Corona (Seduta del 26 febbraio 1861) . 9 Indirizzo di risposta della Camera dei deputati al discorso della Corona (Seduta del 13 marzo 1861) . 15 discussione sul progetto di legge «per cui s. m. il re Vittorio emAnuele ii Assume il titolo di re d’itAliA» Senato del Regno (Seduta del 26 febbraio 1861) . -

(Torino Turistica
Torino Turistica - Servizio Telematico Pubblico - Città di Torino http://www.comune.torino.it/canaleturismo/en/history.htm Città di Torino Torino Turistica The city's history The Emperor Augustus had Turin built two thousand years ago as a camp for the troops he sent to protect the Roman state's northern borders. A classic Roman "castrum" with square layout, it remained almost unchanged, complete with its ancient walls, for centuries, both during the domination of the lombards and later the Franks, as well as during the early middle ages when complex institutional dynamics lead to a short period of domination by the Church followed by a period of fragile municipal autonomy prior to the rise and consolidation of control over the city by the Acaja. It was not until the fifteenth century, when the Savoy dukedom achieved the political and administrative unification of Piedmont's various provinces that Turin, chosen as the Dukedom's official residence, began to consolidate its importance. Involved in the Franco-Austrian war in the first half of the sixteenth century, the city strengthened its defensive system by constructing a series of angular bastions, a project that continued throughout the long period of occupation by the French (1536-1557). It was Duke Emanuele Filiberto who won back his lands, defeating the French at the Battle of San Quintino. In the subsequent peace treaty of Cateau-Cambrésis in 1559 Turin was chosen as the new capital of the Savoy state. While it was Savoy government policy to relaunch Turin's economic, manufacturing and cultural life and to create a city to match the great capitals of Europe, the Dukedom's greatest expenditure was on defence and on the strategic reorganisation of the Savoy state. -

Catalogo Delle Pubblicazioni
Studi Piemontesi rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità edita dal Centro Studi Piemontesi La rivista, a carattere interdisciplinare, è dedicata allo studio della cultura e della civiltà subalpina, intesa entro coordinate e tangenti internazionali. Pubblica, di norma, saggi e studi originali, risultati di ricerche e documenti riflettenti vita e civiltà del Piemonte, rubriche e notizie delle iniziative, attività, problemi, pub- blicazioni comunque interessanti la regione nelle sue varie epoche e manifesta- zioni. Comitato redazionale: Renata Allìo, Alberto Basso, Piero Cazzola, Anna Cornagliotti, Angelo Dragone, Giuliano Gasca Queirazza S.J., Andreina Griseri, Francesco Malaguzzi, Isabella Massabò Ricci, Riccardo Massano, Aldo A. Mola, Narciso Nada, Francesco Panero, Carlo Pischedda, Gian Savino Pene Vidari, Gualtiero Rizzi, Rosanna Roccia, Luciano Tamburini, Giovanni Tesio. Direttore: Luciano Tamburini. Segretario di redazione: Albina Malerba. Consulente grafico: Giovanni Brunazzi. Direttore Responsabile: Angelo Dragone. Abbonamento Italia 2002: € 60; estero € 78. marzo 1972 Studi Piemontesi, vol. I, fasc. 1 (esaurito) Saggi e studi Riccardo Massano 3 Silvio Pellico compilatore responsabile del «Conciliatore» Luigi Ronga 26 Invito alla musica piemontese Marie-Thérèse Bouquet 40 Un maitre de chapelle à la Cour de Turin: Andrea Stefano Fiorè (1686-1732) Vera Comoli Mandracci 57 Studi di storia dell’urbanistica in Piemonte: Asti Note Antonio Illiano 74 Da scelus a innocenza: osservazioni sulla genesi e problematicità della Mirra di Alfieri Corrado Grassi 81 I punti piemontesi e valdostani negli atlanti linguistici nazionali Giuseppe Bracco 86 La statistica delle arti e manifatture del 1822 negli stati di terraferma del Regno Sardo Maria Delfina Fusina 94 La diffusione della iconografia della Sindone in Piemonte Giorgio Avigdor 97 La Sinagoga di Casale Rosalba Tardito 104 Torino: Palazzo Reale, l’appartamento di Madama Felicita; Moncalieri: gli appartamenti reali del Castello Enzo Bottasso 109 Nascita di un grande editore: G. -

FEDERIGO SCLOPIS, DA TORINO ALL'europa Gian Savino Pene
FEDERIGO SCLOPIS, DA TORINO ALL’EUROPA Gian Savino Pene Vidari Università di Torino [email protected] Sommario: 1. Inquadramento. – 2. Gli anni giovanili. – 3. La collabora- zione in prospettiva europea alle iniziative carloalbertine. – 4. L’inizio dei viaggi europei. – 5. Ricostruzione della storia istituzionale italiana. – 6. Cenni su un quindicennio particolarmente politico. – 7. La vita culturale da Torino all’Europa. 1. Inquadramento Su Federico1 Sclopis sono state scritte di recente due voci enciclopediche di una certa consistenza, che ne mettono in rilievo l’importante e multiforme personalità, anche in prospettiva europea2. È stato inoltre edito da poco un pregevole articolo che sottolinea il suo ruolo di presidente, fondamentale per la felice conclusione dell’arbitrato internazionale svoltosi a Ginevra fra l’Inghilterra e gli Stati Uniti sulla “questione dell’Alabama” e delle altre navi- pirata in danno dei Nordisti nella guerra di secessione americana3. Mi sem- bra perciò che, con queste basi, si possa tornare rapidamente sulla figura di Federico Sclopis, tenacemente attaccato alla sua terra natìa ma nello stesso tempo anelante ad un respiro europeo della sua vita culturale e sociale, più che politica. Nonostante le alte funzioni pubbliche raggiunte prima nel Re- gno di Sardegna e poi in quello d’Italia, egli è stato infatti un intellettuale attento alla cultura ed alla scienza dell’Europa del proprio tempo, per quanto sempre radicato nella sua Torino. Può avere un significato cercare di farlo notare in questo momento, in cui la prospettiva europea sta ripiegando 1 “Federigo” era la denominazione preferita dall’interessato, che però era usualmente detto “Federico”. 2 Moscati, 2012, pp. -

10 Lyttelton 1034 18/11/02 9:57 Am Page 325
10 Lyttelton 1034 18/11/02 9:57 am Page 325 ITALIAN LECTURE The Origins of a National Monarchy: Tradition and Innovation in the Cult of the House of Savoy During the Risorgimento ADRIAN LYTTELTON Johns Hopkins University, Bologna Center D 1848–78 (which except for the first year coincides with the reign of Victor Emanuel II, the ‘re galantuomo’) the Savoy monarchy was transformed from a purely dynastic institution into a sym- bol of national unity. The reactions to Victor Emanuel’s death and his later funeral in the Pantheon show beyond any doubt that the image of the King as ‘father of the nation’ was widely accepted, and that his pop- ularity extended beyond the circle of the notables and the bourgeoisie who were the promoters of the cult of the monarchy to significant sectors of the urban working classes. That the ‘myth’ of the monarchy’s role during the critical phase of the Risorgimento did not correspond to the complex realities of the period is by now a commonplace. One of the first important blows was struck by the American historian Howard McGaw Smyth in his key article of 1935, ‘The armistice of Novara: a legend of a liberal King’.1 This showed that the accepted idea that in the armistice talks at Vignale in March 1849 Victor Emanuel had courageously resisted the pressure of Marshal Radetzky to make him give up the constitution established by the Statuto Read at the Academy 31 October 2001. 1 H. McGaw Smyth, ‘The Armistice of Novara: a Legend of a Liberal King’, Journal of Mod- ern History, VII (1935), 141–74. -

Retour Sur L'affaire De L'alabama
Boston University School of Law Scholarly Commons at Boston University School of Law Faculty Scholarship 2019 Retour sur L’Affaire de L’Alabama: De l’Utilité et de l’Histoire pour l'Arbitrage International William Park Boston Univeristy School of Law Bruno de Fumichon Follow this and additional works at: https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship Part of the Dispute Resolution and Arbitration Commons, and the International Law Commons Recommended Citation William Park & Bruno de Fumichon, Retour sur L’Affaire de L’Alabama: De l’Utilité et de l’Histoire pour l'Arbitrage International, 2019 Revue de l'Arbitrage 743 (2019). Available at: https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/821 This Article is brought to you for free and open access by Scholarly Commons at Boston University School of Law. It has been accepted for inclusion in Faculty Scholarship by an authorized administrator of Scholarly Commons at Boston University School of Law. For more information, please contact [email protected]. RETOUR SUR L’AFFAIRE DE L’ALABAMA : DE L’UTILITÉ DE L’HISTOIRE POUR L’ARBITRAGE INTERNATIONAL (1) par Bruno de LOYNES de FUMICHON Maître de conférences honoraire de l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I) et Doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université de la Polynésie Française (Tahiti) et William W. PARK Professeur à Boston University, Ancien Président de la London Court of International Arbitration et General Editor de Arbitration International RÉSUMÉ Pour les passionnés de l’arbitrage international et, plus largement, de droit international, l’affaire de l’Alabama, de 1872, est une mine presque inépuisable.