Cavour 02 Layout 1 17/11/2011 00:56 Pagina I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Esercitati GRATIS On-Line! N
N. Domanda A B C D 885 DA CHI ERA COMPOSTO IL SERRISTORI, RICASOLI, PERUZZI, GUERRAZZI, LAMBRUSCHINI, GOVERNO PROVVISORIO RIDOLFI, CAPPONI PUCCIONI MONTANELLI, GIORGINI, MORDINI TOSCANO PROCLAMATO L'8 MAZZONI FEBBRAIO 1849 IN SEGUITO ALLA FUGA DA FIRENZE DI LEOPOLDO II? 886 NEL MARZO 1849, DURANTE LA A NOVARA A MONCALIERI A MAGENTA A CUSTOZA SECONDA FASE DELLA PRIMA GUERRA DI INDIPENDENZA, IN QUALE LOCALITA' LE TRUPPE DEL REGNO DI SARDEGNA FURONO SCONFITTE DALLE TRUPPE AUSTRIACHE? 887 IN QUALE LOCALITA' VITTORIO A VIGNALE A VILLAFRANCA A CUSTOZA A NOVARA EMANUELE II ACCETTO' LE CONDIZIONI ARMISTIZIALI DEL FELDMARESCIALLO RADETZKY? 888 QUALE TRA I SEGUENTI FRANCESCO CARLO PISACANE SILVIO PELLICO DANIELE MANIN PERSONAGGI PRESE PARTE ALLA DOMENICO DIFESA DI ROMA NEL 1849? GUERRAZZI 889 IN SEGUITO ALLA RESA DELLA PORTARE AIUTO PORTARE AIUTO AL ATTACCARE I ASSEDIARE PIO IX REPUBBLICA ROMANA, CON ALLA DIFESA DI GOVERNO FRANCESI A A GAETA QUALE OBIETTIVO GARIBALDI, VENEZIA PROVVISORIO CIVITAVECCHIA INSIEME A 4000 UOMINI, LASCIO' TOSCANO ROMA? 890 CHI E' L'AUTORE DELL'OPUSCOLO GIUSEPPE GIUSEPPE GIUSTI GIUSEPPE FERRARI GIUSEPPE MAZZINI "LA FEDERAZIONE MONTANELLI REPUBBLICANA", PUBBLICATO A CAPOLAGO NEL 1851? 891 QUALI POTENZE INTERRUPPERO SPAGNA E PRUSSIA E RUSSIA E IMPERO FRANCIA E LE RELAZIONI DIPLOMATICHE CON PORTOGALLO AUSTRIA OTTOMANO INGHILTERRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE NEL 1856? 892 QUALE DIPLOMATICO SABAUDO EMILIO VISCONTI LUIIG AMEDEO COSTANTINO LUIGI PRINETTI COLLABORO' IN MODO DECISIVO VENOSTA MELEGARI NIGRA CON CAVOUR NELLE TRATTATIVE -

Delpaese E Le Forze Armate
L’ITALIA 1945-1955 LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE STATO MAGGIORE DELLA DIFESA UFFICIO STORICO E LE Commissione E LE FORZE ARMATE Italiana Storia Militare MINISTERO DELLA DIFESA CONGRESSOCONGRESSO DIDI STUDISTUDI STORICISTORICI INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI CISM - Sapienza Università di Roma ROMA, 20-21 NOVEMBRE 2012 Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) Palazzo Salviati ATTI DEL CONGRESSO PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione © 2014 • Ministero della Difesa Ufficio Storico dello SMD Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma [email protected] A cura di: Dott. Piero Crociani Dott.ssa Ada Fichera Dott. Paolo Formiconi Hanno contribuito alla realizzazione del Congresso di studi storici internazionali CISM Ten. Col. Cosimo SCHINAIA Capo Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD Ten. Col. Fabrizio RIZZI Capo Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD CF. Fabio SERRA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD 1° Mar. Giuseppe TRINCHESE Capo Segreteria dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Francesco D’AURIA Addetto alla Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Giovanni BOMBA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD ISBN: 978-88-98185-09-2 3 Presentazione Col. Matteo PAESANO1 Italia 1945-1955 la ricostruzione del Paese el 1945 il Paese è un cumulo di macerie con una bassissima produzione industriale -

Enjoy Your Visit!!!
declared war on Austria, in alliance with the Papal States and the Kingdom of the Two Sicilies, and attacked the weakened Austria in her Italian possessions. embarked to Sicily to conquer the Kingdom of the Two Sicilies, ruled by the But Piedmontese Army was defeated by Radetzky; Charles Albert abdicated Bourbons. Garibaldi gathered 1.089 volunteers: they were poorly armed in favor of his son Victor Emmanuel, who signed the peace treaty on 6th with dated muskets and were dressed in a minimalist uniform consisting of August 1849. Austria reoccupied Northern Italy. Sardinia wasn’t able to beat red shirts and grey trousers. On 5th May they seized two steamships, which Austria alone, so it had to look for an alliance with European powers. they renamed Il Piemonte and Il Lombardo, at Quarto, near Genoa. On 11th May they landed at Marsala, on the westernmost point of Sicily; on 15th they Room 8 defeated Neapolitan troops at Calatafimi, than they conquered Palermo on PALAZZO MORIGGIA the 29th , after three days of violent clashes. Following the victory at Milazzo (29th May) they were able to control all the island. The last battle took MUSEO DEL RISORGIMENTO THE DECADE OF PREPARATION 1849-1859 place on 1st October at Volturno, where twenty-one thousand Garibaldini The Decade of Preparation 1849-1859 (Decennio defeated thirty thousand Bourbons soldiers. The feat was a success: Naples di Preparazione) took place during the last years of and Sicily were annexed to the Kingdom of Sardinia by a plebiscite. MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY LABORATORY Risorgimento, ended in 1861 with the proclamation CIVIC HISTORICAL COLLECTION of the Kingdom of Italy, guided by Vittorio Emanuele Room 13-14 II. -

Antonio Rosmini on Property It Showed Itself As a Part of God’S Calling
Journal of Markets & Morality Volume 7, Number 1 (Spring 2004): 63–97 Copyright © 2004 A Sphere Around Alberto Mingardi Policy Director the Person: Istituto Bruno Leoni (Turin, Italy) Antonio Rosmini and Visiting Fellow Centre for the New Europe on Property* (Brussels, Belgium) Father Antonio Rosmini-Serbati (1797–1855) is an author of growing interest and curiosity to his fellow churchmen, as well as to secular intellectuals, as a philosopher who successfully reconciled reason and faith. Nevertheless, the political nuances of his thought have barely been explored by English-speaking scholars, and even among his Italian followers these have not been fully appre- ciated. This article attempts to present an overview of Rosmini’s political philoso- phy, focusing on his concern for the protection of private property rights and arguing that it is precisely his advocacy of private property that determines his attitude toward the general organization of associated life, government, and democracy. The organization of this investigation consists of four parts. The first pro- vides a brief biographical sketch of Antonio Rosmini. The second tentatively enlists the main influences in the development of Rosmini’s thought as far as politics and economics are concerned. The third is devoted to examining his approach toward property. The fourth examines his definition of social justice in the light of his justification of property. Introduction In this article, I introduce the reader to the figure of Antonio Rosmini, provide a biographical sketch, and subsequently approach his thought on private prop- erty. As a priest and a devout Catholic, religious faith was central to every aspect of Rosmini’s philosophy. -

Kazdan Pak Dissertation
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Italy's Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 Permalink https://escholarship.org/uc/item/7fh45860 Author Pak, Julie Kazdan Publication Date 2012 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Italy’s Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Julie Kazdan Pak 2012 © Copyright by Julie Kazdan Pak 2012 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Italy’s Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 by Julie Kazdan Pak Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2012 Professor Geoffrey Symcox, Chair This dissertation concerns the feminization of the Italian teaching profession between the introduction of pre-Unification schooling in 1859 and the nationalization of that system in 1911. By feminization, this dissertation refers both to the gradual assumption of the majority of elementary teaching positions by women and to a transformation in the nature of the position itself. Through an examination of educational periodicals, school records, government inquests, and accounts by teachers and pedagogical theorists, it argues that rather than the unintended consequence of economic constraints or shifting labor patterns, feminization was fundamentally connected to larger processes of centralization and modernization in the Italian school system. Following an introductory chapter outlining the major national, religious, and gender debates of ii the Unification era, the second chapter of the dissertation argues that the figure of the female elementary teacher became embroiled in the contest between local and national interests, furthering the drive toward centralization. -

Memorie Della Accademia Delle Scienze Di Torino
1 Memorie della Accademia delle Scienze di Torino Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche Serie V, Volume 38, fasc. 3 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO 2014 Memorie Morali_32mi - seg 1 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO Via Accademia delle Scienze, 6 10123 Torino, Italia Uffici: Via Maria Vittoria, 3 10123 Torino, Italia Tel. +39-011-562.00.47; Fax +39-011-53.26.19 Tutti i saggi che appaiono nelle «Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino» sono valutati da referees anonimi attraverso un sistema di peer review. L’Accademia vende direttamente le proprie pubblicazioni. Per acquistare fascicoli scrivere a: [email protected] Per contattare la Redazione rivolgersi a: [email protected] I lettori che desiderino informarsi sulle pubblicazioni e sull’insieme delle attività dell’Accademia delle Scienze possono consultare il sito www.accademiadellescienze.it In copertina: Busto di Pietro Luigi Albini nel Loggiato del Rettorato, Università degli Studi, Torino. ISSN: 1120-1622 ISBN: 978-88-99471-01-9 Busto di Pietro Luigi Albini nel Palazzo Civico di Vigevano. Ringraziamenti Un vivo ringraziamento va anzitutto all’Accademia delle Scienze di Torino, all’Ar- chivio della Universitätsbibliothek di Heidelberg e alla Biblioteca Norberto Bobbio, Sezione Patetta – Antichi e Rari, Università degli Studi, Torino, che hanno autorizzato la pubblicazione delle lettere di Albini, di Sclopis e di Mittermaier conservate nei loro archivi. Inoltre, nell’impossibilità di ringraziare individualmente le persone che -
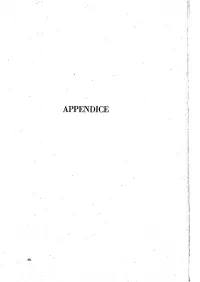
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

1 “Le Riforme Nella Scuola Italiana Dal 1859 Al 2003”
“Le riforme nella scuola italiana dal 1859 al 2003” SCHEDE a cura di Elena Bertonelli e Giaime Rodano con la consulenza di Giorgio Chiosso e Giuseppe Tognon settembre 2003 1 Indice n “Le riforme nella scuola italiana dal 1859 al 2003” n Questo corso n 1. La scuola nella prima fase dello Stato unitario n 1.1 La legge Casati n 1.2 La legge Coppino n 1.3 L’età giolittiana n 2. La scuola fra le due guerre n 2.1 La riforma Gentile n 2.2 I “ritocchi” e la fascistizzazione della scuola n 2.3. La “Carta della scuola” n 3. La scuola della Costituzione n 3.1 La scuola alla Costituente n 3.2. La scuola negli anni ’50 n 3.3 La Scuola media unica n 3.4. I Decreti Delegati e le sperimentazioni n 4. La scuola verso una riforma di sistema n 4.1 Il “mosaico” della XIII legislatura n 4.2. Le novità della XIV legislatura 2 Questo corso mira a ricostruire nei suoi tratti essenziali i mutamenti più significativi che hanno contraddistinto - lungo un arco di quasi 150 anni - il modo di essere. di vivere e di operare della scuola italiana. Saranno considerati sia gli interventi di carattere ordinamentale che - a partire dalla riforma Casati sino a quelle dei nostri giorni - hanno modificato l’architettura complessiva del nostro sistema di istruzione e di formazione, sia quelle innovazioni di segno metodologico e organizzativo - ad esempio i Decreti Delegati e il Regolamento dell’autonomia - che hanno di volta in volta contribuito a mutare il rapporto della scuola con la società civile. -

Archivi Di Stato in Milano : Prefetti O Direttori, 1468-1874. Note Sull
MM 01 STATO IN MILANO PREFETTI DIRETTORI (1468-1874) IOTE SULL'ORIGINE, FORMAZIONE E CONCENTRAMENTO DI QUESTI ED ALTRI SIMILI ISTITUTI DAMIANO MUONI Presidente della milanese Accademia Fisio-Medico-Statistica Membro effettivo promotore della Società Storica Lombarda Socio degli Atenei di Bergamo e Venezia della Regia Accademia di Belle Arti in Milano e di quella di Raffaello in Urbino Corrispondente della Consulta Araldica a Roma delle Regie Deputazioni di Storia Patria a Torino, Bologna e Firenze delle Società analoghe di Asti, Genova, Palermo, Parigi, Grenoble, Filadelfia Segretario di I Classe ai suddetti Archivi ecc., ecc., ecc. MILANO TIPOGRAFIA C. MOLINARI E C. Galleria Vittorio Emanuele, 77. 1874 A SPESE DELL'AUTORE Ristretto numero di esemplari. Vendesi presso i Librai Galli o Omodol - Milano, Galleria Viti. Km., il. AI LETTORI II tenue saggio che offriamo al pubblico non è che un epilogo delle molte note ritratte nel decennale nostro soggiorno in questi Archivi. A fronte delle belle ed assennate relazioni uscite finora da congeneri Istituti in Italia e altrove, non potemmo che esitare a mettere fuori la nostra; tuttavia, riflettendo come nella maggior parte le prime sieno state Vopera collettiva di parecchi com= petentissimi ingegni, non dubitiamo che i veri giudici della materia vorranno esserci indulgenti se da soli e male agguerriti osammo avventurarci noi pure in una selva si intricata e oscura. Come che sia, ne conforti V avere inoltrato un passo, additato un sentiero. Milano, 22 marzo 1874. Come di presente, anche in addietro, ogni magistratura, ogni comparto della pubblica amministrazione annoverava uno speciale archivio. Il Magistrato Ordinario , il Magi- strato Straordinario,, la Cancelleria Bucaley la Cancelle- ria Secreta, il Senato, in cui il re di Francia Luigi XII ebbe, colPeditto 11 novembre 1499, a concentrare in Mi- lano i precedenti Consigli de' nostri duchi, possedevano il proprio. -

The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860
The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl VERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR NEUERE GESCHICHTE ÖSTERREICHS Band 115 Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Vorsitzende: em. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauber Mitglieder: Dr. Franz Adlgasser Univ.-Prof. Dr. Peter Becker Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Bruckmüller Univ.-Prof. Dr. Laurence Cole Univ.-Prof. Dr. Margret Friedrich Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Garms-Cornides Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Gottsmann Univ.-Prof. Dr. Margarete Grandner em. Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas Univ.-Prof. i. R. Dr. Wolfgang Häusler Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Hanisch Univ.-Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz Dr. Michael Hochedlinger Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt Mag. Thomas Just Univ.-Prof. i. R. Dr. Grete Klingenstein em. Univ.-Prof. Dr. Alfred Kohler Univ.-Prof. Dr. Christopher Laferl Gen. Dir. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner Dr. Stefan Malfèr Gen. Dir. i. R. H.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky Dr. Gernot Obersteiner Dr. Hans Petschar em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Scheutz em. Univ.-Prof. Dr. Gerald Stourzh Univ.-Prof. Dr. Arno Strohmeyer Univ.-Prof. i. R. Dr. Arnold Suppan Univ.-Doz. Dr. Werner Telesko Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer Sekretär: Dr. Christof Aichner The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl Published with the support from the Austrian Science Fund (FWF): PUB 397-G28 Open access: Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License. -

Parte Ii Da Vittorio Emanuele Ii a Umberto I
FEDERICO BONA STEMMI DEI CAVALIERI DELL’ANNUNZIATA DA CARLO EMANUELE IV A UMBERTO II **** PARTE II DA VITTORIO EMANUELE II A UMBERTO I (1849 – 1900) LUGLIO 2012 Vittorio Emanuele II XXIV Gran Maestro dell’Ordine 1849 1849 1849 Napoleone III Francesco d’Assisi Ferdinando II imperatore dei Francesi re di Spagna re del Portogallo 1850 1850 1850 1850 Giovanni Federico Augusto di Federico di Prussia3 Carlo Maffei di Boglio Nepomuceno Sassonia2 di Sassonia1 1850 1850 1850 1850 Federico Guglielmo Carlo Giuseppe Pietro Vivaldi Pasqua Angelo Michele Crotti di Prussia4 Beraudo di Pralormo di Costigliole 1853 1853 Carlo Ferrero Roberto Saluzzo di Masserano di Monesiglio 1 poi Giovanni, re di Sassonia. 2 poi Alberto re di Sassonia. 3 poi Federico III, imperatore di Germania e re di Prussia. 4 poi Guglielmo I, re di Prussia e imperatore di Germania. 14 (segue Vittorio Emanuele II) 1855 1855 1855 1855 Giuseppe Sanjust di Leopoldo del Belgio Pietro V Luigi di Portogallo San Lorenzo principe reale del Belgio5 re di Portogallo duca di Oporto6 1855 1855 1856 Napoleone Gerolamo Napoleone Camillo Benso di 7 Giuseppe Carlo Bonaparte Cavour Bonaparte 1857 1857 Michele Costantino granduca di Russia granduca di Russia 1858 1858 1858 Ettore de Gerbaix Cesare Alfieri di Alfonso Ferrero della de Sonnaz Sostegno Marmora 5 Poi Leopoldo II, re dei Belgi. 6 Poi Luigi I, re di Portogallo. 7 Già re di Westfalia. 15 (segue Vittorio Emanuele II) 1859 1859 1859 1859 Umberto di Savoia Napoleone Giuseppe Nicola Alberto Edoardo principe di Piemonte8 Bonaparte granduca ereditario di principe di Gran principe imperiale di Russia Bretagna e Irlanda9 Francia 1859 1859 1859 1859 Giovanni Battista Enrico Morozzo della Alessandro Colonna Achille Baraguay Vaillant Rocca Waleski d'Hilliers 1859 1859 1859 1859 Francesco Certain Augusto Michele Edmondo Maurizio di Adolfo Niel Canrobert Regnault Mac Mahon10 di Saint-Jean d'Angély 1859 1859 Alessandro Giacomo Luigi Gortshakoff Randon 8 Poi Umberto I, re d’Italia. -

STORIA Ai Sensi Delle Vigenti Leggi Italiane Sul Copyright, Non È Consentito L'uso Del Presente Materiale Testologico a Scopo Di Lucro
STORIA Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ID Domanda A B C D Esatta 1 Cosa fece di Mussolini il Re Vittorio Emanuele III dopo Lo invitò a presentarsi Lo costrinse ad Lo invitò a elaborare Lo fece prendere in D il colloquio successivo alla seduta del Gran Consiglio alla Camera dei Fasci andare in esilio in una strategia di consegna dai del Fascismo del 25 luglio 1943? e delle Corporazioni Germania rilancio dell'iniziativa Carabinieri e lo spedì per un dibattito sulla bellica confinato sul Gran crisi di Governo. Sasso 2 Chi giustiziò Mussolini il 28 aprile 1945 a Giulino di I partigiani Gli americani Gli inglesi I fascisti A Mezzegra? 3 Tra il 1952 e il 1962 l'Italia ha attraversato un periodo trend positivo exploit economico boom economico incremento C di forte sviluppo detto: economico 4 In quale anno nacque l'O.N.U.? 1940 1945 1939 1960 B 5 Quale di queste battaglie non venne combattuta La battaglia del Piave La battaglia del La battaglia di El La battaglia di C durante la Prima guerra mondiale? monte Ortigara Alamein Caporetto 6 Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio Matteotti Badoglio Saragat Ciano C durante il ventennio fascista? 7 In che data venne dichiarata guerra all'Austria - 24-mag-15 31-dic-14 10-giu-15 15-mag-15 A Ungheria (1° guerra mondiale) da Parte dell’Italia? 8 Con quale legge Cavour riformò la contabilità e L.