La Pellegrina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
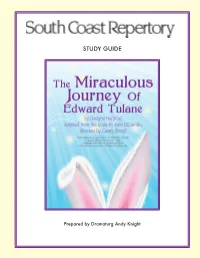
Check out the Show's Study Guide
STUDY GUIDE Prepared by Dramaturg Andy Knight The Miraculous Journey of Edward Tulane • SOUTH COAST REPERTORY •1 TABLE OF CONTENTS PART I: THE PLAY 3. The.Characters 3. The.Story 4. Going.by.the.Book:.An.Excerpt.from. ......The Miraculous Journey of Edward Tulane 5. Awards.for Edward Tulane. 5. Meet.the.Playwright:.Dwayne.Hartford. 5. Meet.the.Author:.Kate.DiCamillo. 6. An.Interview.with.Author.Kate.DiCamillo. 7. From.Page.to.Stage:.Bringing Edward Tulane.to.Life PART II: CLASSROOM ACTIVITIES Before the Show 8. Questions.for.Discussion.and.Activities.. 8. American.History.in.Edward Tulane 9. Words,.Words,.Words! After the Show 10. Discussion.About.the.Theatre 10. Discussion.About.the.Play 11. Activities. PART III: AT THE THEATRE 12. .Welcome.to.the.Julianne.Argyros.Stage 12. .Theatre.Etiquette 12. .Student.Tips.for.Theatre.Trips 12. .Programs PART IV: EDUCATION STATION 13. California.Visual.and.Performing.Arts.Framework 14. Five.Strands.of.Art.Education 15. Basic.Theatre.Vocabulary PART V: RESOURCES 16. More.Information.on. The Miraculous Journey of Edward Tulane. 16. More.About.Author.Kate.DiCamillo. 16. More.About.the.1930s 2 • SOUTH COAST REPERTORY • The Miraculous Journey of Edward Tulane Part I: The Play THE CHARACTERS • The Traveler, the storyteller who portrays: Pellegrina, the Society Lady, Martin, Lolly, Jack, the Watchman, the Old Lady, Marlene and Lucius Clarke • The Woman, the storyteller who portrays: Abilene, Nellie, Lucy the Dog, Sarah Ruth, Neal, the Doll, the Old Doll and the Shopper • The Musician, the storyteller who portrays the voice of Edward’s thoughts and emotions • The Man, the storyteller who portrays: Abilene’s Father, Amos, Lawrence, Bull and Bryce THE STORY he Miraculous Journey of Edward Tulane hobo named Bull, calls the china rabbit Malone, and begins in a house on Egypt Street in the for seven happy years the threesome travels the open mid-1920s. -

I Had to Fight with the Painters, Master Carpenters
‘I had to fight with the painters, master carpenters, actors, musicians and the dancers’: Rehearsals, performance problems and audience reaction in Renaissance spectacles Jennifer Nevile Early Dance Circle Annual Lecture, 21 February 2021 In 1513 Castiglione wrote about the difficulties he was having during the rehearsals for a production at Urbino. [the intermedio] about the battles was unfortunately true - to our disgrace. … [The intermedi] were made very much in a hurry, and I had to fight with the painters, the master carpenters, the actors, musicians and the dancers.1 Unfortunately, we do not know exactly what caused the arguments between Castiglione and all the personnel involved in this production, and neither do we know how these difficulties were resolved. But Castiglione’s letter reminds us that then, as now, not everything went as smoothly as those in charge would have hoped for. In spite of the many glowing reports as to the success of theatrical spectacles in early modern Europe, the wonder and amazement of the audience, the brilliance of the glittering costumes, the quantity of jewels and precious stones worn by the performers and the virtuosity of the dancing, problems were encountered during production and the performance. It is this aspect of Renaissance spectacles that is the focus of today’s lecture. I will begin with a discussion of the desire for a successful outcome, and what efforts went into achieving this aim, before moving to an examination of what disasters did occur, from audience over-crowding and noise, stage-fright of the performers, properties being too big to fit through the door into the hall in which the performance was taking place, to more serious catastrophes such as a fire during a performance. -

FY 2021-22 General Government Budget Narrratives
G:\ANNUAL BUDGET WORKFILES\22 Budget Folders\22 Narratives Submitted\..Combined Narratives (3-1 TM Submission) GENERAL FUND REVENUES FY2021/22 2020 2021 2022 Actual Adopted Amended Department Manager Account Description Revenue Budget Budget Requested Approved 41 - Taxes: 001.00.0000.5.41002.00000 Current Levy 77,238,290 78,789,139 78,789,139 83,453,870 83,612,102 001.00.0000.5.41010.00000 Supplemental Motor Vehicles 812,725 700,000 700,000 700,000 700,000 Various Back Taxes/Interest/Suspense Taxes 1,174,595 692,000 692,000 735,000 735,000 001.00.0000.6.41601.00000 Elderly Housing 51,814 51,813 51,813 52,945 52,945 Total Taxes 79,277,425 80,232,952 80,232,952 84,941,815 85,100,047 42 - Licenses, Permits, & Other: 001.05.0511.1.42151.00000 Town Clerk Fees 436,152 330,000 330,000 330,000 330,000 001.05.0511.1.42152.00000 Town Clerk Dog License Fees 9,726 11,000 11,000 11,000 11,000 001.05.0505.1.42153.00000 Passport Fee 10,520 16,000 16,000 12,000 12,000 001.10.1014.1.42201.00000 Building Inspection Fees 446,398 375,000 375,000 475,000 500,000 001.10.1014.1.42202.00000 Planning Fees 22,117 18,000 18,000 18,000 18,000 001.10.1016.1.42251.00000 Zoning Board of Appeals 2,990 3,000 3,000 3,000 3,000 001.15.1530.1.42271.00000 Animal Control Fees 1,637 1,000 1,000 1,000 1,000 001.15.1530.1.42272.00000 Animal Control Rent 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 001.15.1531.1.42304.00000 Outside Fire Services 625 8,000 8,000 8,000 8,000 001.15.1532.1.42301.00000 Police Services 41,558 40,000 40,000 45,000 45,000 001.15.1532.1.42302.00000 Police Services -

July 24, 2016
Church of the Holy Spirit 16 South 6th Street, New Hyde Park, New York 11040 The Seventeenth Sunday in Ordinary Time - July 24th, 2016 PASTORAL STAFF Rev Frank Grieco, Pastor Ext. 116 E-mail: [email protected] Deacon Lachlan Cameron Ext. 112 E-mail: [email protected] Deacon Douglas Ferreiro Ext. 171 E-mail: [email protected] Music Director: Mary Bolan Religious Education Office Ext. 132 E-mail:[email protected] Bulletin E-mail: [email protected] Carolyn Mueller Ext 117 E-mail: [email protected] Parish Social Ministry Mr. Tom Friel, Director Ext. 138 E-mail: [email protected] LITURGICAL CELEBRATIONS Website: www.holyspiritchurch.com Mass Schedule Website Coordinator : May O’Boyle Deegan E-mail: [email protected] Sunday: Saturday Vigil Mass 5:00 PM 8:00 AM, 9:30 AM, 11:00 AM, 12:30 PM Rectory Office Monday Through Saturday: 8:30 AM Phone: 516-354-0359 Holydays: As announced Fax : 516-354-2611 Family Mass: 9:30 AM Mass Rectory Hours: Confessions Mon/Tues/Thurs/Fri: 9:00am - 8:00pm • Saturday: 3:45 PM - 4:45 PM Wednesday: 3:00pm - 8:00pm • Call for an appointment (call the rectory to arrange a mutually convenient time.) Saturday: 9:00am - 5:00pm Baptisms Church Hours: Please contact the rectory to make arrangements for your child’s baptism. Monday Through Friday 7:00am -8:00pm Saturday: 7:00am-6:15pm Sacrament of Matrimony Sunday: 7:00am-2:00pm Arrangements must be made at least six months prior to the ceremony and before arranging the reception. Emergency call (516) 880-2936 PASTOR’S PAGE -2- DEACON LACHLAN Last week, in Rome, Annibale Gammarelli passed away. -

Reading the Surface: the Danish Gothic of B.S. Ingemann, H.C
Reading the Surface: The Danish Gothic of B.S. Ingemann, H.C. Andersen, Karen Blixen and Beyond Kirstine Marie Kastbjerg A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2013 Reading Committee: Marianne Stecher. Chair Jan Sjaavik Marshall Brown Program Authorized to Offer Degree: Scandinavian Studies ©Copyright 2013 Kirstine Marie Kastbjerg Parts of chapter 7 are reprinted by permission of the publishers from “The Aesthetics of Surface: the Danish Gothic 1820-2000,” in Gothic Topographies ed. P.M. Mehtonen and Matti Savolainen (Farnham: Ashgate, 2013), pp. 153–167. Copyright © 2013 University of Washington Abstract Reading the Surface: The Danish Gothic of B.S. Ingemann, H.C. Andersen, Karen Blixen and Beyond Kirstine Marie Kastbjerg Chair of the Supervisory Committee: Professor in Danish Studies Marianne Stecher Department of Scandinavian Studies Despite growing ubiquitous in both the popular and academic mind in recent years, the Gothic has, perhaps not surprisingly, yet to be examined within the notoriously realism-prone literary canon of Denmark. This dissertation fills that void by demonstrating an ongoing negotiation of Gothic conventions in select works by canonical Danish writers such as B.S. Ingemann, Hans Christian Andersen, and Karen Blixen (Isak Dinesen), as well as contemporary writers such as Peter Høeg and Leonora Christina Skov. This examination does not only broaden our understanding of these culturally significant writers and the discourses they write within and against, it also adds to our understanding of the Gothic – an infamously malleable and indefinable literary mode – by redirecting attention to a central feature of the Gothic that has not received much critical attention: the emphasis on excess, spectacle, clichéd conventions, histrionic performances, its hyperbolic rhetorical style, and hyper-visual theatricality. -

Forgotten Reality, Remembered Fiction, Production Values and Court Opera
INFORMATION TO USERS This manuscript has been repockiced frwn the mkdilrn master. UMI films the text directly ftom the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in Merface, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Brdcen or indistinct print, cdored or poor quality illustrations and photographs, print Meedttrmugh, substandard margins, and impmper alignment can adversely affect reprodudion. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e-g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuirlg from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6' x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. Bell & Howell Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, MI 48106-1346 USA 800-521-0600 FORGOTTEN mITY, REMEMBERED FICTION: PRODUCTION VALUES AND COURT OPERA, 1598-1608 Peter Eliot Weiss A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Centre for Study of Drama University of Toronto O Copyright by Peter Eliot Weiss 1999 National Library Biblioth4que nationale 1+1 of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographic Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395. -

Displays of Medici Wealth and Authority: the Acts of the Apostles and Valois Fêtes Tapestry Cycles
University of Central Florida STARS Honors Undergraduate Theses UCF Theses and Dissertations 2019 Displays of Medici Wealth and Authority: The Acts of the Apostles and Valois Fêtes Tapestry Cycles Madison L. Clyburn University of Central Florida Part of the Classical Archaeology and Art History Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/honorstheses University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Open Access is brought to you for free and open access by the UCF Theses and Dissertations at STARS. It has been accepted for inclusion in Honors Undergraduate Theses by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. Recommended Citation Clyburn, Madison L., "Displays of Medici Wealth and Authority: The Acts of the Apostles and Valois Fêtes Tapestry Cycles" (2019). Honors Undergraduate Theses. 523. https://stars.library.ucf.edu/honorstheses/523 DISPLAYS OF MEDICI WEALTH AND AUTHORITY: THE ACTS OF THE APOSTLES AND VALOIS FÊTES TAPESTRY CYCLES by MADISON LAYNE CLYBURN A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Honors in the Major Program in Art History in the College of Arts & Humanities and in the Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, Florida Spring Term, 2019 Thesis Chair: Margaret Ann Zaho, Ph.D. © 2019 Madison Layne Clyburn ii ABSTRACT The objective of my research is to explore Medici extravagance, power, and wealth through the multifaceted artistic form of tapestries vis-à-vis two particular tapestry cycles; the Acts of the Apostles and the Valois Fêtes. The cycles were commissioned by Pope Leo X (1475- 1521), the first Medici pope, and Catherine de’ Medici (1519-1589), queen, queen regent, and queen mother of France. -

St. Ephrem Catholic Church
St. Ephrem Catholic Church July 28, 2019 The Chronicles of Fr. Craig Lord open my lips + and my mouth will proclaim your praise! This weekend, we welcome our Be Our Guest! missionary priest, Last week I shared a memory of a dinner party hosted by a person who grew up in an era and class that knew how Rev. Evanson Njogu, to truly throw one. Back in the day, she would have as he makes his appeal multiple courses of delicious food, paired with all the right for the Diocese of wines, served in the best china and crystal, put up elaborate decorations, had party favors for guests, and gave gifts to Nakuru in Kenya. everyone to take home. Guests would come dressed up and ready for an experience like no other. I wanted to relate this party to last weekend’s Gospel passage of Martha, Mary, and the one thing necessary. As I switched things up, I was not comparing this woman and her parties to Martha, worried about so many things, but rather compared her to Mary who understood what was most important: the guest! These parties were all about the guests. Jesus, who tells of the one thing necessary, is saying to Martha, Mary, and to us that the guest is most important. When we invite Jesus into our Thank you to all of the hearts, he is our guest. Jesus wants us to be attentive to volunteers that helped what he has to say. Mary sat at the feet of Jesus to listen to during the blood drive, the Word speak truth. -

Power and Piety: Examining the Papal Tiara in The
POWER AND PIETY: EXAMINING THE PAPAL TIARA IN THE CONTEXT OF THE MODERN CHURCH By Manon Wogahn A senior thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree in Bachelor of Arts in Art History CHAPMAN UNIVERSITY Orange, California May 2018 1 The papal tiara has been a symbol of the papacy since its first appearance around the eighth century. The exact symbolism of the three-tiered crown is unknown; a popular interpretation is that it represents the three divisions of the Christian Church: the Church Militant, Church Penitent, and Church Triumphant. Also called the triregnum, the tiara was last worn in public in 1963 by Pope Paul VI, who later donated his crown for charity. Since then, the last four popes, including the current Pope Francis, have received tiaras but have never worn them publicly. This project analyzes the rejection of the papal tiara and of the coronation ceremony as a symbol of the changing values of the modern papacy relationship between the disappearance of the papal tiara and the changing values of the modern papacy after the Second Vatican Council (1962-65). By examining the history of Paul VI’s crown within the context of a centuries-old tradition, I show how the papal tiara has been transformed from a symbol of the pope’s temporal power into a representation of material wealth that has become incompatible with the image of modest piety promoted by the contemporary papacy. In the 2016 drama television series The Young Pope, the fictional American pontiff Pius XIII causes shock and unrest within the Vatican with his controversial conservative philosophies and rejection of his predecessor’s liberality. -

Aglianico from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Aglianico From Wikipedia, the free encyclopedia Aglianico (pronounced [aʎˈʎaːniko], roughly "ahl-YAH-nee- koe") is a black grape grown in the Basilicata and Campania Aglianico regions of Italy. The vine originated in Greece and was Grape (Vitis) brought to the south of Italy by Greek settlers. The name may be a corruption of vitis hellenica, Latin for "Greek vine."[1] Another etymology posits a corruption of Apulianicum, the Latin name for the whole of southern Italy in the time of ancient Rome. During this period, it was the principal grape of the famous Falernian wine, the Roman equivalent of a first-growth wine today. Contents Aglianico from Taurasi prior to veraison Color of Black 1 History berry skin 2 Relationship to other grapes Also called Gnanico, Agliatica, Ellenico, 3 Wine regions Ellanico and Uva Nera 3.1 Other regions Origin Greece 4 Viticulture Notable Taurasi, Aglianico del Vulture 5 Wine styles wines 6 Synonyms Hazards Peronospera 7 References History The vine is believed to have first been cultivated in Greece by the Phoceans from an ancestral vine that ampelographers have not yet identified. From Greece it was brought to Italy by settlers to Cumae near modern-day Pozzuoli, and from there spread to various points in the regions of Campania and Basilicata. While still grown in Italy, the original Greek plantings seem to have disappeared.[2] In ancient Rome, the grape was the principal component of the world's earliest first-growth wine, Falernian.[1] Ruins from the Greek Along with a white grape known as Greco (today grown as Greco di Tufo), the grape settlement of Cumae. -
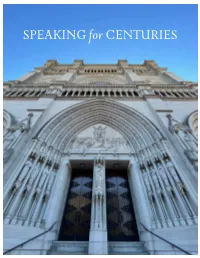
SPEAKING Forcenturies
SPEAKING for CENTURIES CATHEDRAL BASILICA FAÇADE DEDICATION 1 2 SPEAKING FOR CENTURIES SOLEMN VESPERS Celebrating the Dedication of ST. MARY'S CATHEDRAL BASILICA OF THE ASSUMPTION FAÇADE Sunday | June 6, 2021 | 2:00 p.m. Solemnity of Corpus Christi Covington, Kentucky DIOCESE of COVINGTON CATHEDRAL BASILICA FAÇADE DEDICATION 3 H H P F Prelude Entrance Antiphon Ecce Sacerdos Magnus Stadler Let us all rejoice in the Lord, as we celebrate the feast day in honor of all the Saints, at whose festival the Angels rejoice and praise the Son of God. Welcome Very Reverend Ryan L. Maher, V.G. Rector of the Cathedral Basilica Invitatory Bishop O God, come to my assistance. All O Lord, make haste to help me. Bishop Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. All As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Alleluia. 4 SPEAKING FOR CENTURIES B C P M Hymn For All the Saints sine nomine For all the saints, who from their labors rest, Who thee by faith before the world confessed, !y name, O Jesus, be forever bless’d. Alleluia, Alleluia! Oh, bless’d communion, fellowship divine! We feebly struggle, they in glory shine, Yet all are one in thee, for all are thine. Alleluia, Alleluia! ** !e last verse will be sung by the Choir ** !e golden evening brightens in the west. Soon, soon to faithful servants cometh rest. Sweet is the calm of paradise the bless’d. Alleluia, alleluia! CATHEDRAL BASILICA FAÇADE DEDICATION 5 Psalmody Bishop ANTIPHON 1 Christ the Lord is a priest for ever in the line of Melchizedek; he o"ered up bread and wine. -

PEARLS CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Ilontion: FETTER LANE, E.G
\ \ The Cambridge Manuals of Science and Literature PEARLS CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS iLontion: FETTER LANE, E.G. C. F. CLAY, Manager OFUinburgi) : loo, PRINCES STREET ILon^on: H. K. LEWIS, 136, GOWER STREET, W.C. WILLIAM WESLEY AND SON, 28, ESSEX STREET, STRAND JSfdm: A. ASHER AND CO. ILcipjig: F. A. BROCKHAUS i^cbJ Hork: G. P. PUTNAM'S SONS iSombap anti (Calcutta: MACMILLAN AND CO., Ltd. All rights reserved 1 PRINTED BY JOHN CLAY, M.A. AT THE UNIVERSITY PRESS M'ith the exception of the coat of arms at the foot, the design on the title page is a reproduction of one used by the earliest known Cambridge printer, John Siberch, i 5 2 PREFACE "VyO one can be better aware of the defects in this J^\ little book than the author. It has been . written with a view to giving a summary of the most important facts about pearls, pearl fishing and pearl formation, and it is hoped by the writer that any sins of omission will be pardoned. There is no lack of literature on the subject of pearls, and some of the volumes which have been published on this subject are themselves of great value. They do not seem, however, to be easily within reach of the average reader, and they are nearly always written from non-biological points of view. The works on pearl formation are, on the other hand, usually very technical. The structure and natural history of the shell-fish in which pearls are produced are hardly ever described outside scientific treatises ; hence the chapter on this subject.