5A Regione Del Veneto 19-12-14 1 DZ
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
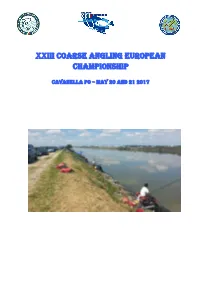
XXIII COARSE ANGLING European Championship
XXIII COARSE ANGLING European CHAMpIONSHIP CAVANELLA PO – MAY 20 and 21 2017 Welcome, dear angler friends, I am delighted to express on my name and on behalf of the Italian Sport Fishing and Underwater Activities Federation (FIPSAS), the best greetings to all participants at this Coarse Angling European Championships that this year is going to take place from May 20th until 21th 2017, in a charming area of Veneto Region, along the “Canalbianco” bank. I am sure that all attending athletes, who will join Rovigo as well as all managers, judges and stewards will find a way to explore and appreciate our beauties and taste Veneto people’s hospitality and of all those who have made all efforts for the organization of this sport fishing important event. I am particularly delighted to express my warmest welcoming to all in the aim to live together some happy days in the name of sport. A special “good luck” to all Judges convened to manage this race, in the certainty of their professional and fair commitment they have also expressed in precedent occasions. Finally, I wish to thank the organizing Committee and his President, the local authorities and all journalists for their support and contribution for this event’s good success. The FIPSAS President Prof. Ugo Claudio Matteoli OFFICIAL PROGRAMME From: Sunday 14 May 2017 (arrival of teams) To: Monday 22 May 2017 (departure of teams) INFORMATION ABOUT LOREO CITY This city is located in the “Basso Polesine” between the Adige and the Po river. A series of little streets leading into “Piazza Longhena”, which preserves its ancient appearance next to the Cathedral (1658), rich of many artworks. -

Provincia Di Rovigo
Provincia di Rovigo Protocollo n. 11522 Deliberazione n. 06 Estratto dal Verbale delle deliberazioni del CONSIGLIO PROVINCIALE Seduta dell'11 marzo 2013 Oggetto n. 04: PSR per il Veneto 2007 – 2013, Misura 321, Azione 1 – progetto “Attivazione e coordinamento di una rete di servizi fra enti locali e associazioni di volontariato per una omogeneizzazione dei servizi di trasporto sociale”. Adeguamento convenzioni con enti locali aderenti e associazioni di volontariato diverse dal territorio provinciale e del regolamento di accesso e disciplina del servizio. SEDUTA PUBBLICA Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori: CONSIGLIERE P A CONSIGLIERE P A 01 AVANZI Pierangelo P 13 GROTTO Franco P 02 BIMBATTI Andrea A 14 MANTOVANI Silvana P 03 BOLOGNESI Gian Paolo P 15 MASIN Matteo P 04 BORSETTO Ottavio P 16 MORO Monica A 05 BOSCOLO Giuseppe P 17 RAISI Michele A 06 CAPPATO Fiorella P 18 RIGONI Alessandro A 07 CARLIN Filippo A 19 ROSSI Tommaso P 08 CONTIERO Antonello A 20 SIVIER Angelo P 09 FALCONI Stefano A 21 TRANIELLO GRADASSI Giuseppe A 10 FRIGATO Federico P 22 TROMBINI Marco P 11 GIBIN Ivano P 23 VECCHIATTI FRANCO P 12 GIRARDI Oriana A 24 VERONESE VASCO A 25 VIRGILI Tiziana Michela, Presidente della Provincia P Presenti n. 15 Assenti n. 10 Presiede Federico Frigato, Presidente del Consiglio Provinciale. Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina. Consigliere Anziano: GianPaolo Bolognesi. Scrutatori: Pierangelo Avanzi, GianPaolo Bolognesi, Matteo Masin. Il Presidente del Consiglio Provinciale presenta ed illustra al Consiglio Provinciale il presente provvedimento dandolo per letto. PREMESSO: CHE la Provincia di Rovigo è titolare di un contributo di € 150.000,00= per l'attuazione del progetto “Attivazione e coordinamento di una rete di servizi fra enti locali e associazioni di volontariato per una omogeneizzazione dei servizi di trasporto sociale” concesso con il Decreto di ammissibilità e finanziabilità N. -

Villamarzana, Villanova Del Ghebbo
Provincia di Rovigo Ufcio Associato di Statstca tra la Provincia di Rovigo e i Comuni di Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Frassinelle Polesine, Frata Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusia, Occhiobello, Pincara, Salara, Stenta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo LA SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI Villamarzana Informazioni introdutte I dat elaborat sono raccolt dall'Istat annualmente presso i Comuni con la rilevazione "Indagine sugli intervent e i servizi sociali dei Comuni singoli o associat" (IST-01181) che rileva la spesa sostenuta dal Comune per i servizi sociali. Per l’analisi dei servizi sociali i dat vengono presentat secondo due tpi di aggregazione: Area di intervento: Famiglie e minori Disabili Dipendenze Anziani Immigrat e nomadi Povertà, disagio adult e senza dimora Multutenza Categoria di intervento: Intervent e servizi Contribut economici Struture I dat si riferiscono agli anni dal 2013 al 2015; sono stat fat confront, ove possibile, coi valori medi della provincia di Rovigo e con quelli della zona di appartenenza in Polesine (Alto Polesine). I valori della spesa riportat nelle tabelle e grafci sono in euro. Ogni tabella e grafco sono introdot da una breve spiegazione del contenuto. Dicembre 2018 Servizi sociali Nella tabella 1 sono riportate le spese comunali sostenute, suddivise nelle aree d’intervento sociale. Si notano quindi le aree con un “peso” maggiore in termini di spesa, e quindi più sostenute dal Comune, e quelle meno supportate. La variazione, in percentuale positiva o negativa, della spesa tra il 2014 e il 2013 è indicata nell’ultima colonna. Tab. 1 - Spesa per interventi e servizi sociali per area di intervento in € e variazione percentuale. -

Cavanella Po (Rovigo)
CITTÀ PROVINCIA COMUNE DI ADRIA DI ROVIGO DI LOREO Pesca 2017 Cavanella Po (Rovigo) Benvenuti, cari amici pescatori, Sono lieto di esprimere a mio nome e per conto della Federazione Italiana Pesca Sportiva Italiana e Attività Subacquee (FIPSAS), i migliori saluti a tutti i partecipanti a questo Campionato Europeo di Pesca al Colpo che quest'anno sta andando a prendere posto dal 20 maggio fino al 21 maggio 2017 , in una zona affascinante della Regione Veneto, lungo la riva del "Canalbianco". Sono sicuro che tutti gli atleti partecipanti, che si uniranno a Rovigo, così come tutti i manager, i giudici e amministratori troveranno un modo per esplorare e apprezzare le nostre bellezze e gustare l'ospitalità del Veneto le persone e di tutti coloro che hanno fatto tutti gli sforzi per l'organizzazione di questo importante evento di pesca sportiva. Sono particolarmente lieto di esprimere il mio più caloroso benvenuto a tutti con lo scopo di vivere insieme alcuni giorni felici in nome dello sport. Uno speciale "in bocca al lupo" a tutti i giudici che sono riuniti per gestire questa gara, nella certezza del loro impegno professionale che hanno già espresso in occasioni precedenti. Infine, desidero ringraziare il comitato organizzatore e il suo Presidente, le autorità locali e tutti i giornalisti per il loro sostegno e il contributo per la buona riuscita di questo evento. Il Presidente FIPSAS Prof. Ugo Claudio Matteoli PROGRAMMA UFFICIALE Da:Domenica 14 Maggio 2017 (arrivo delle squadre) A: Lunedi 22 MAGGIO 2017 (partenza delle squadre) INFORMAZIONI SU LOREO Questa città si trova nel "Basso Polesine" tra l'Adige e il Po. -

Villamarzana Provincia Di Rovigo
Comune di Villamarzana Provincia di Rovigo VILLAMARZANA RAPPORTO COMUNALE SULL’ECONOMIA Anno 2017 Dicembre 2017 Questo Rapporto offre una fotografia sintetica della struttura economica del comune analizzando dati sul mondo imprenditoriale, sul mercato del lavoro e sui redditi dei contribuenti. Per presentare il maggior numero di informazioni sono stati elaborati dati a partire da quattro fonti che permettono di analizzare il livello comunale e valorizzano aspetti differenti della situazione economica. Dove possibile sono stati condotti confronti con la zona d’appartenenza del comune e con la provincia. Il rapporto è diviso in sezioni in base all’oggetto dell’analisi: ● Sezione 1. Imprese attive del comune (Fonte A.S.I.A. - Istat). Analisi delle imprese per macro settore di attività economica e degli addetti, anni dal 2011 al 2015 ………..…………... Pag. 3 ● Sezione 2. Demografia d’impresa (Fonte A.S.I.A. - Istat). Studio longitudinale che segue le imprese nate tra gli anni 2010 e 2014 e ne verifica la sopravvivenza ………………..... Pag. 7 ● Sezione 3. Localizzazioni attive nel comune (Fonte C.C.I.A.A Delta Lagunare - Infocamere).● Analisi delle unità locali attive e degli addetti, anni dal 2012 al 2016 ………………….. Pag. 8 ● Sezione 4. Mercato del lavoro nel comune (Fonte S.I.L.V. - Veneto Lavoro). Analisi degli iscritti ai centri per l’impego residenti nel comune e delle assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro, anni dal 2013 al 2017 ……………………………………………….……………... Pag. 11 ● Sezione 5. Reddito dei contribuenti del comune (Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze). Analisi dei redditi dei contribuenti per tipologia e fascia di reddito, anni dal 2011 al 2015 ……………………………………………………………………………………………. -

Ceneselli (Cfr Lc 1)
“L’angelo Periodico della del Signore Parrocchia portò l’annuncio Santa Maria a Maria” Annunziata di Ceneselli (cfr Lc 1) Anno XXVII – n. 3 – 11 giugno 2017 Lettera aperta del Parroco Attività della Corale Venerdì 19 maggio 2017 Estate: Le Corali riunite... Ceneselli riscopre per Maria sant’Emidio tempo D omenica 30 aprile la Corale di n occasione del 5° anniversario del per Ceneselli, accompagnata dai due I terremoto dell'Emilia del maggio maestri Marco Menabò ed Edoardo Ma- 2012, la Parrocchia di Ceneselli ha pro- riscoprire la gioia ri, insieme alla Corale S. Stefano di posto venerdì 19 maggio un incontro sul Castelmassa, con il maestro Marco Pi- tema "Ceneselli, i terremoti e un santo notti, si sono recate a San Marino pres- dimenticato: Sant'Emidio". L'appunta- apa Francesco durante il Con- so il Santuario del Cuore Immacolato di mento si è svolto in chiesa, gravemente P vegno della Chiesa Italiana a Maria. Sui due pullman, oltre alle Cora- lesionata proprio dal sisma del 2012 e Firenze del Novembre 2015 ha li, hanno preso posto familiari, amici e riaperta al culto il 30 marzo 2014. chiesto a tutti di non lasciar passare abitanti dei due paesi coinvolti e di Un edificio, uno dei quattro in Veneto, la sua esortazione apostolica Evan- gelii Gaudium, ma di far sì che in tutti i livelli, dalle Diocesi alle par- rocchie, dagli adulti fino ai bambi- ni, fosse sbriciolata e attuata con- cretamente la tesi fondamentale e cioè “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. -

ORARI SERVIZI AGGIUNTIVI ROVIGO Aggiornati Al 1° Febbraio 2021
ORARI SERVIZI AGGIUNTIVI ROVIGO aggiornati al 1° Febbraio 2021 Noi andiamo a scuola con Busitalia! LINEE POTENZIATE INDICE • La sicurezza viaggia con noi, e tu? pag. 3 • Legenda servizi aggiuntivi extraurbani pag. 5 • Elenco linee extraurbane potenziate pag. 6 • Extraurbano Rovigo pag. 7 • Informazioni e contatti pag. 14 2 LA SICUREZZA VIAGGIA CON NOI, E TU? INDOSSA CORRETTAMENTE LA NON METTERTI IN VIAGGIO SE HAI MASCHERINA A COPERTURA DI NASO E SINTOMI INFLUENZALI COME FEBBRE, BOCCA PRIMA DI SALIRE A BORDO E PER TOSSE, RAFFREDDORE. TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. tolto un paio di parole SE IL BUS HA RAGGIUNTO LA PER VIAGGIARE, È NECESSARIO UN CAPIENZA MASSIMA DI PASSEGGERI REGOLARE TITOLO DI VIAGGIO. CONSENTITA, INDICATA NELLA ACQUISTALO PRIMA DI SALIRE A BORDO, XX SEGNALETICA SULLA PORTA DI SE IL BUS HA RAGGIUNTO LA CAPIENZA PRIVILEGIANDO I CANALI DIGITALI. MASSIMAACCESSO, DI PASSEGGERI ATTENDI IL CONSENTITA,BUS SUCCESSIVO. 50 50 3 LA SICUREZZA VIAGGIA CON NOI, E TU? RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA RICORDA DI IGIENIZZARE ALLE FERMATE E A BORDO. FREQUENTEMENTE LE MANI UTILIZZANDO GLI APPOSITI DISPENCER. NON AVVICINARTI ALL’AUTISTA PER CHIEDERE INFORMAZIONI E RICORDA NON UTILIZZARE I CHE LA VENDITA A BORDO DEI TITOLI POSTI CONTRASSEGNATI. DI VIAGGIO È SOSPESA. 4 LEGENDA SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRAURBANI Tragitto effettuato da Busitalia Veneto Tragitto aggiuntivo effettuato da altri operatori Località di partenza delle Località di partenza delle corse effettuate da Busitalia corse aggiuntive effettuate Veneto da altri operatori Località di arrivo delle corse Località di arrivo delle corse aggiuntive effettuate da altri effettuate da Busitalia Veneto operatori 5 ELENCO LINEE EXTRAURBANE POTENZIATE E601.0 ROVIGO - ADRIA pag. -

ТB 1. Plants of Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach
2000L0029 — EN — 14.04.2006 — 013.001 — 54 ¼B ANNEX III PART A PLANTS, PLANT PRODUCTS AND OTHER OBJECTS THE INTRODUCTION OF WHICH SHALL BE PROHIBITED IN ALL MEMBER STATES Description Country of origin 1. Plants of Abies Mill., Cedrus Trew, Non-European countries Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. and Tsuga Carr., other than fruit and seeds 2. Plants of Castanea Mill., and Quercus Non-European countries L., with leaves, other than fruit and seeds 3. Plants of Populus L., with leaves, other North American countries than fruit and seeds ¼M12 ¼B 5. Isolated bark of Castanea Mill. Third countries 6. Isolated bark of Quercus L., other than North American countries Quercus suber L. 7. Isolated bark of Acer saccharum Marsh. North American countries 8. Isolated bark of Populus L. Countries of the American continent 9. Plants of Chaenomeles Ldl., Cydonia Non-European countries Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., and Rosa L., intended for planting, other than dormant plants free from leaves, flowers and fruit 9.1. Plants of Photinia Ldl., intended for USA, China, Japan, the Republic of Korea planting, other than dormant plants free and Democratic People's Republic of from leaves, flowers and fruit Korea 10. Tubers of Solanum tuberosum L., seed Third countries other than Switzerland potatoes 11. Plants of stolon- or tuber-forming species Third countries of Solanum L. or their hybrids, intended for planting, other than those tubers of Solanum tuberosum L. as specified under Annex III A (10) 12. Tubers of species of Solanum L., and Without prejudice to the special require- their hybrids, other than those specified ments applicable to the potato tubers listed in points 10 and 11 in Annex IV, Part A Section I, third coun- tries other than Algeria, ºA1 ÄEgypt, Israel, Libya, ºA1 ÄMorocco, Syria, Switzerland, Tunisia and Turkey, and other than European third countries which are either recognised as being free from Clavibacter michiganensis ssp. -

Parere Pati Medio Polesine
COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PARERE n. 59 del 03 Agosto 2010 (o.d.g. 7 del 03 Agosto 2010) OGGETTO: Comune di Fratta Polesine (RO),capofila del PATI denominato “del Medio Polesine” con i Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo. Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. PREMESSO CHE – ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”; – La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 03 Agosto 2010, come da nota n. 409037/45.06 del 28.07.2010 del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, segretario della commissione; – Il Comune di il Comune di Fratta Polesine (RO), quale capofila del PATI denominato “del Medio Polesine” con i Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo, con note n. 8972 del 22.09.09, n.2063 del 23.02.2010 n. 6608 del 01.07.10 , ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS; – ITER PROCEDURALE PER LA VAS I Comuni che fanno parte del PATI del “Medio Polesine”: Fratta Polesine con delibera di Giunta Comunale n. -

Galà Delle Pari Opportunità: Premiazioni Al 31/12/2019
Premio “ Galà delle Pari Op portunità” (Ex Galà della Donna” ) Riepilogo Anni precedenti Premiazioni 13 dicembre 2019 - Galà delle Pari Opportunità Comuni Premiati Premia Adria Coro Eco del Fiume di Cons.re Oriana Trombin Bottrighe Ariano Nel Polesine Schola Cantorum di Piano di Cons.re delegato alle P.O. Lina Zangirolami Rivà Bagnolo Di Po Coro Altopolesano Vangadizza Sindaco Zeri Amor Castelmassa Sabrina Brigo Vice Sindaco Roberta Azzolini Corbola Natalino Sivieri Sindaco Michele Domeneghetti Costa Di Rovigo Coro Fiat Vox Vice Sindaco Cristiano Villa Crespino Band Musicale Grace N Kaos Sindaco Angela Zambelli Fiesso Umbertiano Elisa Braiato Ass.re ai servizi sociali Luigia Modonesi Lendinara Corpo Bandistico Città di Ass.re Franco Fioravanti Lendinara Loreo Coro San Michele Arcangelo Cons.re Sara Forzato Occhiobello Marta Guidoboni Vice Sindaco Silvia Fuso Porto Tolle Chiara Cazzadore Ass.re alle P.O. Federico Vendemmiati CHIARA & MAGIC MUSIC Porto Viro Elisabetta Fantinati Sindaco Maura Veronese e Vice Sindaco Doriano Mancin Porto Viro – Comm.ne P.O. Gloria Sottovia Vice Presidente Comm.ne Com.le P.O. Luciana Milani e Sindaco Maura Veronese Provincia GIOVI -Giovanni Guarnieri Presidente Comm.ne Prov.le P.O. Antonella Bertoli Rosoli na Lorenza Bellemo Ass.re alle P.O.Alessia Zaninello Rovigo Zoe Pia Cons.re alle P.O. Erika Alberghini Stienta Emma Scarazzati Ass.re alle P.O. Marina Garato Taglio Di Po Corale di Mazzorno Destro Ass.re alle P.O. Silvia Boscaro Villamarzana Loredana Romanato Vice Sindaco Daniele Menon 21 dicembre 2018 - Galà delle Pari Opportunità 20^ edizione. A differenza degli anni precedenti in cui si invitavano i Comuni della Provincia di Rovigo, la Provincia stessa e la Regione a segnalare le premiate, l’evento è stato dedicato a tutte le componenti della Commissione P.O. -

Scheda Percorso 4
Percorsi di mobilità lenta PERCORSO 4 Sinistra Po Elaborazione: T.E.R.R.A. Consulting srl Dati percorso Dati percorso Comuni Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Calto, Salara, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello, Canaro, Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Villanova Località di Melara attraversati: Marchesana, Papozze, Adria, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle partenza: Elementi di Località di arrivo: Porto Tolle golena lungo il Po a Bergantino; golena Cibo a Castelnovo Bariano; isola Tontola a Ficarolo; golena Quarti a Guarda Veneta;golena lungo il Po a Crespino; golena di interesse (località Pila) Panarella a Papozze; conca di Volta Grimana a Loreo; golena Madonnina a Porto Viro; valli da pesca a Porto Viro e a Porto Tolle, isola della Batteria a Porto Tolle naturalistico: Lunghezza: 140,4 Km Elementi di Museo della Civiltà Contadina “Bragazzi”, chiese e monumenti storici nel centro di Melara; Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare, chiesa di San Giorgio Tipo di fondo: 96,7% asfalto, interesse e palazzi nel centro storico di Bergantino; chiesa Parrocchiale a Castelnovo Bariano; chiesa di Santo Stefano e edifici storici a Castelmassa; chiesa di San Rocco e 3,3% sterrato storico- villa Fioravanti a Calto; chiese e villa Schiatti Giglioli a Ficarolo; villa Manfredini Stampanoni e chiesa di San Giuseppe a Gaiba; villa Camerini Bertelè ora Bonfiglioli Strade a scarso 70,5% culturale: a Boaria Gilliola; Chiesa di Santo Stefano Martire e villa Masi Roveroni a Stienta; chiesa di San Lorenzo a Occhiobello; chiesa di Santa -
Calendario Turni Farmacie Rovigo E Provincia Giugno 2020 Maggio 2021 Ulss 5 Polesana Distretto 1 Rovigo Distretto 2 Adria
CALENDARIO TURNI FARMACIE ROVIGO E PROVINCIA GIUGNO 2020 MAGGIO 2021 ULSS 5 POLESANA DISTRETTO 1 ROVIGO DISTRETTO 2 ADRIA FEDERFARMA ROVIGO Via Alberto Mario, 2 ROVIGO Tel. 0425 21380 FEDERFARMA ROVIGO ASM ROVIGO S.p.A. ASM ROVIGO S.p.A Via Dante Alighieri, 4 ROVIGO FARMACIE Tel. 0425 396732 COMUNALI FARMACIE COMUNALI ROVIGO INDIRIZZO FARMACIE DISTRETTO 1 ROVIGO TURNI DA PAG. 8 ROVIGO CENTRALE SNC PIAZZA V. EMANUELE II, 17 0425 23009 ROVIGO COMUNALE 1 VIA BADALONI, 47 ROVIGO 0425 23016 COMUNALE 3 VIA TRE MARTIRI 61 ROVIGO 0425 361434 CORSO DEL POPOLO, 284 DOTT. L. DIAN S.N.C. 0425 23843 ROVIGO RHODIGIUM S.N.C. VIA UMBERTO I, 44 ROVIGO 0425 361361 SAN BORTOLO P.LE SAN BARTOLOMEO, 28 0425 24466 DR.SSA CAZZUFFI ROVIGO S. PIO X VIA AMENDOLA, 15 0425 33701 DR.SSA SEMEGHINI ROVIGO SANT’ILARIO VIA GRAMSCI, 34 0425 30493 DR. SIMEONI ROVIGO VIA BARUCHELLO, 30 TRE COLOMBINE SNC 0425 412038 ROVIGO TRE MORI VIA ZANELLA, 14 0425 23034 DR.SSA CHIARATO ROVIGO BEATA VERGINE DELLA ARQUÀ VIA V.EMANUELE II, 10 0425 91029 POLESINE SALUTE SNC ARQUA’ POL. ALLA MADONNA DELLA PIAZZA DELLA SALUTE, 3 BADIA 0425 51381 POLESINE SALUTE BONETTO SNC BADIA POL. VIA S.ALBERTO, 20 FARM. BONETTO SNC 0425 52278 BADIA POL. BAGNOLO VIA ARIOSTE, 1505 DR.SSA MARTA LUISA 0425 704001 DI PO RINALDI BAGNOLO DI PO BERGANTINO MADONNA DELLA SALUTE PIAZZA MATTEOTTI, 10 0425 805397 DR.SSA ZIBORDI BERGANTINO BOARA ALLA FENICE VIA MEUCCI 2/4 0425 484101 PISANI DR.SSA PIETROPOLI BOARA PISANI PD Fraz. BOARA VIA CURTATONE 135 COMUNALE 4 0425 485180 POLESINE BOARA POL.