Autorita' Ambito Territoriale Ottimale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

What Drives Warming Trends in Streams? a Case Study from the Alpine Foothills
RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS River Res. Applic. 31: 663–675 (2015) Published online 8 May 2014 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/rra.2763 WHAT DRIVES WARMING TRENDS IN STREAMS? A CASE STUDY FROM THE ALPINE FOOTHILLS F. LEPORI*, M. POZZONI AND S. PERA Institute of Earth Sciences, Canobbio, Switzerland ABSTRACT We investigated the effects of climate warming and land-use changes on the temperature and discharge of seven Swiss and Italian streams in the catchment of Lake Lugano. In addition, we attempted to predict future stream conditions based on regional climate scenarios. Between 1976 and 2012, the study streams warmed by 1.5–4.3 °C, whereas discharge showed no long-term trends. Warming trends were driven mainly by catchment urbanization and two large-scale climatic oscillations, the North Atlantic Oscillation and the Atlantic Multidecadal Oscillation. In comparison, independent influences by radiative forcing due to increased atmospheric CO2 were uncertain. However, radiative forcing was predicted to further increase stream temperature (to +3–7 °C), reduce summer discharge (to À46%) and increase winter discharge (to +96%) between the present and 2070–2099. These results provide new insights into the drivers of long-term temperature and discharge trends in European streams subject to multiple impacts. The picture emerging is one of transition, where greenhouse-gas forcing is gaining ground over climate oscillations and urbanization, the drivers of past trends. This shift would impress a more directional nature upon future changes in stream temperature and discharge, and extend anthropogenic warming to rural streams. Diffusing future impacts on stream ecosystems would require adaptation measures at local to national scales and mitigation of greenhouse-gas emissions at the global scale. -

Commissariato Italiano Per La Convenzione Italo-Svizzera Sulla Pesca
SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA Commissariato italiano COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza per la Convenzione tel. 0323 518327 fax 0323 55651 posta certificata [email protected] italo-svizzera sulla pesca e-mail segreteria [email protected] Codice Fiscale 93007650034 DATA N. Argomento ordinanze pag. 14/06/21 03/21 Pescate di sfoltimento di agone nel Lago Maggiore ….………….………….………….………….……. 1 03/06/21 02/21 Proroga scadenza dell’ordinanza n. 02/15 ……….………….………….………….………….…………. 2 11/01/21 01/21 Libretto segna pesci della pesca dilettantistica nelle acque lombarde soggette alla CISPP ….…..… 3 23/12/19 03/19 Libretto segna catture della pesca professionale nelle acque lacustri lombarde della CISPP ……… 4 16/12/19 02/19 Divieti di pesca allo sbocco e imbocco del F. Tresa a Lavena Ponte Tresa ………………………….. 5 21/12/18 03/18 Nuovo Regolamento di Applicazione della Convenzione (R.d.A . 2019)………………………………. 6 15/06/16 01/16 Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano………………………………. 7 08/02/16 C1/16 Impiego delle reti volanti nel Lago Maggiore ……………………………………………..………………. 8 10/11/15 14/15 Protezione popolamenti coregoni, lucioperca, persico e trota nelle acque italiane del L.Maggiore … 9 01/01/15 02/15 Protezione della fauna ittica alla foce dei principali tributari dei laghi Maggiore e di Lugano ……….. 10 01/01/15 03/15 Divieto di pesca dell’agone nelle acque italiane del Lago Maggiore ……………………………………. 11 01/01/15 05/15 Orari della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore ......................... -

Commissione Internazionale Per La Protezione Delle Acque Italo-Svizzere
ISSN: 1013-8080 Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere Ricerche sull'evoluzione del Lago di Lugano Aspetti limnologici Programma quinquennale 1998-2002 Campagna 2002 e Rapporto quinquennale 1998-2002 Ufficio Protezione e Depurazione Acque Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo Dipartimento del Territorio - Cantone Ticino I dati riportati nel presente volume possono essere utilizzati purchè se ne citi la fonte come segue: Ufficio Protezione e Depurazione Acque (UPDA), 2003: “Ricerche sull’evoluzione del Lago di Lugano. Aspetti limnologici. Programma quinquennale 1998-2002. Campagna 2002 e rapporto quinquennale 1998-2002.” Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (Ed.); 110 pp. 3 R I A S S U N T O Questo volume presenta i dati limnologici sul Lago di Lugano raccolti dall'Ufficio Protezione e Depurazione Acque (UPDA) del Cantone Ticino durante la campagna 2002, nell’ambito dell’attività di ricerca della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere svolta a partire dal 1978. Trattandosi dell'ultimo rapporto del quinquennio 1998-2002 è stato inoltre presentato e discusso l'andamento limnologico del lago sul lungo periodo. Le informazioni ottenute nel corso del 2002 permettono di aggiornare le serie storiche disponibili per i principali parametri limnologici, e di descrivere le tendenze evolutive del Lago in relazione agli interventi di depurazione sinora realizzati. Durante l’anno è proseguita l'analisi dettagliata dei carichi esterni di fosforo ai due bacini principali, in modo da verificare in quale misura le opere di risanamento contribuiscano al recupero del corpo idrico. La progressiva riduzione delle concentrazioni di fosforo riscontrata nell’ultimo decennio è proseguita nel bacino sud, mentre si è arrestata all'interno dello strato 0-100 m del bacino nord. -

Relazione Porlezza Torrenti
GEOPLANET INDICE 1. PREMESSA__________________________________________________________________ 2 1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO _________________________________________ 7 2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO __________________________________________ 8 2.1 CENNI PALEOGEOGRAFICI ___________________________________________________ 8 3. COMMENTO ALLA CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE _____________________ 9 3.1 – CARATTERI GEOMORFOLOGICI E GEOLOGICI _________________________________ 9 3.2 – CARATTERI LITOLOGICI _____________________________________________________ 11 3.2.1 Depositi superficiali ___________________________________________________________________ 11 3.2.2 Substrato roccioso ____________________________________________________________________ 13 4. ASPETTI PEDOLOGICI __________________________________________________ 21 5. OSSERVAZIONI CLIMATOLOGICHE ______________________________________ 21 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO ___________________________________________ 21 5.1.1Temperatura atmosferica ________________________________________________________________ 21 5.1.2 Radiazione solare globale _______________________________________________________________ 22 5.1.3 Precipitazioni _________________________________________________________________________ 23 5.1.4 Intensità dei venti ______________________________________________________________________ 24 6. CARATTERISTICHE METEOROLOGICHE DELL'AREALE LACUSTRE 1998-2007 25 7. REGIME DEL LIVELLO LACUSTRE _______________________________________ 27 7.1 Regime del livello lacustre 1930-1997 _________________________________________________ -

La Via Dei Canti
FORESTA REGIONALE VALSOLDA (CO) LA VIA DEI CANTI Quick link Quick link FORESTA REGIONALE PER SCARICARE VALSOLDA (CO) LE TRACCE SONORE www.ersaf.lombardia.it Barchi Darni 1316 Signora Tecchia a Marda S. Antonio Pianon 1229 n 994 1 Ugino 5 3 0 a Cagon sol 0 Posia 1100 al da Segolone L V Bogno 3 Tegnivo Colla 1610 1071 F Serravada 961 i Rusi di Vora 886 Cavargna d Cureia 1399 Bubegno Monte 1 Colone Zocchetta Cima al 20 0 Burena e Matro l Marsèta Rif. S. Lucio l 1224 Scareglia A. Cottino a Ambesello Corticiasca 1550 Forni Vecchi S. Nazzaro Rugino F V 816 Pianca 1441 Val Cavargna Cardè Lember Maglio Vraghex 1016 S. Lucio Pradè di Colla 1540 S. Giovanni P.te di Lana Gordolina Roncaliva 1000 Piana dellʼUva Carnia Piazza T 9 o r Certara 12 00 r e Albumo 0 00 V n 0 t 4 3 e Cranello 1 Buchi C Neggio Trevin a Ponte Calbino u 80 Insone 12 0 1003 00 c Osnaga l c Roccoli i Piandera o Vora 853 Tavaino Pezza 1379 d Püfin Valpèra Freggio i Carusio C S. Bartolomeo 680 Premestivo Monte a v Val Cavargna 0 880 a Piazzora 0 Roccolo Citella Alpetto Sella C r g F Nagia Curtina 4 n a Piano della 1 Cavada Forcoletta 1334 Pezza Sora 130 0 802 a 0 a 0 Al Ponte Cucco 1148 701 7 Costa Trecciò l Passo della meo Piancaccia La Corte rtolo l v . Ba 870 Cava i S o Paradiso d o C i c c Bertogno l 880 Nendum Alpe Colmine a u a Prato Bello 1484 3 C V Cimadera e 700 00 Grisello t 0 1 n 1 1624 Monte Cucco 2 V 0 e 0 Crisello r rr o 0 T 800 a 0 Seghébbia Monte Piazzola V 3 Dasio 1 582 a l 1354 g Cusino Arla 1100 l Ponte 1 Mugnai l Val Rezzo 0 Dovia 1110 0 Le Spine d Prati della Poma 0 e Costa di Stella Cugnoli i 925 0 n Mattor dei Falchi Corti V 0 V 4 Buggiolo 0 d 1 0 a 9 1300 e 1290 828 i a l Prati di Firovana g g n a Alpe Crisello a i V C S d a i V Madonna dʼArla 1 n l d 3 F 0 i Monti Torre 753 1072 Alpaccio p 0 a 1 20 C 0 i l 947 n a Pramarzio 1587 p B.tta di Usin a 1061 1100 o S. -

Rapporto Ambientale
Provincia di Varese COMUNE DI PORTO CERESIO RAPPORTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO CERESIO (VA) Num. Rif. Lavoro 10-068 N. copie consegnate 5+2 Data Redatto Approvato rev00 GIUGNO 2013 Dr. Barbara Raimondi Dr. Alessandro Uggeri rev01 rev02 Collaboratori Dr. Biol. B. Raimondi, Dr. Geol. A. Uggeri, Dott. M. Serra. Dott. T. Brogilato Nome file 10-068RA parte I PCeresio_rev02.doc; 10-068RA parte II PCeresio_rev02.doc Via Lungolago di Calcinate, 88 21100 Varese Tel. 0332 286650 – Fax 0332 234562 www.idrogea.com - [email protected] P.IVA : 02744990124 COMUNE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI PORTO PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) rev02 CERESIO giugno 2013 Provincia di RAPPORTO AMBIENTALE Varese Introduzione SOMMARIO INTRODUZIONE 1 INTRODUZIONE ................................................................................................................... 6 1.1 Normativa di riferimento ................................................................................................ 6 1.2 Scopo del documento .................................................................................................... 7 2 DEFINIZIONE DELLO SCHEMA METODOLOGICO ........................................................................ 9 2.1 Schema metodologico .................................................................................................... 9 2.2 Soggetti del procedimento ........................................................................................... -

Pescare Nel Bacino 5 (Verbano
ANNO 2020 2 INDIRIZZI UTILI E RIFERIMENTI TERRITORIALI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA INSUBRIA -Varese Orario di apertura al pubblico: Viale Belforte, 22 ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 21100 VARESE (VA) ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Attività: gestione faunistica Sportello Utenza: 0332.338367 [email protected] AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA INSUBRIA -Como Orario di apertura al pubblico: Via L. Einaudi, 1 ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 22100 COMO (CO) Attività: gestione faunistica ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Sportello Utenza: 031.320570 [email protected] AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Brianza -Lecco Corso Promessi Sposi, 132, Orario di apertura al pubblico: 23900 LECCO (LC) ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 Attività: gestione faunistica ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Sportello Utenza: 0341.358946 [email protected] PESCARE NEL BACINO 5 – VERBANO LARIO CERESIO 4 PESCARE NEL BACINO 5 – VERBANO LARIO CERESIO PREMESSA Questa pubblicazione ha carattere divulgativo e non legale; essa riassume i regolamenti di pesca in vigore nel bacino n° 5 -Verbano, Lario, Ceresio- al 1 gennaio 2020 Il bacino 5 comprende la porzione lombarda dei laghi Verbano, Ceresio, Lario e i laghi Mezzola, Garlate e Olginate, Varese, Comabbio, Monate, Montorfano, Alserio, Segrino, Piano, Pusiano, Annone, con i loro tributari. Sono escluse tutte le acque che ricadono nella Provincia di Sondrio. Appartengono al bacino 5 il fiume Adda immissario nel tratto compreso fra il Lario e il confine con la provincia di Sondrio, il fiume Adda emissario fino al nuovo Ponte ferroviario del Lavello, il fiume Ticino fino al ponte di Sesto Calende, il fiume Olona fino al ponte di Vedano e il fiume Lambro fino al ponte di Nibionno sulla Sp 342. -

In Moto Tra Lecco E Como Introduzione 2
in moto tra Lecco e Como Introduzione 2 Questa guida è dedicata ai motociclisti che le due ruote ce le hanno un po’ nel cuore, ai motociclisti che sono anche poco o tanto turisti; ai motociclisti che amano la strada e le sensazioni che essa può dare; ai motociclisti che non si accontentano di salire in sella solo per andare al bar; ai motociclisti che oltre all’articolazione del polso sanno usare lo sguardo per godere di un panorama e l’olfatto per respirare profumi e sensazioni; ai motociclisti che non devono Assessorato al Turismo Assessorato al Turismo obbligatoriamente guardare l’orologio Corso Matteotti, 3 Via Sirtori, 5 perchè è il sole a scandire la loro giornata; 23900 Lecco 22100 Como ai motociclisti che preferiscono Tel. +39 0341 295516/ 509 Tel. +39 031 2755595 due pieghe alle tre corsie di un’autostrada; Fax +39 0341 295501 Fax +39 031 2755569 www.provincia.lecco.it www.provincia.como.it ai motociclisti che godono della moto anche [email protected] [email protected] senza limare le pedane ad ogni curva; ai motociclisti che hanno capito Ufficio Informazioni Turistiche Ufficio Informazioni Turistiche che le due ruote sono libertà, gioia e vita; Via Nazario Sauro, 6 Piazza Cavour, 17 23900 Lecco 22100 Como ai motociclisti che hanno capito Tel. +39 0341 295720/ 721 Tel. +39 031 269712 che la vita è importante e non va stupidamente Fax +39 0341 295730 Fax +39 031 240111 messa a repentaglio; www.turismo.provincia.lecco.it www.lakecomo.org ai motociclisti che arrivati a casa [email protected] [email protected] non vedono l’ora di ripartire; a tutti loro: BUON VIAGGIO! 3 indiceitinerario itinerari 1 LECCO pag. -

Stato Delle Acque Superficiali Della Provincia Di Varese
STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE RAPPORTO ANNUALE 2012 DIPARTIMENTO DI VARESE Settembre, 2013 Stato delle acque superficiali della provincia di Varese. Anno 2012 1 Il Rapporto annuale 2012 sullo stato delle acque superficiali è stato predisposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia. Autori Dipartimento di Varese ‐ U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali Valeria Roella Andrea Beghi Cristina Borlandelli Franca Pandolfi Le tematiche comuni a tutti i Dipartimenti sono state redatte da: Direzione Generale ‐ Settore Monitoraggi Ambientali – U.O. Acque Nicoletta Dotti Pietro Genoni Massimo Paleari Laura Tremolada Direzione Generale ‐ Settore Monitoraggi Ambientali ‐ U.O. Risorse Naturali e Biodiversità Rossella Azzoni Pierfrancesca Rossi ARPA LOMBARDIA Dipartimento di Varese Via dei Campigli, 5 Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Cazzaniga In copertina: Lago di Comabbio, 2012 ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Varese Stato delle acque superficiali della provincia di Varese. Anno 2012 2 Sommario 1 INTRODUZIONE ......................................................................................................................................................... 3 2 IL QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO .............................................................................................................. 4 3 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ............................................................................................................... 8 3.1 OBIETTIVI DI QUALITÀ .................................................................................................................................................... -

Year-Round N2O Production by Benthic Nox Reduction in a Monomictic South-Alpine Lake
Biogeosciences, 10, 8373–8383, 2013 Open Access www.biogeosciences.net/10/8373/2013/ doi:10.5194/bg-10-8373-2013 Biogeosciences © Author(s) 2013. CC Attribution 3.0 License. Year-round N2O production by benthic NOx reduction in a monomictic south-alpine lake C. V. Freymond1,*, C. B. Wenk1, C. H. Frame1, and M. F. Lehmann1 1Department of Environmental Sciences, University of Basel, Bernoullistrasse 30, 4056 Basel, Switzerland *now at: Institute of Geology, ETH Zürich, Sonneggstrasse 5, 8092 Zürich, Switzerland Correspondence to: C. V. Freymond ([email protected]) and M. F. Lehmann ([email protected]) Received: 18 February 2013 – Published in Biogeosciences Discuss.: 12 March 2013 Revised: 30 October 2013 – Accepted: 12 November 2013 – Published: 20 December 2013 Abstract. Nitrous oxide (N2O) is a potent greenhouse gas, 1 Introduction generated through microbial nitrogen (N) turnover processes, such as nitrification, nitrifier denitrification, and denitrifi- Nitrous oxide (N2O) is a potent greenhouse gas with a global cation. Previous studies quantifying natural sources have warming potential that is ∼ 300 times higher than that of mainly focused on soils and the ocean, but the potential CO2 over a 100 yr time horizon (Forster et al., 2007). Fur- role of terrestrial water bodies in the global N2O budget thermore, N2O is the most important stratospheric ozone- has been widely neglected. Furthermore, the biogeochemi- depleting substance currently being emitted to the atmo- cal controls on the production rates and the microbial path- sphere (Ravishankara et al., 2009). The atmospheric con- ways that produce benthic N2O in lakes are essentially un- centration has increased from 270 ppb in 1750 (Forster et known. -

TOURIST GUIDE ASSOCIATIONS PROVINCE of COMO Associazione Guide E Accompagnatori Turistici Di Como E Provincia Phone No
TOURIST GUIDE www.lakecomo.com ISOLA COMACINA 01_ING_presen_sistema.indd 1 25/07/11 11:40 PRESENTATION This Tourist Guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will fi nd, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known Via Sirtori 5 - 22100 Como places. Phone No. + 39 031 2755551 Subdivided into geographical areas of lake, mountain Fax + 39 031 2755569 and plain, the Guide describes the entire territory of [email protected] www.provincia.como.it Como and Lecco provinces; its history, architecture, art www.lakecomo.com and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport. -
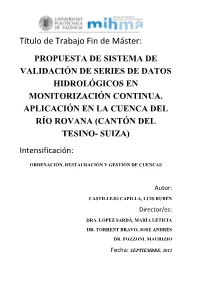
Título De Trabajo Fin De Máster
Título de Trabajo Fin de Máster: PROPUESTA DE SISTEMA DE VALIDACIÓN DE SERIES DE DATOS HIDROLÓGICOS EN MONITORIZACIÓN CONTINUA. APLICACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO ROVANA (CANTÓN DEL TESINO- SUIZA) Intensificación: ORDENACIÓN, RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DE CUENCAS Autor: CASTILLEJO CAPILLA, LUIS RUBÉN Director/es: DRA. LÓPEZ SARDÁ, MARÍA LETICIA DR. TORRENT BRAVO, JOSE ANDRÉS DR. POZZONI, MAURIZIO Fecha: SEPTIEMBRE, 2012 Título del trabajo de Fin de Máster PROPUESTA DE SISTEMA DE VALIDACIÓN DE SERIES DE DATOS HIDROLÓGICOS EN MONITORIZACIÓN CONTINUA. APLICACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO ROVANA (CANTÓN DEL TESINO- SUIZA) Autor: CASTILLEJO CAPILLA, LUIS RUBÉN Tipo A B Lugar de Lugano, Suiza Director LÓPEZ SARDÁ, MARÍA LETICIA Realización Codirector TORRENT BRAVO, JOSE ANDRÉS Fecha de Tutor POZZONI, MAURIZIO Lectura SEP. 2012 Resumen: El presente trabajo estudia el sistema de validación de datos hidrológicos propuesto por el Instituto de Science della Terra, en Suiza, propone mejoras a dicho sistema y lo valida con series de datos reales. El estudio se ha centrado en la validación de datos de precipitaciones y de forma secundaria en validación de series de datos de profundidad hídrica de cursos de agua. Se han propuesto una serie de diagramas de flujo, tanto genéricos como específicos, por donde deberán circular los datos en su proceso de validación así como la aplicación y mejora de cada uno de los pasos de la validación. Así mismo se ha modelado hidrológicamente el tramo de un río situado en la zona donde se desea aplicar el sistema de validación, ya que se ha estimado que el conocimiento de la dinámica de la serie de datos que se desea validar es fundamental para el éxito de la validación.