Terra D'ossola.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Valle D'ossola, Val Vigezzo (Prov. Di Novara)-Centovalli (Kt
Geographica Helvetica 1987 - Nr. 4 Rene Hantke Zur Talgeschichte zwischen Domodossola und Locarno: Valle d'Ossola, Val Vigezzo (Prov. di Novara)-Centovalli (Kt. Tessin) 2. Teil* mit Kartenbeilage 7. Die pleistozane Ausräumung in der Schuttfächer bewaldet; in den Interstadialen stieg Vigezzo - Centovalli-Talung der Wald um einige hundert Meter an, auf 10001200 m. Die warmzeitliche Ausräumung hat - Die bescheidene Eintiefung längs der Centovalli- infolge der weitgehenden Bewaldung - vor allem Störung (S. 16) hängt vor allem mit der quer zur steile Gebiete ergriffen. In den wärmsten Phasen Hauptstoß-Richtung des Eises verlaufendenTalung lag die Waldgrenze - heute um 1800-2000 m - um zusammen. Das von Domodossola in dieV Vigezzo 200-300 m höher, wie aus der interglazialen Flora eingedrungene Toce-Eis hatte dabei eine Felsstufe der Seetone von Re mit ihren wärmeliebenden Ar¬ von über 230 m zu überwinden. Zudem drang von ten hervorgeht. Locarno Tessin-Eis gegen W vor, staute das aus Besonders in tektonisch zerrütteten Bereichen hin¬ V. Maggia und V Onsernone austretende Eis und terlassen katastrophale Unwetter ihre Spuren. Da drängte dieses in die Centovalli. Damit wurde das sich die Schadengebiete erst mit den neuzeitlichen Toce-Eis zurückgestaut und die kaltzeitliche Ero¬ Rodungen - vorab in steilen Quellbereichen - ge¬ sion stark reduziert. Daß dies - mit Ausnahme der häuft haben, darf ihre Erosionswirkung nicht auf Kolktiefen um Domodossola und um Locarno - in alle Warmzeiten mit über 80% Waldbedeckung aus¬ den älteren Hochglazialen viel anders gewesen sein gedehnt werden. soll, ist unwahrscheinlich. N des Sassetto und an derW-Flanke der CimaTrub- In der V Vigezzo konnte eine Eintiefung nur in en¬ bio N Malesco reicht derWald bis 1900 m; die Baum¬ gen Vorstoß- und Abschmelz-Bereichen stattfinden, grenze liegt auf 1980 m, die Krüppelgrenze auf bei Eisständen zwischen Druogno und der Mün¬ 2040 m. -

Divisionismo La Rivoluzione Della Luce
DIVISIONISMO LA RIVOLUZIONE DELLA LUCE a cura di Annie-Paule Quinsac Novara, Castello Visconteo Sforzesco 23.11.2019 - 05.04.2020 Il Comune di Novara, la Fondazione Castello Visconteo e l’associazione METS Percorsi d’arte hanno in programma per l’autunno e l’inverno 2019-2020 nelle sale dell’imponente sede del Castello Visconteo Sfor- zesco – ristrutturate a regole d’arte per una vocazione museale – un’im- Gaetano Previati Maternità 1 DELLA LUCE LA RIVOLUZIONE DIVISIONISMO portante mostra dedicata al Divisionismo, un movimento giustamente considerato prima avanguardia in Italia. Per la sua posizione geografica, a 45 km dal Monferrato, fonte iconografica imprescindibile nell’opera di Angelo Morbelli (1853-1919), e appena più di cento dalla Volpedo di Giuseppe Pellizza (1868-1907) – senza dimenticare la Valle Vigezzo di Carlo Fornara (1871-1968) che fino a pochi anni era amministrativa- mente sotto la sua giurisdizione – Novara, infatti, è luogo deputato per ospitare questa rassegna. Sono appunto i rapporti con il territorio che hanno determinato le scelte e il taglio della manifestazione. incentrata sul Divisionismo lombardo-piemontese. Giovanni Segantini All’ovile 2 DELLA LUCE LA RIVOLUZIONE DIVISIONISMO La curatela è stata affidata ad Annie-Paule Quinsac, tra i primissimi storici dell’arte ad essersi dedicata al Divisionismo sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso, esperta in particolare di Giovanni Segantini – figura che ha dominato l’arte europea dagli anni Novanta alla Prima guerra mondiale –, del vigezzino Carlo Fornara e di Vittore Grubicy de Dragon, artisti ai quali la studiosa ha dedicato fondamentali pubblicazio- ni ed esposizioni. Il Divisionismo nasce a Milano, sulla stessa premessa del Neo-Im- pressionnisme francese (meglio noto come Pointillisme), senza tuttavia Carlo Fornara Fontanalba 3 DELLA LUCE LA RIVOLUZIONE DIVISIONISMO Angelo Morbelli Meditazione Emilio Longoni Bambino con trombetta e cavallino 4 DELLA LUCE LA RIVOLUZIONE DIVISIONISMO che si possa parlare di influenza diretta. -

Relazione Sulla Gestione 2012
2012 BILANCIO D’ESERCIZIO BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 In copertina: Carlo Fornara, Il seminatore, 1895, olio su tela, cm. 26,5 x 34 - collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ___________________________________________________________________________________________________________ 2 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 SOMMARIO 4 Relazione sulla gestione 157 Prospetti di bilancio 159 Nota integrativa 209 Relazione del Collegio dei Revisori ___________________________________________________________________________________________________________ 3 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 RELAZIONE SULLA GESTIONE INTRODUZIONE – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il 31 dicembre 2012 si è chiuso il ventunesimo esercizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Il quadro di riferimento normativo relativo allo scorso esercizio è stato caratterizzato da numerosi interventi legislativi che hanno inciso, in alcuni casi significativamente, sull’attività delle fondazioni bancarie. Di seguito una breve panoramica su tali novità. Governance delle Fondazioni L’art. 27-quater della legge n. 27/2012 ha apportato alcune integrazioni all’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 153/99. In particolare, in tema di requisiti dei componenti l’Organo di Indirizzo delle Fondazioni, viene previsto il ricorso a modalità di designazione ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità. Viene poi inserita una ulteriore ipotesi di incompatibilità riferita ai soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni: trattasi dell’impossibilità, per tali soggetti, di assumere od esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del gruppo. -

IL MONDO DEI FUNGHI Appunti Di Micologia
Maria Rosaria Tieri – Nino Tieri IL MONDO DEI FUNGHI appunti di micologia 1 Collana : “I quaderni della natura ” © Dispensa tratta da : FUNGHI D‟ABRUZZO Edizioni Paper's World S. Atto Teramo di Maria Rosaria Tieri e Nino Tieri FUNGHI IN CUCINA Edizioni Menabò di Maria Rosaria Tieri e Nino Tieri Con la preziosa collaborazione del prof. Mimmo Bernabeo Copertina di Nino Tieri © I diritti sono riservati. Il divieto di riproduzione è totale, anche a mezzo fotocopia e per uso interno. Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di ricerca o trasmessa in qualunque forma elettronica, meccanica, registrata o altro. 2 BREVE STORIA DELLA MICOLOGIA Le origini dei funghi sono di sicuro antichissime, di certo, i funghi, come organismi eucarioti, apparvero sulla terra più di 500 milioni di anni fa. La documentazione, circa la loro presenza, viene dedotta dai resti fossili venuti recente- mente alla luce, risalenti a moltissimi milioni di anni fa: nei resti del carbonifero (300 milioni di anni fa) sono, infatti, riconoscibili varietà di funghi ancora oggi presenti tra le specie della flora fungina. Le popolazioni primordiali, agli inizi della civiltà umana, hanno avuto sicuramente di- mestichezza con i funghi, sia per scopi alimentari che per pratiche religiose ed arti- stiche. Oggi non siamo a conoscenza del significato che i funghi rappresentavano per l‟uomo primitivo. Non è noto, infatti, se egli se ne nutrisse o se li ignorasse, né tanto- meno se fosse in grado di distinguere le specie eduli da quelle velenose. Tra gli oggetti ritrovati nello zaino dell‟uomo di Similaun, risalente a più di 5000 anni fa, vi erano anche funghi allucinogeni secchi. -

Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 30 · Nummer 2 · 2009 Svensk Mykologisk Tidskrift Inkluderar Tidigare
Volym 30 nummer 2 2009 2 nummer 30 Volym Svensk Mykologisk Tidskrift Tidskrift Mykologisk Svensk Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 30 · nummer 2 · 2009 Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: www.svampar.se Svensk Mykologisk Tidskrift Sveriges Mykologiska Förening Tidskriften publicerar originalartiklar med svamp- Föreningen verkar för anknytning och med svenskt och nordeuropeiskt - en bättre kännedom om Sveriges svampar intresse. Tidskriften utkommer med fyra nummer och svampars roll i naturen per år och ägs av Sveriges Mykologiska Förening. - skydd av naturen och att svampplockning och Instruktioner till författare finns på SMF:s hemsida annat uppträdande i skog och mark sker under www.svampar.se Tidskrift erhålls genom medlem- iakttagande av gällande lagar skap i SMF. - att kontakter mellan lokala svampföreningar Svensk Mykologisk Tidskrift framställs med bidrag och svampintresserade i landet underlättas från bl. a. Tore Nathorst-Windahls minnesfond - att kontakt upprätthålls med mykologiska och Naturvårdsverket. föreningar i grannländer - en samverkan med mykologisk forskning och Redaktion vetenskap. Redaktör och ansvarig utgivare Mikael Jeppson Medlemskap erhålls genom insättning av Lilla Håjumsgatan 4, medlemsavgiften 250:- (familjemedlem 50:-, 461 35 TROLLHÄTTAN vilket ej inkluderar Svensk Mykologisk Tidskrift) 0520-82910 på postgirokonto 443 92 02 - 5. Medlemsavgift [email protected] inbetald från utlandet är 300:-. Hjalmar Croneborg Subscriptions from abroad are welcome. Pay- Mattsarve Gammelgarn ments (300 SEK) can be made to our bank ac- 620 16 LJUGARN count: 018-672557 Swedbank [email protected] Storgatan, S 293 00 Olofström, Sweden SWIFT: SWEDSESS Jan Nilsson IBAN no. SE9280000848060140108838 Smeberg 2 450 84 BULLAREN 0525-20972 Sveriges Mykologiska Förening [email protected] Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs Universitet Äldre nummer av Svensk Mykologisk Tidskrift Box 461 (inkl. -

45 Attraverso La Valle Vigezzo
Viaggio attraverso la Valle Vigezzo La Valle Vigezzo inizia a Masera, località poco oltre Domodossola. Il primo paese che si incontra risalendo la valle è Coimo, un piccolo centro rinomato per la produzione del pane nero di segale. Proseguendo si raggiunge Druogno, il primo comune nel verde altopiano dove sorge la Cappella dell’Addio, il luogo dove anticamente gli emigranti salutavano i parenti prima della partenza verso altri Paesi, in particolare verso il Nord Europa. Druogno SMS di Piancavallo 1 Prima di arrivare a Santa Maria Maggiore c’è il “Piano delle Lutte”, conosciuto come il luogo preferito per i ritrovi delle streghe. Santa Maria Maggiore è la capitale turistica e amministrativa della valle; si trova in un punto particolarmente incantevole, in un ampio pianoro circondato dalle belle montagne circostanti. La chiesa parrocchiale è dedicata alla Vergine Assunta e risale al XVIII secolo. Il campanile che la affianca è invece di epoca medievale. La chiesa è ad un’unica navata in stile corinzio e contiene pregevoli affreschi di pittori vigezzini come Lorenzo Peretti e Giuseppe Mattia Borgnis. La Parrocchiale Opere importanti di altri artisti della valle sono ospitate nella pinacoteca dell’Istituto di Belle Arti “Rossetti Valentini”. SMS di Piancavallo 2 Particolarmente interessante è la visita al Museo dello Spazzacamino. Il Museo è stato allestito nel 1983, all’interno di una bella costruzione, Villa Antonia, circondato da un parco nella parte centrale del paese. Nel Museo sono esposti i vari strumenti di lavoro degli spazzacamini, fotografie, scritti e testimonianze varie, materiale tutto legato a questa particolare attività. SMS di Piancavallo 3 Il lavoro dello spazzacamino e l’emigrazione dalla Valle Vigezzo verso città e paesi al di qua e al di là delle Alpi, è un fenomeno comune anche alla vicina Valle Cannobina. -
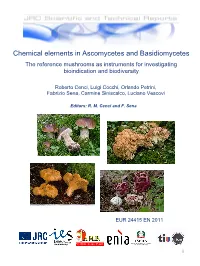
Chemical Elements in Ascomycetes and Basidiomycetes
Chemical elements in Ascomycetes and Basidiomycetes The reference mushrooms as instruments for investigating bioindication and biodiversity Roberto Cenci, Luigi Cocchi, Orlando Petrini, Fabrizio Sena, Carmine Siniscalco, Luciano Vescovi Editors: R. M. Cenci and F. Sena EUR 24415 EN 2011 1 The mission of the JRC-IES is to provide scientific-technical support to the European Union’s policies for the protection and sustainable development of the European and global environment. European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Via E.Fermi, 2749 I-21027 Ispra (VA) Italy Legal Notice Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server http://europa.eu/ JRC Catalogue number: LB-NA-24415-EN-C Editors: R. M. Cenci and F. Sena JRC65050 EUR 24415 EN ISBN 978-92-79-20395-4 ISSN 1018-5593 doi:10.2788/22228 Luxembourg: Publications Office of the European Union Translation: Dr. Luca Umidi © European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Printed in Italy 2 Attached to this document is a CD containing: • A PDF copy of this document • Information regarding the soil and mushroom sampling site locations • Analytical data (ca, 300,000) on total samples of soils and mushrooms analysed (ca, 10,000) • The descriptive statistics for all genera and species analysed • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in mushrooms • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in soils 3 Contact information: Address: Roberto M. -

2 the Numbers Behind Mushroom Biodiversity
15 2 The Numbers Behind Mushroom Biodiversity Anabela Martins Polytechnic Institute of Bragança, School of Agriculture (IPB-ESA), Portugal 2.1 Origin and Diversity of Fungi Fungi are difficult to preserve and fossilize and due to the poor preservation of most fungal structures, it has been difficult to interpret the fossil record of fungi. Hyphae, the vegetative bodies of fungi, bear few distinctive morphological characteristicss, and organisms as diverse as cyanobacteria, eukaryotic algal groups, and oomycetes can easily be mistaken for them (Taylor & Taylor 1993). Fossils provide minimum ages for divergences and genetic lineages can be much older than even the oldest fossil representative found. According to Berbee and Taylor (2010), molecular clocks (conversion of molecular changes into geological time) calibrated by fossils are the only available tools to estimate timing of evolutionary events in fossil‐poor groups, such as fungi. The arbuscular mycorrhizal symbiotic fungi from the division Glomeromycota, gen- erally accepted as the phylogenetic sister clade to the Ascomycota and Basidiomycota, have left the most ancient fossils in the Rhynie Chert of Aberdeenshire in the north of Scotland (400 million years old). The Glomeromycota and several other fungi have been found associated with the preserved tissues of early vascular plants (Taylor et al. 2004a). Fossil spores from these shallow marine sediments from the Ordovician that closely resemble Glomeromycota spores and finely branched hyphae arbuscules within plant cells were clearly preserved in cells of stems of a 400 Ma primitive land plant, Aglaophyton, from Rhynie chert 455–460 Ma in age (Redecker et al. 2000; Remy et al. 1994) and from roots from the Triassic (250–199 Ma) (Berbee & Taylor 2010; Stubblefield et al. -

OF UKRAINE © Chvikov V., Prylutskyi O
Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, 2020, №2 MYCOLOGY UDC 582.284 (477) Prylutskyi O. https://orcid.org/0000-0001-5730-517X Chvikov V. https://orcid.org/0000-0001-5297-3996 ANNOTATED CHECKLIST OF HYGROPHORACEAE (AGARICALES, BASIDIOMYCOTA) OF UKRAINE © Chvikov V., Prylutskyi O. V.N. Karazin Kharkiv National University [email protected] , [email protected] https://doi.org/10.34142/2708-5848.2020.22.2.01 Hygrophoraceae is a family within Agaricales, which comprises 26 genera and approximately 690 agaricoid species, including ectomycorrhizal, lichen-forming, bryophilous, humus and litter decomposing fungi. Some of these species especially those from genera Cuphophyllus, Hygrocybe, Neohygrocybe and Porpolomopsis are associated with natural grasslands and show extreme sensitivity to the presence of nitrogen-containing fertilizers in their substrate. This makes them indicative species of grasslands of high conservation value. While casual observations of Hygrophoraceae of Ukraine were incorporated in studies of agaricoid fungi as a whole, this family has never been in the focus of special research. Previously accumulated data on the diversity of Hygrophoraceae in Ukraine must be aggregated and revised. We have summarized all available data on the occurrences of Hygrophoraceae in Ukraine, including published papers, open databases, citizen science observations, and the previously unpublished original collection materials. Also, we provide an original description of the rare European species Haasiella venustissima (Fr.) Kotl. & Pouzar ex Chiaffi & Surault, which is reported for the first time from the territory of Ukraine. The resulting checklist of Hygrophoraceae of Ukraine includes 66 species. Leading genera are Hygrophorus (22 species), Hygrocybe (17) and Arrhenia (10); 5 species among them (Hygrocybe punicea, Hyrgocybe splendidissima, Neohygrocybe nitrata, Neohygrocybe ovina, Porpolomopsis calyptriformis) are threatened and according to “IUCN Red List” considered “Vulnerable”. -

Josiana Adelaide Vaz
Josiana Adelaide Vaz STUDY OF ANTIOXIDANT, ANTIPROLIFERATIVE AND APOPTOSIS-INDUCING PROPERTIES OF WILD MUSHROOMS FROM THE NORTHEAST OF PORTUGAL. ESTUDO DE PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES, ANTIPROLIFERATIVAS E INDUTORAS DE APOPTOSE DE COGUMELOS SILVESTRES DO NORDESTE DE PORTUGAL. Tese do 3º Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutoramento em Ciências Farmacêuticas–Bioquímica, apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Orientadora: Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (Professora Adjunta c/ Agregação do Instituto Politécnico de Bragança) Co- Orientadoras: Maria Helena Vasconcelos Meehan (Professora Auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto) Anabela Rodrigues Lourenço Martins (Professora Adjunta do Instituto Politécnico de Bragança) July, 2012 ACCORDING TO CURRENT LEGISLATION, ANY COPYING, PUBLICATION, OR USE OF THIS THESIS OR PARTS THEREOF SHALL NOT BE ALLOWED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. ii FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO STUDY OF ANTIOXIDANT, ANTIPROLIFERATIVE AND APOPTOSIS-INDUCING PROPERTIES OF WILD MUSHROOMS FROM THE NORTHEAST OF PORTUGAL. Josiana Adelaide Vaz iii The candidate performed the experimental work with a doctoral fellowship (SFRH/BD/43653/2008) supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT), which also participated with grants to attend international meetings and for the graphical execution of this thesis. The Faculty of Pharmacy of the University of Porto (FFUP) (Portugal), Institute of Molecular Pathology and Immunology (IPATIMUP) (Portugal), Mountain Research Center (CIMO) (Portugal) and Center of Medicinal Chemistry- University of Porto (CEQUIMED-UP) provided the facilities and/or logistical supports. This work was also supported by the research project PTDC/AGR- ALI/110062/2009, financed by FCT and COMPETE/QREN/EU. Cover – photos kindly supplied by Juan Antonio Sanchez Rodríguez. -

Impressions of the Art at the Panama-Pacific Exposition
W m it-: l^t:'^,l:^l "vP^' "^/^m^ c.y ^^ J ••>' /'..^./'*. '^^j.^ '^o.^-?•^-o^ oV'^^ia*- ^^&^ ^^m^^^ 4 o »\y X'-^-^v V'^-'.*^ ;* . V 'o. *.t:t'' a 1-^ y^j,^^- "t. -n^^o^ », < O •' T' o-) .^^ <S^. '..o' * ^^ ^L'A y ... -. v.^ .S^-^. '^.^W/ ^-'^ " 4 ir^ -fL 'bV •a.^ O -'^Wi'^^s* ^0 ,0' ^5, A." -^ ^/v'^v %5<^"/ V^v' %/-^£^^'>^^ V^^.^' .* «0 < o -^v^O^ »- '^l*!^' •^i'^'^ v^ '^Sfe' '^^^° .. M 'bv .„c^^ ^*>#" J>^^ .^''^^ ^'•"^'^- '-^^^° ^'" ,,.^^ "\ ''^: ^^'\ S . 'WWS .J' . .-v'.v . X'2 *'t:t' .'v <^> .^ ^ ^.>.^ o 4> 5°. 4^°^ V 1. O 5 " • A v^^ <. /.. :. '-^0^ 1^ * O B O ° ^.^ o^.i^';%'°""V\...^"--:o^;s..,'v^-\/lO* ,= v^^ .*'% 0^ v;^ •^ ^'T.s* A <^ .^" A^ 'is •' .^^ % -J." . <>^ ^' "^"^ *- <fi '' i\^^ A"' ' . • s 4 > Cj. o • » «U O C 4- <K ,0 ^ '^. A** v^- '•''" *' = ^^ . • ** .-. '»- ^^ A" * ^°-^^. ^-1°^ .-iq* * "q,*^^'\o^ <^. o.^' Oj," <?>„ c'* V- 0^ Off '^o^ ^bV-" •^o^ ^^-^^^^ r^0 ^V^ v-^ 0° t ^ .4,^^ .-s.'^ ^ta V,. ".. IMPRESSIONS OF THE ART AT THE PANAMA-PACIFIC EXPOSITION OTHER WORKS BY CHRISTIAN BRIXTON, M.A.. Litt. D. Modern Artists. The Baker ami Taylor Coinpanv. New York, 1!I(IS Catalogue of Paintings by Ignacio Zi'loaga. The Hispanic Society of Amerifa, New ^'ork, 190!l AuSSTELLUNG AmERIKANISCHER KuNST. Konigliche Akademie tier Kiinste zu Berlin, IIUO Die Entwicklung der Amerikanischen Malerei. F. Bruekmann. Miinehen-Berlin. litlc Masterpieces of American Painting. The Berlin Photographic Company, New York ami Berlin, I'JIO Catalogue of Sculpture by Prince Paul Troubetzkoy. The American Numismatic Society, New York, 1911 Walter Greaves, Pupil of Whistler. Cottier and Company, New York, 191i The Scandinavian Exhibition. -

Lettera Dei Musei N 55 | Marzo 2017
LETTERA DEI MUSEI N 55 | MARZO 2017 SPECIALE DA NON PERDERE NOVITÀ I SACRI MONTI L'EMOZIONE CUPOLA DEL PIEMONTE DEI COLORI DI SAN GAUDENZIO NELL'ARTE A NOVARA Poste Italiane Spedizione in A.P. 45%_Art.2 Comma 20/B Legge 662/96 _ D.C./D.C.I. Torino _ n° XLVII/Anno XVI LETTERA DEI MUSEI n° 52/2017 _ n° XLVII/Anno Torino 662/96 _ D.C./D.C.I. 45%_Art.2 20/B Legge Comma Spedizione in A.P. Italiane Poste 2 LETTERA DEI MUSEI [ N 55 ] Marzo 2017 3 Editoriale IN QUESTO NUMERO EDITORIALE N 55 MARZO 2017 4 Ci siamo proposti di contribuire a i fattori chiave e un Vademecum MUSEI A MISURA dare voce alla capacità dei Musei per i Musei, pensato anche di far parte della vita delle famiglie nella versione per le famiglie. PENSATI PER VOI DI FAMIGLIE e dei bambini fin dai primi passi e I Musei che raggiungeranno i SCONTI E VANTAGGI PER GLI ABBONATI a creare le condizioni per renderli requisiti indicati dal Decalogo E BAMBINI sempre più “casa”: Musei che e accoglieranno le famiglie con siano percepiti dalla collettività il Passaporto Culturale in tutta la Regione come luoghi “Family and Kids (scaricabile anche dal sito www. friendly”, risorsa attiva di una naticonlacultura.it) comunità educante. potranno avvalersi della Nati con la Cultura è il progetto Ma quali caratteristiche certificazione “Nati con concepito all’Ospedale Sant’Anna deve avere un museo per la Cultura”. di Torino dalla Fondazione attrarre un pubblico sempre 20 Medicina a Misura di Donna più ampio ed essere adatto Da fine marzo scopri sul sito nel 2014, in collaborazione a ospitare anche famiglie www.abbonamentomusei.it il SPECIALE con Palazzo Madama: a ogni con figli piccoli? Perché le Decalogo dei Musei Family bambino nato nell’ospedale, con famiglie con bambini da 0 a and kids frendly.