01 Copertina Tesi Ver 02-1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

La Via Appia
LA VIA APPIA Storia Alla fine del IV secolo a.C. Roma era padrona di gran parte della Penisola e una delle grandi potenze del Mediterraneo, solo pochi gruppi etnici, a sud delle Alpi, restavano da soggiogare. L'Urbe stessa stava cambiando il suo volto tradizionale assumendo quello di una capitale, ricca di opere pubbliche erette dai suoi generali vittoriosi. Il Foro, il Campidoglio, erano luoghi dove si ostentava la potenza crescente della città. Solo la nazione Sannita sfidava ancora l'egemonia di Roma da sud; da Paestum all'Apulia la Lega Sannitica minacciava di prendere Capua, non lontana dai confini del Lazio. La Via Appia nacque in questo contesto, come una via militare che consentiva di accelerare le comunicazioni coi confini meridionali del territorio conquistato. La strada fu poi estesa man mano che altri territori cadevano sotto il dominio di Roma. Appio Claudio Cieco, il console, fu colui che rese celebre la funzione di censore per le grandi imprese di interesse pubblico da lui realizzate, ma il suo nome fu reso famoso dalla Via Appia che gli sopravvisse. Nel 1993 la Via Appia compie 2305 anni, Appio fece tracciare la strada all'epoca delle guerre contro i Sanniti, nel 312 a.C., da Roma a Capua, per una distanza di 124 miglia romane. Appio impiegò anche i suoi capitali personali laddove le tesorerie dello stato erano insufficienti. Al primo posto fra tutte le strade di Roma c'era la Via Appia, a suo tempo la più lunga, la più bella, la più imponente via che fosse mai stata tracciata in alcuna parte del mondo, al punto che i romani la chiamarono "Regina di tutte le vie". -

Mario Pagano Continuità Insediativa Delle Ville in Campania Fra Tarda Antichità E Alto Medioevo
Mario Pagano Continuità insediativa delle ville in Campania fra tarda antichità e alto medioevo [A stampa in La Campania fra tarda antichità e alto medioevo. Ricerche di archeologia del territorio . Atti della Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno 2008, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, Cimitile, Tavolario editore, 2009 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, 1), pp. 9-21 @ degli autori e dell’editore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]. 9 MARIO PAGANO CONTINUITÀ INSEDIATIVA DELLE VILLE NELLA CAMPANIA FRA TARDA ANTICHITÀ E ALTO MEDIOEVO Potrebbe sembrare straordinario che, su un argomento così centrale per la storia di una regione importante come la Campania nel periodo che si esamina, in particolare per la sua rilevanza rispetto all’approvvigionamento di Roma (accresciuta dopo la fondazione di Costantinopoli), e come cerniera col Mediterraneo e in particolare con Costantinopoli, l’Africa, l’Egitto e la Terra Santa, i dati siano piuttosto scarsi. Eppure, pochissimi sono i siti delle ville romane in Campania scientificamente indagati e, anche questi, solo molto parzialmente; una gran quantità di scavi e scoperte occasionali sono inediti o solo insufficientemente pubblicati; assai carenti anche le ricognizioni di superficie; pochi gli studi specifici, e limitati a zone non molto estese. Certo, negli ultimi anni la situazione comincia in qualche misura a mutare, grazie anche ai maggiori investimenti economici degli ultimi anni, ai ritrovamenti avvenuti durante la realizzazione di grandi opere pubbliche e alla continua espansione edilizia che hanno investito la Campania, e alla importante e lodevole iniziativa, che assume già notevole rilievo per il Casertano e il Beneventano, della prof.ssa Stefania Quilici Gigli, che ha permesso la pubblicazione di alcuni fogli della Carta archeologica della Campania riguardanti in particolare la zona di Capua, la valle del Volturno e la Valle Caudina e, prossimamente, quella Telesina. -

V2017-Sinuessa.Pdf
SINUESSA, UN APPRODO SOMMERSO DI EPOCA ROMANA Archeologia, geomorfologia costiera, strategie sostenibili di valorizzazione Monografia a cura di Micla Pennetta e Alfredo Trocciola 2017 ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ISBN: 978-88-8286-340-1 Revisione editoriale: Giuliano Ghisu Copertina: Flavio Miglietta Foto in copertina: immagine del fondo marino, acquisita con indagini side-scan sonar, che mostra le “Pilae di Sinuessa” collocate in una vasta depressione di un banco tufaceo caratterizzato da una morfologia articolata SINUESSA, UN APPRODO SOMMERSO DI EPOCA ROMANA Archeologia, geomorfologia costiera, strategie sostenibili di valorizzazione A cura di Micla Pennetta e Alfredo Trocciola La monografia raccoglie i contribuiti di studi e ricerche condotti negli ultimi anni nell’area archeologica marina di Sinuessa nel golfo di Gaeta in Campania. Alla realizzazione del volume hanno contribuito diversi autori, specialisti in differenti discipline quali la geo- morfologia costiera, archeologia e beni culturali con la finalità di suggerire agli amministratori e stakeholder del litorale domitio strategie sostenibili per la valorizzazione dell’approdo sommerso di epoca romana. Presentazione di: Claudio Zucchelli Contributi di: Paolo Caputo, Sergio Cascella, Vera Corbelli, Veronica D’Ambrosio, Alberto De Bonis, Tiziana Di Luccio, Carlo Donadio, Carmine Minopoli, Angela Mormone, Vincenzo Morra, Raffaella Nappi, Micla Pennetta, Raffaele Pica, Monica Piochi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona, Rosario -

China and Italy: Routes of Culture, Valorisation and Management
N° 3 CHINA AND ITALY: ROUTES OF CULTURE, VALORISATION AND MANAGEMENT Edited by Heleni Porfyriou and Bing Yu Consiglio Nazionale delle Ricerche CHINA AND ITALY: ROUTES OF CULTURE, VALORISATION AND MANAGEMENT Edited by Heleni Porfyriou And Bing Yu This series of volumes comprises research outputs that have been achieved due to the financial contribution of the National Research Council of Italy (CNR) and the the Chinese Academy of Cultural Heritage (CACH) within the context of a Bilateral Agreement of Scientific and Technological Cooperation between these two Institutions. SCIENTIFIC EDITORIAL BOARD: Chai Xiaoming, Director of the Chinese Academy of Cultural Heritage - CACH Gilberto Corbellini, Director of the Department of Social and Human Sciences, Cultural Heritage of the National Research Council of Italy – CNR Dora Di Francesco, Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities – MiBACT, General Secretariat, Service II Luigi Scaroina, MiBACT, General Secretariat, Service II Maria Grazia Filetici, MiBACT, Colosseum Archaelogical Park Bing Yu, CACH Heleni Porfyriou, CNR ICVBC (Institute for the Conservation and Valorization of the Cultural Heritage) © Cnr Edizioni, 2018 P.le Aldo Moro 7 00185 Roma ISBN versione cartacea 978 88 8080 321 8 ISBN versione elettronica 978 88 8080 322 5 TABLE OF CONTENTS Foreword 5 Gilberto Corbellini ........................................................................................................................ 5 Chai Xiaoming ............................................................................................................................. -

A Reappraisal of Hannibal's Use of Elephants
0DJLVWHU(OHSKDQWRUXP$5HDSSUDLVDORI+DQQLEDO V 8VHRI(OHSKDQWV 0LFKDHO%&KDUOHV3HWHU5KRGDQ Classical World, Volume 100, Number 4, Summer 2007, pp. 363-389 (Article) 3XEOLVKHGE\-RKQV+RSNLQV8QLYHUVLW\3UHVV DOI: 10.1353/clw.2007.0054 For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/clw/summary/v100/100.4charles.html Access provided by University of Queensland (17 Sep 2015 03:29 GMT) 363 MAGISTER ELEPHANTORVM: A REAPPRAISAL OF HANNIBAL’S USE OF ELEPHANTS ABSTRACT: This article, which examines all the available evidence for Hannibal’s use of elephants in the Second Punic War, refutes the conten- tion that Hannibal was especially innovative in his tactical use of the beasts. In addition, greater reliance on elephants in Italy, particularly after his success at the Trebia, would have hindered Hannibal in his lengthy cam- paign against Rome. The article also contends that Hannibal’s use of massed elephants at Zama highlights the degree to which he was accustomed to take chances in the field, especially given his demonstrable familiarity with the fickle nature of elephants when used for military purposes. Over the years, much has been written about the Carthaginian general Hannibal and his use of elephants during the Second Punic War. 1 Outwardly, it might appear as if the topic were a closed one and that there is little new to add. Despite this, a recent article by Jacob Edwards has added something new—and indeed controversial— by arguing that Hannibal might have achieved much more success in Italy than he did if a greater number of his elephants had sur- vived the arduous trek across the Alps.2 Edwards also suggests that “Hannibal’s use of elephants is one of thwarted genius,”3 the impli- cation being that Hannibal had developed an almost unique grasp of the manner in which elephants could be used in warfare. -

Il Duovirato Nei Municipia Italici: Contributo Allo Studio Della Fase Finale Del Processo Di Municipalizzazione Nell’Italia Centrale E Meridionale
ARTÍCULOS Gerión. Revista de Historia Antigua ISSN: 0213-0181 https://dx.doi.org/10.5209/geri.74783 Il duovirato nei municipia italici: contributo allo studio della fase finale del processo di municipalizzazione nell’Italia centrale e meridionale Simone Sisani1 Recibido: 24 de junio de 2020 / Aceptado: 18 de noviembre Riassunto. Il contributo analizza in forma sistematica i casi noti di municipia retti da duoviri all’interno delle regiones augustee I-VII, con lo scopo di offrire una lettura in chiave strutturale della diffusione del duovirato municipale in area italica: l’analisi consente di formulare ipotesi sulle ragioni storiche del ritardo istituzionale manifestato da alcune aree della penisola, dove il processo di municipalizzazione giunge a pieno compimento soltanto a cavallo tra l’età cesariana e l’età augustea. Palabras clave: Cesare; duoviri; municipia; praefecturae; quattuorviri; Silla. [en] The Duovirate in Italian Municipia: Contribution to the Study of the Final Phase of the Municipalization Process in Central and Southern Italy Abstract. The contribution analyzes systematically all known cases of municipia governed by duoviri within the Augustan regiones I-VII, aiming at offering a structural reading of the diffusion of municipal duovirate in the Italic area: the analysis allows to formulate hypothesis on the historical reasons for the institutional delay manifested by some areas of the peninsula, where the process of municipalization is fully accomplished only between the Caesarian and the Augustan ages. Key words: Caesar; Duoviri; Municipia; Praefecturae; Quattuorviri; Sulla. Sommario: 1. Il duovirato come esito del riassetto istituzionale di municipia quattuorvirali. 2. Il duovirato come esito della promozione a municipia di realtà vicane. -
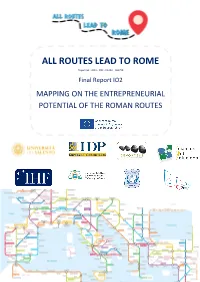
Download IO2 Final Report
ALL ROUTES LEAD TO ROME Project ref.: 2019 - IT02 - KA203 – 062798 Final Report IO2 MAPPING ON THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF THE ROMAN ROUTES a a a With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This document and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Content Content..................................................................................................................................... 2 1. Introduction ...................................................................................................................... 6 1.1. Grounding: Secondary Research ................................................................................ 6 1.2. Involvement: Primary Research ................................................................................. 7 2. The Sample ....................................................................................................................... 8 2.1. Descriptives ............................................................................................................... 8 2.2. The Roman Routes Questionnaire ............................................................................ 11 2.3. Results ..................................................................................................................... 12 2.4. Conclusions ............................................................................................................ -
© in This Web Service Cambridge University
Cambridge University Press 978-1-107-01318-6 - Peasants, Citizens and Soldiers: Studies in the Demographic History of Roman Italy 225 BC–AD 100 Luuk De Ligt Index More information Index Abella, 310 Allifae, 310 Abellinum (Campania), 310 Alsium, 320 Abellinum Marsicum, 329 Altinum, 265, 289 Acelum, 298 Ameria, 315 Acerrae, 311 Amiternum, 323 Aceruntia, 334 Amitinum, 320 Acherusia, 334 Anagnia, 306 Aecae, 329 Ancona, 312 Aeclanum, 329 Angera, 265 Aegetium, 329 Angitia, 325 Aemilia, 264; viritane settlers, 81, 131; population Angulum, 324 in 28 bc, 195, 224 Anxa, 325 Aesernia, 324 Anxa (Callipolis), 330 aes equestre, 84 Anxanum, 325 aes hordiarium, 84 Antinum, 324 Aesis, 316 Antium, 260, 304 Affilae, 306 Antonine Plague, 2, 13 age at first marriage, 3, 144–9, 159, 166 Apama, 330 age groups, in Roman armies, 55–6, 83, 145, 166;in Appian, on background to Gracchan crisis, 158–9, Greek armies, 56–7; see also iuniores, seniores 164, 167–9, 178, 181, 192 Ager Brundisinus, 266 Aprusta, 334 Ager Caeretanus, 271 Apulia, confiscations after 201 bc, 131; viritane Ager Cosanus, 259, 267, 281; see also Albegna settlers, 81; decline of pre-Roman towns, 229, Valley Survey 262; evidence of population decline, 262–3; ager publicus, 158–9, 185–7 realignment of settlement system, 262; shape of Ager Tiburtinus, 272 urban network, 235–6; see also Brundisium agro-towns, 230, 266 Apulians, 68; anomalous ratio between horse Alba Fucens, 323 and foot in Polybius, 42, 67; manpower Alba Longa, 306 resources, 70 Alba Pompeia, 293 Aquae Statiellae, 293 Albegna Valley Survey, -

A Study of the Topography and Municipal History of Praeneste by Ralph Van Deman Magoffin
A Study Of The Topography And Municipal History Of Praeneste by Ralph Van Deman Magoffin A Study Of The Topography And Municipal History Of Praeneste by Ralph Van Deman Magoffin Produced by Juliet Sutherland, Wilelmina Malliere and the Online Distributed Proofreading Team. SERIES XXVI NOS. 9-10 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY STUDIES IN HISTORICAL AND POLITICAL SCIENCE Under the Direction of the Departments of History, Political Economy, and Political Science STUDY OF THE TOPOGRAPHY AND MUNICIPAL HISTORY OF PRAENESTE BY RALPH VAN DEMAN MAGOFFIN, A.B. Fellow in Latin. September, October, 1908 page 1 / 159 COPYRIGHT 1908 CONTENTS. CHAPTER I. THE TOPOGRAPHY OF PRAENESTE EXTENT OF THE DOMAIN OF PRAENESTE THE CITY, ITS WALLS AND GATES THE PORTA TRIUMPHALIS THE GATES THE WATER SUPPLY OF PRAENESTE THE TEMPLE OF FORTUNA PRIMIGENIA THE EPIGRAPHICAL TOPOGRAPHY OF PRAENESTE THE FORA THE SACRA VIA CHAPTER II. THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF PRAENESTE WAS PRAENESTE A MUNICIPIUM? PRAENESTE AS A COLONY THE DISTRIBUTION OF OFFICES THE REGULATIONS ABOUT OFFICIALS THE QUINQUENNALES AN ALPHABETICAL LIST OF THE MUNICIPAL OFFICERS OF PRAENESTE A CHRONOLOGICAL LIST OF THE MUNICIPAL OFFICERS OF PRAENESTE page 2 / 159 1. BEFORE PRAENESTE WAS A COLONY 2. AFTER PRAENESTE WAS A COLONY PREFACE. This study is the first of a series of studies already in progress, in which the author hopes to make some contributions to the history of the towns of the early Latin League, from the topographical and epigraphical points of view. The author takes this opportunity to thank Dr. Kirby Flower Smith, Head of the Department of Latin, at whose suggestion this study was begun, and under whose supervision and with whose hearty assistance its revision was completed. -

Caserta and Matese
Generale_INGL 25-03-2008 13:28 Pagina 122 Caserta and Matese 122 123 This is the area referred to as “Campania Felix ” by ancient populations due to its privileged position i and the fertility of its soil. Irrigated by the Volturno and favoured by a mild climate, the province extends from the sea to the Apennines, alternating between lush vegetation and places of great historic and cultural interest. The vast plains of the Caserta area Ente Provinciale per il open onto the sea and host one of the most famous Turismo di Caserta and widely visited monuments of the Region: the Palazzo Reale Royal Palace (Reggia) of Caserta. tel. 0823 321137 www.eptcaserta.it Santa Maria Capua Vetere, Capua and Sessa Aurunca, are also of historic and archaeological Ente Parco del Matese interest, all concentrated in the area of Caserta via Sannitica known as Terra di Lavoro. The Domitian shore is Piedimonte Matese the province’s coastline, an area rich with pine tel. 0823 917232 stands, wide sandy beaches and famous bathing Comunità Montana establishments. Monte Santa Croce Inland, the massif of Matese offers marvellous via Roma 30 uncontaminated nature and villages where art and Roccamonfina popular traditions are still strongly felt; one of the tel. 0823 921276 least contaminated areas of Italy. Calvi Vecchia Scavi archeologici di Cales strada statale Casilina tel. 0823 652533 Capua Museo Provinciale Campano via Roma 68 tel. 0823 961402 Santa Maria Capua Vetere Museo Archeologico dell’antica Capua via Roberto d’Angiò 48 tel. 0823 844206 Caserta Reggia e Parco via Douhet 22 tel. -

Itinera Tiberi
1 Princeton/Stanford Working Papers in Classics Itinera Tiberi Version 1.0 March 2009 Edward Champlin Princeton University Abstract: Intended as a guide for quick reference, this paper tabulates all of the known movements of the princeps Tiberius from birth to death. © Edward [email protected] 2 Itinera Tiberi [] = [age before November 16th of that year] S = Suetonius, Tiberius; D = Cassius Dio; T = Tacitus, Annales; VP = Velleius Paterculus BC 42 Rome Palatine: born S 5, D 57. 18. 2, Fer Cum., FAnt., AFA 16 Nov. 40 Praeneste after L. Antonius capitulates at Perusia, parents flee to [1] Naples Sicily Achaia S 4. 2-3, 6. 1-3, VP 2. 75. 3 Sparta S 6. 1 39 Rome returns after amnesty, S 4.3 [2] 38 Rome mother Livia marries Octavian, VP 2. 94. 1, FVerul 17 Jan. [3] 32 Rome Rostra: age 9 (33/32) eulogizes father, S 6. 4 [9] 29 Rome in Octavian’s Actium triumph, 13-15 Aug. [12] astici ludi, Circus: Troy games, S 6. 5, D 51. 22. 4 27 Rome toga virilis, FPraen. 24 Apr. [14] [Torelli 1982: 85, argues for 23 Apr.] 26 Spain military tribune, Cantabrian War (or not till 25), S 9. 1 [15] 25 Spain military tribune, Cantabrian War, S 9. 1, S 42. 1 [16] 24 Rome right to stand for office 5 years early; elected quaestor, D 53. 28. 3 [17] T 3. 29. 1, S 8; ?AP 9. 219 (Diodorus) 23 Rome quaestor, VP 2. 94. 1, and cura annonae VP 2. 94. 1, S. 8, ?AP 9.