L'italia Altrove
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'italia Altrove
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archivio istituzionale della ricerca - Università di Palermo UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO DIPARTIMENTO DI CULTURE E SOCIETÀ Dottorato di Ricerca Internazionale in STUDI CULTURALI EUROPEI – XXIX CICLO (Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/01) L’ITALIA ALTROVE Una lettura postcoloniale delle riviste geografiche italiane (1882-1942) TUTOR Prof.ssa Giulia de Spuches TESI DI CO-TUTOR Francesca Genduso Prof. Matteo Meschiari COORDINATORE DEL DOTTORATO Chiar.mo Prof. Michele Cometa A.A 2016/2017 Indice Introduzione ..........................................................................................................................3 Capitolo 1 Il postcoloniale come pratica e condizione contemporanea ..............................13 1.1 Ambiguità e punti di forza di un pensiero frammentario ..........................................13 1.2 Poter ridire di nuovo “Io”: il pensiero sulla decolonizzazione ..................................23 1.3 Il “post” come metafora: la critica postcoloniale ......................................................42 1.4 Temporalità dislocate ................................................................................................61 Capitolo 2 Il qui e l’altrove: il caso italiano ........................................................................75 2.1 L’Italia e il colonialismo: tra un passato rimosso e una prospettiva in divenire .......75 2.2 L’impresa coloniale: la costruzione del sé attraverso la -

Valutazione Tattica Della Battaglia
La campagna d’Africa: Libia L’Italia in guerra Breve riassunto Alla fine degli anni Trenta le forze armate italiane erano in gravi condizioni: le armi erano scarse e di vecchio tipo, l’Aeronautica usava apparecchi antiquati, la Marina era indifendibile e mancante di portaerei. Per giustificare questa ultima mancanza Mussolini aveva affermato che la stessa Italia era da considerarsi una gigantesca portaerei. Il paese, durante le sfilate, poteva mostrare al mondo solo i famosi fantomatici «otto milioni di baionette». Le guerre di Etiopia e di Spagna avevano dimostrato i limiti dell’Italia, ma nessuna riforma sostanziale era stata apportata per modernizzare la struttura militare. La campagna d’Albania, risultata vittoriosa, aveva elevato notevolmente il morale, ma non coglieva l’autentica situazione militare. In realtà ben pochi sapevano che si era rivelata una tragedia. Lo sbarco si era svolto in una confusione indescrivibile, tra urla e sconquassi, con gente finita in mare con il rischio di annegare, navi impossibilitate ad attraccare perché non era stata calcolata la profondità dei fondali. Per questo i soldati furono trasportati a terra solo grazie a barconi richiesti ai pescatori locali. Scriveva Filippo Anfuso, allora braccio destro del ministro degli Affari Esteri Galeazzo Ciano: «Se gli albanesi avessero avuto anche solo una brigata di pompieri bene armati, avrebbero potuto ributtarci nell’Adriatico». Le tradizioni belliche non erano delle migliori, ma si inneggiavano a eroi anche i comandanti con più sconfitte a carico. I generali italiani erano quasi tutti da pensione (tra i più giovani c’era Ugo Cavallero con sessanta anni), derelitti della Prima guerra mondiale, per la maggiorwww.qattara.it parte fino ad allora nell’anonimato; occorreranno le prime sconfitte per renderli «noti» alle cronache dei giornali. -

L'apporto Degli Ascari Eritrei Nella Guerra Italo – Turca
ALBERTO CAMINITI L’APPORTO DEGLI ASCARI ERITREI NELLA GUERRA ITALO – TURCA ( 1911-1912 ) STORIA POSTALE E FILATELIA TEMATICA PREMESSA. Quando lo Stato Maggiore di Roma s’avvide che le truppe inviate in Tripolitania ed in Cirenaica non erano sufficienti per espandere la conquista dalle coste verso l’interno, fu ordinato l’invio di ingenti rinforzi dalla madrepatria in Libia. Poi qualche mente più sveglia, a Roma, suggerì di far confluire nel Nordafrica alcuni battaglioni di ascari eritrei, in quanto già addestrati ad operazioni di guerriglia, agili nei movimenti sul campo e pratici di scontri in zone desertiche. Il 1912 vide quindi l’intervento di alcuni nostri Battaglioni eritrei. Si provvide : Alla costituzione di quattro nuovi battaglioni eritrei, numerati dal V all’ VIII ( per tradizione si usavano i numeri romani ). Essi alternandosi, giunsero e combatterono in Libia già a partire dal febbraio 1912. venne immediatamente inviato a Tripoli un primo battaglione ( magg. Ernesto De Marchi ) composto da 4 compagnie, ognuna prelevata da ciascuno dei quattro battaglioni preesistenti. Fu denominato V Battaglione Ascari. Non si poteva completamente indebolire la guarnigione della primigenia colonia africana, su cui gravava – dopo Adua – la costante minaccia d’invasione abissina, mentre i nuovi coscritti si stavano addestrando. Inoltre, a parte lo Squadrone di cavalleria Savari, di cui appresso faremo cenno, vennero arruolati ( Ordinanza del 27.2.1912 ) indigeni libici appartenenti ad alcune tribù locali non dimostratesi finora a noi ostili, con cui si formarono tre bande di irregolari arabi per complessivi 600 armati, che presero il nome dalle rispettive etnie d’origine ( del Garian, del Sahel, e di Tarhuna ). -

Italo-German Order of Battle, North Africa, 24 May 1942
Italo-German Order of Battle North Africa 24 May 1942 Superior Command: General Ettore Bastico Superior Artillery Command: General Ettore Manc di Mores 8th Raggruppamento Army Artillery (decentralized) 152mm/37 Guns 152mm/13 Howitzers 149mm/40 Guns 149mm/28 Howitzers 37th Raggruppamento (20mm AA Guns) 50th Positional AA Guns (20mm) 51st Positional AA Guns (20mm) Superior Engineer Command: General Luigi Grosso 2nd Special Engineer Raggruppamento (Labor troops?) 7th Special Engineer Raggruppamento 31st Assault Engineerse (Guastatori)1 North Africa Intendancy: Colonel Vittorio Palma (Service and Administrative Corps) Units Directly Assigned to Superior Command 133rd Littorio Armored Division 133rd Medium Armored Regiment 2 Battalions M Tanks 12th Motorized Bersaglieri Regiment (3 Bns) 133rd Motorized Artillery Regiment 1 75mm/27 gun Battalion 33rd Engineer Battalion 25th Bologna Infantry Division 39th Infantry Regiment (2 Bns) 40th Infantry Regiment (2 Bns) 205th Artillery Regiment 1 Battalion (100mm/17 Guns) 3 Battalions (75mm/27 Guns) Support Units Raggruppamento Giovani Fascisti 2 Battalions 4th Granatieri AT Battalion Raggruppamento North Africa Celere2 11th Infantry Battalion 291st G.A.F. (Frontier) Artillery Battalion (77mm/27 Guns) 332nd G.A.F. (Frontier) Artillery Battalion (100mm/17 Guns) San Marco Marines (2 companies assigned to Hecker Group) Tripolitanian Command: Tripoli Proper 1 CCRR (Carabinier) Battalion 330th G.A.F. Machine Gun Battalion 340th G.A.F. Machine Gun Battalion 1 Assigned to 10th Corps. 2 Horse cavalry stationed in Tripoli). 1 350th G.A.F. Machine Gun Battalion 335th G.A.F. Artillery Battalion (149mm/12 Howitzers) 345th G.A.F. Artillery Battalion (120mm/25 Guns)3 353rd G.A.F. -

Annali N. 28/2020
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ANNALI N. 28/2020 © 2020 - Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto via Castelbarco, 7 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 438100 - fax 0464 423410 [email protected] www.museodellaguerra.it Direttore responsabile: Francesco Frizzera Redazione: Nicola Fontana (redattore), Anna Pisetti, Enrico Finazzer, Francesco Frizzera, Davide Zendri ISSN: 2723-9829 Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana INDICE STUDI E RICERCHE MARCO ROVINELLO, La ricezione della (nuova) storia militare a scuola: guerre risorgimentali e brigantaggio nei manuali delle superiori p. 3 ALBERTO BECHERELLI, L'occupazione italiana di Dubrovnik (1941-1943) p. 37 ENRICO FUSELLI, Catture, campi, lavoro e fughe di Guardie di Finanza prigioniere durante la Grande Guerra p. 87 FILIPPO CAPPELLANO, Strategia e tattica militare in rapporto all’evoluzione degli armamenti. Il caso italiano p. 109 MATTEO TOMASONI, Unità di destino e rivoluzione: genesi, ascesa e ʽcadutaʼ del fascismo spagnolo (1931-1937) p. 125 FONTI FEDERICO GODDI, Livio Picozzi a Cefalonia. Taccuino, 1948 p. 151 ARCHIVIO STORICO NICOLA FONTANA, Il fondo Tullio Marchetti p. 179 ARCHIVIO FOTOGRAFICO CAMILLO ZADRA, Il fondo fotografico Maurizio Rava p. 207 COLLEZIONI BEATRICE FALCUCCI, Le sale coloniali del Museo della Guerra di Rovereto: censimento e storia delle collezioni p. 255 ALBERTO MIORANDI, Forche, forconi, tridenti: attrezzi o armi? Riflessioni su alcuni esemplari delle collezioni del Museo della Guerra di Rovereto e di altre collezioni trentine p. 275 ANDREA BRAMBILLA, MARCO PISANI, Guerra chimica e maschere antigas dalle origini alla Prima guerra mondiale p. 311 ENRICO FINAZZER, DAVIDE ZENDRI, La collezione di autocarri militari italiani del Regio Esercito al Museo Storico Italiano della Guerra p. -

Studi E Documenti
STUDI E DOCUMENTI LA REPRESSIONE DELLA RESISTENZA ARABA IN CIRENAICA NEL 1930-31, NEI DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO GRAZIANI Il colonialismo italiano tra le due guerre mondiali è uno dei settori più trascurati della nostra storiografia contemporanea, malgrado il cre scente sviluppo degli studi sul fascismo e l’importanza che le conquiste africane ebbero per la propaganda e la politica di prestigio del regime '. Con una chiara scelta politica, gli istituti, i comitati e gli studiosi che dovrebbero essere interessati istituzionalmente a questi problemi preferiscono occuparsi del colonialismo itaMano dell’Ottocento, più di menticato ormai e quindi più adatto ad uno studio « scientifico » e neutro. Gli archivi del disciolto ministero dell’Africa italiana sono aperti con estrema avarizia e solo a pochi privilegiati ed anche il ministeriale e molto ufficiale Comitato per la documentazione dell’opera dell’Italia in Africa riserva al periodo fascista un’attenzione penosamente insuffi ciente, privilegiando la cronaca agiografica e gli studi settoriali e di menticando la ricostruzione critica e semplicemente la documentazione delle linee di sviluppo della politica coloniale italiana tra le due guerre mondiali. Il risultato di questo orientamento politico-culturale è che un avve nimento di grande portata come lo stroncamento della resistenza araba in Cirenaica nel 1930-31 (ma si potrebbero fare molti altri esempi) è oggi accessibile solo attraverso la pubblicistica nazional-fascista degli anni ’30 e dell’immediato dopoguerra1 2. Ci è stato tuttavia possibile affrontare questo argomento grazie al ritrovamento di un nutrito grup po di documenti che Graziani, vice-governatore della Cirenaica dal 1930 al 1934, raccolse in previsione di polemiche sul suo operato. -

Il Duce Guarda All'egitto
Capitolo ventunesimo Il duce guarda all’Egitto «L’invasione dell’Inghilterra è decisa, è in corso di ultimazione come preparativi e avverrà. Circa l’epoca può essere fra una settimana o un mese. Ebbene, il giorno in cui il primo plotone di soldati germanici toccherà il territorio inglese, voi simultaneamente attaccherete. Ancora una volta vi ripeto che non vi fisso limiti territoriali, non si tratta di puntare su Alessandria e nemmeno su Sollum. Vi chiedo solo di attaccare in forze gli inglesi che avete di fronte […]. Voi avete un’indubbia superiorità di effettivi e di mezzi e di morale. Cinque navi di linea sono pronte. Pensiamo di fare un ulteriore concentramento di aeroplani». Questo telegramma di Mussolini a Graziani, ultimo di una lunga serie, può considerarsi, per varie ragioni, l’ordine definitivo dì passare all’attacco sul fronte dell’Africa Settentrionale, attacco non previsto dai piani generali precedenti la guerra e intrapreso di controvoglia. Il messaggio viene spedito alle 12:30 del 19 agosto 1940, appena giunta a Roma la notizia che due giorni prima il ministro degli Esteri nazista Ribbentrop ha ammonito l’ambasciatore Alfieri a non turbare lo status quo nei Balcani (una specie di «giù le mani dalla Grecia») che Mussolini risentirà come una offesa personale, mentre Ciano commenta nel suo Diario: «Un alto là su tutta la linea». Quella di Mussolini non è tuttavia una decisione improvvisa, presa ab irato per reagire in qualche modo alla tracotanza tedesca. No, si tratta dello stesso equivoco iniziale che ha caratterizzato l’intera nostra campagna di guerra. Mussolini teme di arrivare troppo tardi, è convinto (proprio mentre i «giorni dell’aquila» stanno volgendo a favore degli Inglesi) che l’isola caparbia verrà invasa e dovrà comunque acconciarsi a chiedere la pace. -

Colonial Soldiers in Italian Counter-Insurgency Operations in Libya, 1922-321
British Journal for Military History, Volume 1, Issue 2, February 2015 Colonial Soldiers in Italian Counter-Insurgency Operations in Libya, 1922-321 NIR ARIELLI University of Leeds Email: [email protected] ABSTRACT The vast majority of the force employed by the Italians to crush local resistance in Tripolitania and Cyrenaica was composed of Libyans, Eritreans and Ethiopians. The article examines why the Italians came to rely so heavily on colonial soldiers. It highlights two key predicaments the Italians faced: how to contend with the social, economic and political repercussions that military recruitment for the counter-insurgency created in East Africa; and the extent to which they could depend on forces raised in Libya itself. Finally, the article offers an initial assessment of how the counter-insurgency exacerbated tensions between Libyans and East Africans. Introduction The insurgency in Iraq from 2003 onwards has created a renewed interest in the comparative study of counter-insurgencies. British, American and French counter- insurgency campaigns in the twentieth century have received most of the attention.2 Little has been said in this context about the lengthy, difficult and bloody attempts by the Italian government and its armed forces to subdue the colonies of Tripolitania and Cyrenaica which were later united and renamed Libya.3 Indeed, events in Libya predated the birth of the term 'counter-insurgency'. But like other colonial 'small wars' of the nineteenth and early twentieth century, the suppression in Libya fits into the definition of counter-insurgency used by David Kilcullen and others – 'all means adopted to suppress an insurgency'; in this case a 'resistance insurgency' in which the 1 The author wishes to thank Bruce Collins, Shane Doyle, Luigi Goglia and Brian Sullivan for their invaluable suggestions. -

Case Summaries and Sources
APPENDIX A Case Summaries and Sources In appendix A, all cases of extended-immediate deterrence between major powers are summarized for the period 1895–1985 (for their sum- mary listing, see table 3.2). The headings for each case include the year(s) of its commencement and termination and the names under which these cases are most commonly referred to in the historical liter- ature. Brief narrative summaries document all actions that are relevant for this study, that is, those that indicate military acts as operational- ized in chapter 3. Each case summary is completed with the biblio- graphic references for the consulted sources. For those surveys that provide case summaries, such as Brecher and Wilkenfeld (1997), the numbers (#) refer to the case numbers rather than to the relevant pages. Sources used for the case summaries are listed at the end of the references. The second section of this appendix identi‹es all other cases of general deterrence failure that did not escalate into immediate deter- rence between major powers. The summary for each case includes the starting and ending years of its occurrence, its conventional historical name, major actors and outcome (also listed in table 3.1), and the bib- liographic information used in its analysis from the relevant historical literature. The third section presents the cases of direct-immediate deterrence failure (see also table 3.3) between major powers, and the same information format is used as in the second section. 1. Extended-Immediate Deterrence Cases (Summaries and Sources) 1895–96 South African Crisis (Delagoa Bay and Jameson Raids) The Transvaal (Boer Republic), Cape Colony, and Rhodesia were viewed as parts of the British Empire and as such were not allowed to 183 184 Appendixes have independent foreign relations with other powers, although Eng- land did not interfere in their internal affairs. -
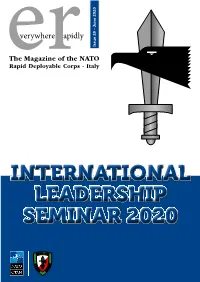
June 2020 Issue 29
Issue 29 - June 2020 Issue 29 The Magazine of the NATO Rapid Deployable Corps - Italy INTERNATIONAL LEADERSHIP SEMINAR 2020 #WEARENATO / 1 NATO Rapid Deployable Corps - Italy Ubique Celere CONTENTS LEADERSHIP IN VARIOUS FORMS Page 4 Major Stuart GIRLING, British Army ESA PROJECT FOR SPACE COLONIZATION Page 6 1 Major Andrea TROVATO, Italian Army SO DIFFERENT, SO EQUAL. Page 9 2 LEADERSHIP IN COMPARISON: ROMMEL A BOLD ‘MODERNIST PAINTER’, MONTGOMERY A ‘PAINSTAKING SEVENTEENTH-CENTURY MINIMALIST’. Major Giorgio CULASSO, Italian Army /NRDCItaly LEADERSHIP, THE ABILITY TO NOT Page 15 3 BE PREDICTABLE, UNDERSTAND CHANGES AND FIND SOLUTIONS AIMED AT ACHIEVING THE ASSIGNED TARGET @NRDCITA Col. Michele MASTRONARDI, Italian Army NRDC ITA AMEDEO GUILLET. Page 18 4 A DASHING CAVALRY OFFICER, GUERRILLA LEADER IN NRDC-Italy ITALIAN EAST AFRICA AND LOYAL DIPLOMAT OF THE FIRST REPUBLIC AFTER THE WAR. Lt. Col. Andrea MARI, Italian Army Everywhere Rapidly is the authorized of- ficial publication of the NATO Rapid De- ployable Corps, Italy. All editorial content LEADERS IN MUSIC. Page 22 of Everywhere Rapidly is coordinated, for publication, by the Public Affairs Office. 5 WHEN THE CONDUCTOR IS “A WOMAN” Lt. Col. Paola GORI, Italian Army The contents of Everywhere Rapidly are not necessarily the official views of, or endorsed by the North Atlantic Trea- CADORNA: A LEADER WITHOUT LEADERSHIP? Page 25 ty Organization and the Nations thereby 6 A CONTROVERSIAL ITALIAN GENERAL. represented. All intellectual property ri- ghts, including copyright in the content Lt. Col. Marco CAGNAZZO, Italian Army displayed on Everywhere Rapidly, belong to their respective owners. GIOVANNI MESSE, Page 28 Printed by: Grafica Olona 7 THE LAST FIELD MARSHAL OF ITALY Lt. -
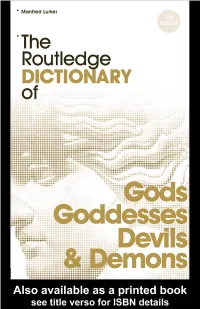
The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons
The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons From classical Greek and Roman mythology to the gods of Eastern Europe and Mesopotamia; from Nordic giants to Islamic jinns and Egyptian monsters, this classic dictionary is packed with descriptions of the figures most worshipped and feared around the world and across time. Fully cross-referenced and with over 100 illustrations, it also features two handy appendices listing the functions and attributes shared by these deities and demons. Covering over 1800 of the most important gods and demons from around the world, this is the essential resource for anyone interested in comparative religion and the mythology of the ancient and contemporary worlds. Manfred Lurker was, from 1968 to 1980, editor of the Bibliography of Symbolism, Iconography and Mythology. He has published widely on symbolism and the history of religion. The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons Manfred Lurker First published in German in 1984 as Lexicon der Götter und Dämonen by Alfred Krämer Verlag, Stuttgart This translation first published in 1987 by Routledge & Kegan Paul Ltd This reissue published 2004 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 29 West 35th Street, New York, NY 10001 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. “To purchase your own copy of this or any of Taylor & Francis or Routledge’s collection of thousands of eBooks please go to www.eBookstore.tandf.co.uk.” © Routledge & Kegan Paul, 1987 All rights reserved. -

URBS Giugno 2012
Giugno 2012 7.qxp:Layout 1 5-07-2012 13:02 Pagina 1 www.accademiaurbense.it SILVA ET FLUMEN Poste Italiane s.p.a. TRIMESTRALE DELL’ACCADEMIA URBENSE DI OVADA Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 / 02 / 2004 n° 46) ANNO XXV - N° 2 GIUGNO 2012 art. 1, comma 1, DCB/AL Capriata gli scavi archeologici di S. Nicolao Antonio Rebbora (1815 - 1861) Michele Oddini e la nascita di Colleferro Trionzo di Rocca G. tra storia e leggenda Violenza squadrista a Campo Ligure Carlo Gorzio pittore monferrino 1762-94 La Madonna della Salute ad Ovada Da Bandita di Cassinelle a Marsiglia a fare la balia Ubaldo Arata e il Cinema Italiano anni ‘30 Pupi Mazzucco una vita per lo spettacolo Torino, il Castello del Valentino si specchia nel Po Giugno 2012 7.qxp:Layout 1 12-07-2012 8:45 Pagina 2 www.accademiaurbense.it ... per non essere sommersi dai rifiuti bisogna riciclare... ... per riciclare bisogna fare la Raccolta Differenziata... AIUTACI AD ARGINARE L’AVANZATA DEI RIFIUTI... RICICLA!!! ORARIO CENTRO DI RACCOLTA UTILIZZA IL SERVIZIO GRATUITO DI OVADA PORTA A PORTA PER I RIFIUTI STRADA REBBA 2 INGOMBRANTI! Lunedì 08,30-12,00/14,00-17,00 Martedì 09,00-12,00 CHIAMA IL Mercoledì 08,30-12,00/14,00-17,00 Giovedì 09,00-12,00 E PRENOTA IL TUO RITIRO! Venerdì 08,30-12,00/14,00-17,00 RICORDA CHE POSSIAMO RITIRARE Sabato 09,00-12,00 GRATUITAMENTE FINO AD UN MASSIMO DI N° 3 PEZZI ORARIO PIATTAFORMA IMPRESE A PRENOTAZIONE! Lunedì 17,00-18,00 Martedì 08,00-09,00 Mercoledì 17,00-18,00 Non differenziare Giovedì 08,00-09,00 nuoce gravemente Venerdì 17-00,18,00 alla salute Sabato 08,00-09,00 ECONET SRL - SEDE LEGALE: Piazza Levi, 12 - 15011 ACQUI TERME (AL) SEDE AMMINISTRATIVA: Strada Rebba, 2 - 15076 OVADA (AL) TEL.