Annali N. 28/2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Downloaded from Brill.Com10/06/2021 09:49:05AM Via Free Access
Fascism 2 (2013) 161–182 brill.com/fasc ‘We Will Never Leave.’ The Reale Accademia d’Italia and the Invention of a Fascist Africanism Emanuel Rota University of Illinois at Urbana-Champaign [email protected] Abstract At the beginning of November 1938 the Reale Accademia d’Italia, the official cultural institution of the Italian Fascist regime, organized a conference on Africa. Mussolini himself had chosen the theme for the conference and major Italian political figures, such as De Vecchi and Balbo, delivered papers, together with French, English and German politicians and scholars. The con- ference, organized in the same year of Hitler’s visit to Italy and of the introduction of the new racial laws, could have offered the cultural justification for a foreign policy alternative to the German turn taken by the regime. Only Mussolini’s last minute decision not to attend trans- formed the Convegno Volta on Africa from a potential alternative foreign policy into a forum where the dissenting voices within the regime voiced their opposition to German style racism. Keywords Italian Fascism; racism; anti-Semitism; Reale Accademia d’Italia; Fascist colonialism; Fascist Africanism The time of politics and the time of cultural production run at different speeds. In authoritarian and totalitarian regimes, where the political power can dic- tate the cultural agenda, the lack of synchronicity that characterizes these two different times can be a source of embarrassment for the political authorities, a space where the sudden turns of politics can reveal themselves as such. For this reason, the cultural events that a regime organizes to systematize its ideol- ogy can be invaluable ‘time machines’ for historians, who can look a these events to challenge the time frame produced by political authorities to legiti- mize their choices. -
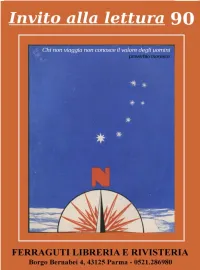
Fn000030.Pdf
1) Viaggi ed esplorazioni- 205 2) Collana Paravia Viaggi- 226 3)Collana Alpes Viaggi- 240 4) Ebraismo- 390 5) Colonialismo Fascista- 513 6) L'Illustrazione Italiana- 522 7) Storia- 546 8) Fascismo- 609 9) Spionaggio- 626 10) Letteratura italiana- 635 11) Letteratura straniera- 648 12) Il Corriere dei Piccoli-658 13) Libri per Ragazzi-693 14) Sport- 701 15) Arte-727 Le immagini di tutti i libri proposti in questo catalogo ( e molti altri) sono disponibili nella sezione RICERCA del sito www.ferraguti.it , continuamente aggiornato, che vi invitiamo a visitare. Preghiamo i gentili clienti di comunicarci l'indirizzo email, al fine di poter inviare, qualora lo gradissero, comunicazioni e cataloghi intermedi rispetto alle "classiche" pubblicazioni trimestrali. Siamo sempre interessati all'acquisto di intere biblioteche e partite o blocchi di libri, riviste e stampe d'epoca, saremo grati a chi ci fornirà opportune segnalazioni. FERRAGUTI SERVICE s.a.s. di Ferraguti Ivo & C. Borgo Bernabei 4 - 43125 Parma Tel. e Fax 0521-286980- [email protected] [email protected] P. IVA 01779470341- C.C.I.A.A. PR Reg. Ditte n. 177878 Iscrizione Tribunale di Parma n. 22291 Conto Corrente Postale n. 11724432 Catalogo numero 90- I semestre 2013- Gennaio,Febbraio, Marzo 2013 Editore: Ferraguti Service s.a.s. (Responsabile Ivo Ferraguti) Tipografie Riunite Donati - Borgo Santa Chiara 6- 43125 Parma 2 Albertini Gianni, ALLA RICERCA DEI NAUFRAGHI DELL'"ITALIA". mille kilometri sulla banchisa., Libreria d'Italia, Milano, 1929, 8o, brossura e sovracoperta., bs.,seconda ediz., pp. 165. La spedizione Nobile. Con numerose e bellissime foto. € 31,00 3 Albieri Adele, CRISTOFORO COLOMBO alla scoperta dell'America., Paravia G.B. -

L'italia Altrove
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archivio istituzionale della ricerca - Università di Palermo UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO DIPARTIMENTO DI CULTURE E SOCIETÀ Dottorato di Ricerca Internazionale in STUDI CULTURALI EUROPEI – XXIX CICLO (Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/01) L’ITALIA ALTROVE Una lettura postcoloniale delle riviste geografiche italiane (1882-1942) TUTOR Prof.ssa Giulia de Spuches TESI DI CO-TUTOR Francesca Genduso Prof. Matteo Meschiari COORDINATORE DEL DOTTORATO Chiar.mo Prof. Michele Cometa A.A 2016/2017 Indice Introduzione ..........................................................................................................................3 Capitolo 1 Il postcoloniale come pratica e condizione contemporanea ..............................13 1.1 Ambiguità e punti di forza di un pensiero frammentario ..........................................13 1.2 Poter ridire di nuovo “Io”: il pensiero sulla decolonizzazione ..................................23 1.3 Il “post” come metafora: la critica postcoloniale ......................................................42 1.4 Temporalità dislocate ................................................................................................61 Capitolo 2 Il qui e l’altrove: il caso italiano ........................................................................75 2.1 L’Italia e il colonialismo: tra un passato rimosso e una prospettiva in divenire .......75 2.2 L’impresa coloniale: la costruzione del sé attraverso la -

Florestano Di Fausto and the Politics of Mediterraneità
*Please click on ‘Supporting Material ’ link in left column to access image files * The Light and the Line: Florestano Di Fausto and the Politics of Mediterraneità Sean Anderson Architecture was born in the Mediterranean and triumphed in Rome in the eternal monuments created from the genius of our birth: it must, therefore, remain Mediterranean and Italian. 1 On March 15, 1937 along the Via Balbia, an 1800-kilometer coastal road linking Tunisia and Egypt, Benito Mussolini and Italo Balbo, then provincial governor of Italian Libya, inaugurated the Arco di Fileni, a monumental gateway commemorating two legendary Carthaginian hero- brothers, while on their way to Tripoli to celebrate the first anniversary of the Italian colonial empire. Designed by the architect Florestano Di Fausto, the travertine arch, with its elongated archway and stacked pyramidal 31-meter high profile, was built atop a purported 500 BCE site that marked the division between the Greek territory of Cyrene and Carthaginian holdings to the east. Atop the arch, an inscription by the poet Horace, made popular by the Fascist party with a stamp issued in 1936, emphasized the gateway’s prominence in visual terms: “O quickening sun, may naught be present to thy view more than the city of Rome.”2 The distant horizon of Rome, or more broadly, that of the newfound empire, framed by the arch, condensed an architectural, political, and spectral heroism that was akin to the civilizing mission of Italian colonialism. Here, the triumphant building of the arch, the road that passed through it, and the transformation of the Libyan landscape denoted the symbolic passage of an Italian consciousness into what formerly been indeterminate terrain. -

Il Fondo Maugini Nel Catalogo Di Ateneo
Fondo Maugini Titolo / Autore Pubblicazione Identificativo Scheda su SBN OneSearch 1: 1846-1858 Roma : Abate, 1971 UFI0100149 link 1: 1857-1885 / testo di Carlo Giglio Roma : Istituto Poligrafico dello stato, 1958 UFI0100132 link 1. congresso agricolo coloniale a Tripoli, 2-6 maggio 1928 / Sindacato Roma : Stab. Poligr. de "Il lavoro nazionale tecnici agricoli fascisti d'Italia", [1928?] UFI0048371 link 10 ans de recherches forestieres tropicales / Centre technique forestier Nogent sur Marne : Centre technique forestier tropical tropical, stampa 1960 UFI0085432 link 2: 1859-1869 Roma : Abate, 1972 UFI0100150 link 2: 1958-1963 / Giuseppe Vedovato Firenze : Le Monnier, 1963 SBL0248626 link I 25 anni di attivita del Gruppo Vittorio Bottego : 1946-1971 / con l'alto Milano : [s.n.], 1971 patronato del Presidente della Repubblica UFI0047852 link 25 deliciosos platos con arroz / Carmen Victoria Lopez Venezuela : [Corporacion venezolana de fomento, 19..] UFI0118010 link 28. riunione (Pisa, 11-15 ottobre 1939-XVII) : atti / Societa italiana per il Roma : SIPS, 1940 progresso delle scienze ; pubblicati a cura del segretario generale prof. Lucio Silla UFI0048332 link 3. Convegno nazionale delle Camere di commercio, industria e Udine : Camera di commercio, industria e agricoltura per l'emigrazione : Udine 4 e 5 maggio 1951- Gorizia 6 agricoltura, 1951 maggio 1951 UFI0047243 link 600 q.li di pere ad ettaro col Metodo Newtimes (Ferraguti) / A. Del Roma : Istituto di frutticultura e di Lungo, E. Zanini elettrogenetica, 1935 UFI0065598 link 8. Congresso internazionale d'agricoltura tropicale e subtropicale : Roma : Arte della stampa, 1939 Tripoli, 13-17 marzo 1939-XVII : rapporti e comunicazioni di sezione : riassunti / FITA UFI0068161 link A propos de la mise en liberte, par activite microbiologique, du Milano : E. -

Cahiers D'études Africaines
Cahiers d’études africaines 175 | 2004 Varia From Warriors to Urban Dwellers Ascari and the Military Factor in the Urban Development of Colonial Eritrea Des guerriers devenus résidents urbains. Les ascaris et le facteur militaire dans le développement urbain de l’Érythrée Uoldelul Chelati Dirar Electronic version URL: http://journals.openedition.org/etudesafricaines/4717 DOI: 10.4000/etudesafricaines.4717 ISSN: 1777-5353 Publisher Éditions de l’EHESS Printed version Date of publication: 1 January 2004 Number of pages: 533-574 ISBN: 978-2-7132-2004-3 ISSN: 0008-0055 Electronic reference Uoldelul Chelati Dirar, « From Warriors to Urban Dwellers », Cahiers d’études africaines [Online], 175 | 2004, Online since 22 November 2013, connection on 01 May 2019. URL : http:// journals.openedition.org/etudesafricaines/4717 ; DOI : 10.4000/etudesafricaines.4717 This text was automatically generated on 1 May 2019. © Cahiers d’Études africaines From Warriors to Urban Dwellers 1 From Warriors to Urban Dwellers Ascari and the Military Factor in the Urban Development of Colonial Eritrea* Des guerriers devenus résidents urbains. Les ascaris et le facteur militaire dans le développement urbain de l’Érythrée Uoldelul Chelati Dirar 1 The aim of this article is to discuss the role played by the military component in the process of urbanisation which Eritrea experienced, between 1890 and 1941, under Italian colonialism. Two main points will be discussed. The first one is the role played by military priorities in determining lines of development in the early colonial urban planning in Eritrea. In this section I will analyse how the criteria of military defensibility, rather than economic or functional priorities, had a significant influence on the main patterns of early colonial settlements in Eritrea. -

Valutazione Tattica Della Battaglia
La campagna d’Africa: Libia L’Italia in guerra Breve riassunto Alla fine degli anni Trenta le forze armate italiane erano in gravi condizioni: le armi erano scarse e di vecchio tipo, l’Aeronautica usava apparecchi antiquati, la Marina era indifendibile e mancante di portaerei. Per giustificare questa ultima mancanza Mussolini aveva affermato che la stessa Italia era da considerarsi una gigantesca portaerei. Il paese, durante le sfilate, poteva mostrare al mondo solo i famosi fantomatici «otto milioni di baionette». Le guerre di Etiopia e di Spagna avevano dimostrato i limiti dell’Italia, ma nessuna riforma sostanziale era stata apportata per modernizzare la struttura militare. La campagna d’Albania, risultata vittoriosa, aveva elevato notevolmente il morale, ma non coglieva l’autentica situazione militare. In realtà ben pochi sapevano che si era rivelata una tragedia. Lo sbarco si era svolto in una confusione indescrivibile, tra urla e sconquassi, con gente finita in mare con il rischio di annegare, navi impossibilitate ad attraccare perché non era stata calcolata la profondità dei fondali. Per questo i soldati furono trasportati a terra solo grazie a barconi richiesti ai pescatori locali. Scriveva Filippo Anfuso, allora braccio destro del ministro degli Affari Esteri Galeazzo Ciano: «Se gli albanesi avessero avuto anche solo una brigata di pompieri bene armati, avrebbero potuto ributtarci nell’Adriatico». Le tradizioni belliche non erano delle migliori, ma si inneggiavano a eroi anche i comandanti con più sconfitte a carico. I generali italiani erano quasi tutti da pensione (tra i più giovani c’era Ugo Cavallero con sessanta anni), derelitti della Prima guerra mondiale, per la maggiorwww.qattara.it parte fino ad allora nell’anonimato; occorreranno le prime sconfitte per renderli «noti» alle cronache dei giornali. -

L'apporto Degli Ascari Eritrei Nella Guerra Italo – Turca
ALBERTO CAMINITI L’APPORTO DEGLI ASCARI ERITREI NELLA GUERRA ITALO – TURCA ( 1911-1912 ) STORIA POSTALE E FILATELIA TEMATICA PREMESSA. Quando lo Stato Maggiore di Roma s’avvide che le truppe inviate in Tripolitania ed in Cirenaica non erano sufficienti per espandere la conquista dalle coste verso l’interno, fu ordinato l’invio di ingenti rinforzi dalla madrepatria in Libia. Poi qualche mente più sveglia, a Roma, suggerì di far confluire nel Nordafrica alcuni battaglioni di ascari eritrei, in quanto già addestrati ad operazioni di guerriglia, agili nei movimenti sul campo e pratici di scontri in zone desertiche. Il 1912 vide quindi l’intervento di alcuni nostri Battaglioni eritrei. Si provvide : Alla costituzione di quattro nuovi battaglioni eritrei, numerati dal V all’ VIII ( per tradizione si usavano i numeri romani ). Essi alternandosi, giunsero e combatterono in Libia già a partire dal febbraio 1912. venne immediatamente inviato a Tripoli un primo battaglione ( magg. Ernesto De Marchi ) composto da 4 compagnie, ognuna prelevata da ciascuno dei quattro battaglioni preesistenti. Fu denominato V Battaglione Ascari. Non si poteva completamente indebolire la guarnigione della primigenia colonia africana, su cui gravava – dopo Adua – la costante minaccia d’invasione abissina, mentre i nuovi coscritti si stavano addestrando. Inoltre, a parte lo Squadrone di cavalleria Savari, di cui appresso faremo cenno, vennero arruolati ( Ordinanza del 27.2.1912 ) indigeni libici appartenenti ad alcune tribù locali non dimostratesi finora a noi ostili, con cui si formarono tre bande di irregolari arabi per complessivi 600 armati, che presero il nome dalle rispettive etnie d’origine ( del Garian, del Sahel, e di Tarhuna ). -

The Road to Zero. Somalia's Self-Destruction.Pdf
THE ROAD TO ZERO Somalia’s Self-Destruction MOHAMED OSMAN OMAR THE ROAD TO ZERO Somalia’s Self-destruction Personal Reminiscences HAAN Associates 1992 Published in 1992 by HAAN Associates PO Box 607, London SW 16 IEB © Mohamed Osman Omar 1992 ISBN 1 874209 75 8 Front cover map drawn by Shannan Mohamed Abdu Hag Reprinted 1993, London Reprinted 2004, New Delhi Typeset by Digigrafics, New Delhi Printed by Everest Press, New Delhi Sources which have been consulted in the preparation of this book are referenced in footnotes on the appropriate text pages. The photographs are reproduced from the following sources: Somali News, Mogadishu; the author’s personal photographic collection; Mogadishu from the Air Calendar 1986, USAID, Mogadishu, Somalia; Somalia National Film Agency; UN Archives. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, electronic or mechanical, including photocopy or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. DEDICATED TO THE SOMALI PEOPLE ‘Hal bacaad lagu lisey’ A camel milked into the sand has all its efforts dissipated SOMALI PROVERB Acknowledgements First and foremost, I am indebted to my family and relatives who have patiently borne with me during the course of my professional career, which provides the setting for my narration. I am also beholden to those of my friends who gave me continuous encouragement to write these few lines. I was born in Mogadishu in 1937, and my lifetime has spanned five changing and momentous decades in the life of my people and country. My personal reminiscences of living through these decades, being moulded by them, and participating in them as a citizen, government functionary, and diplomat, may strike a chord with others of my countrymen and women who have a story to tell. -

Impa2015 OK:#Impa2006 Ok
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archivio istituzionale della ricerca - Università di Modena e Reggio... Atti Soc. Nat. Mat. Modena 146 (2015) Marisa Mari*, Ivano Ansaloni** Reperti delle colonie italiane nel Museo di Zoo - logia dell’Università di Modena Riassunto Il legame tra la cittadinanza ed il Museo di Zoologia dell’Università di Modena è stato particolar- mente sentito dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai primi decenni del Novecento come testimo- niano i numerosi reperti donati da modenesi. Oltre ad esemplari locali, diverse sono le collezioni eso- tiche raccolte durante soggiorni e/o viaggi all’estero. I reperti provenienti dall’Africa Orientale Italiana e dalla Libia sono stati inviati in gran parte da militari. Vengono qui prese in esame le rac- colte di Vertebrati (Rettili, Uccelli e Mammiferi) cacciati in Eritrea dal tenente dei Bersaglieri Ettore Martini nel 1892-1894 e dal Dott. Guido Corni mentre era Governatore della Somalia Italiana (1928-1931). Abstract Finds from the Italian colonies in the Zoology Museum of Modena University. The link between the citizens of Modena and the Zoology Museum of the local University was particularly strong from the second half of the 19th century up to the first decades of the 20th century, as witnessed by numer- ous finds presented by travellers from Modena. Besides local specimens, there are several exotic col- lections that were put together during journeys and sojourns overseas. The finds coming from Italian Eastern Africa and Libya were mostly sent by military men. This study takes into account the collec- tions of Vertebrates (Reptiles, Birds and Mammals) hunted in Eritrea in 1892-1894 by lieutenant of the Bersaglieri corps Ettore Martini and by Dr. -

Women, Resistance and the Creation of New Gendered Frontiers in the Making of Modern Libya, 1890-1980
WOMEN, RESISTANCE AND THE CREATION OF NEW GENDERED FRONTIERS IN THE MAKING OF MODERN LIBYA, 1890-1980 A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History By Katrina Elizabeth Anderson Yeaw, M.A. Washington, D.C. November 15, 2017 Copyright 2017 by Katrina Elizabeth Anderson Yeaw All Rights Reserved ii WOMEN, RESISTANCE AND THE CREATION OF NEW GENDERED FRONTIERS IN THE MAKING OF MODERN LIBYA, 1890-1980 Katrina Elizabeth Anderson Yeaw, M.A. Thesis Advisor: Judith E. Tucker, Ph.D. ABSTRACT Women, Resistance and the Creation of New Gendered Frontiers in the Making of Modern Libya, 1890-1980 examines the gendered transformation in the territory that became Libya from the late Ottoman period until after independence. Questioning the official version of Libyan nationalism that understood colonialism as a masculine, and at times violent, interaction between male Italian colonists, soldiers, and administrators and colonized men, I demonstrate the multi-faceted ways in which Libyan women interacted with the modernizing Ottoman, Italian and later British states, whether through the introduction of new forms of education, the policing of community boundaries, or through the military suppression of armed resistance. I found that European colonial governance dismantled existing local institutions including the Ottoman education system. Consequently, Italian policies undermined previous Ottoman attempts at modernizing reforms while distorting many of the existing social structures. My dissertation utilizes a variety of Arabic and Italian sources from archives in Italy, the US, and the UK. -

Italo-German Order of Battle, North Africa, 24 May 1942
Italo-German Order of Battle North Africa 24 May 1942 Superior Command: General Ettore Bastico Superior Artillery Command: General Ettore Manc di Mores 8th Raggruppamento Army Artillery (decentralized) 152mm/37 Guns 152mm/13 Howitzers 149mm/40 Guns 149mm/28 Howitzers 37th Raggruppamento (20mm AA Guns) 50th Positional AA Guns (20mm) 51st Positional AA Guns (20mm) Superior Engineer Command: General Luigi Grosso 2nd Special Engineer Raggruppamento (Labor troops?) 7th Special Engineer Raggruppamento 31st Assault Engineerse (Guastatori)1 North Africa Intendancy: Colonel Vittorio Palma (Service and Administrative Corps) Units Directly Assigned to Superior Command 133rd Littorio Armored Division 133rd Medium Armored Regiment 2 Battalions M Tanks 12th Motorized Bersaglieri Regiment (3 Bns) 133rd Motorized Artillery Regiment 1 75mm/27 gun Battalion 33rd Engineer Battalion 25th Bologna Infantry Division 39th Infantry Regiment (2 Bns) 40th Infantry Regiment (2 Bns) 205th Artillery Regiment 1 Battalion (100mm/17 Guns) 3 Battalions (75mm/27 Guns) Support Units Raggruppamento Giovani Fascisti 2 Battalions 4th Granatieri AT Battalion Raggruppamento North Africa Celere2 11th Infantry Battalion 291st G.A.F. (Frontier) Artillery Battalion (77mm/27 Guns) 332nd G.A.F. (Frontier) Artillery Battalion (100mm/17 Guns) San Marco Marines (2 companies assigned to Hecker Group) Tripolitanian Command: Tripoli Proper 1 CCRR (Carabinier) Battalion 330th G.A.F. Machine Gun Battalion 340th G.A.F. Machine Gun Battalion 1 Assigned to 10th Corps. 2 Horse cavalry stationed in Tripoli). 1 350th G.A.F. Machine Gun Battalion 335th G.A.F. Artillery Battalion (149mm/12 Howitzers) 345th G.A.F. Artillery Battalion (120mm/25 Guns)3 353rd G.A.F.