Provincia Di Cagliari
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, Ussana E Villasor
COMUNICATO STAMPA UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO CAMPIDANO: MONASTIR NURAMINIS SAMATZAI SAN SPERATE USSANA E VILLASOR Monumenti Aperti 2019 Radici al Futuro 4 - 5 MAGGIO La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione coordinata da Imago Mundi Onlus, nel suo secondo fine settimana arriva nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio nei 6 comuni dell’Unione dei comuni del Basso Campidano: Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, Ussana e Villasor. Grazie alla volontà delle rispettive amministrazioni comunali e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili complessivamente 36 monumenti del patrimonio artistico, religioso e civile, tra cui segnaliamo Necropoli a domus de janas de Is Aruttas a Monastir; la Tomba bizantina a Nuraminis; il Monte Granatico di Samatzai; la Parrocchia di San Sperate Martire a San Sperate, il Complesso termale a Ussana e infine il Castello Siviller a Villasor. In tutti i comuni numerose iniziative arricchiscono i due giorni di manifestazione. Mentre Gusta la città con attività ricettive e di ristorazione che aprono nelle giornate di Monumenti Aperti affinché la partecipazione sia più piacevole e godibile sarà solo a Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate e Villasor. Sarà inoltre attivo un servizio bus navetta gratuito di collegamento tra i comuni. “Monumenti Aperti rappresenta per il territorio dell’Unione dei Comuni del Basso Campidano un’irripetibile occasione di condivisione di un patrimonio culturale ed etnologico che, pur con le peculiarità locali, mostra una notevole omogeneità frutto del comune percorso storico che ha caratterizzato le comunità interessate. Un filo conduttore comune che porterà il visitatore, che calcherà le strade dei comuni coinvolti, a ripercorrere le tappe più significative della storia della Sardegna: dalle testimonianze prenuragiche di Monastir a quelle medievali di Samatzai e Villasor, passando per le vestigia bizantine di Nuraminis e romane di Ussana, per giungere all’arte contemporanea con i murales e le “pietre sonore” di San Sperate. -

DOMOS Pubblicazione
Bando Domos 2006 - Allegato A - Det. n.1501/G del 27/12/07 Comune capofila Comune Beneficiario Finanziamento ARDAULI€ 168.649,04 ALLAI € 180.207,12 BUSACHI€ 245.700,86 FORDONGIANUS € 323.549,75 NEONELI € 252.600,00 ARDAULI NUGHEDU SV € 130.017,45 SAMUGHEO € 79.360,24 SORRADILE € 109.131,98 ULA TIRSO€ 110.289,98 1.599.506,42 GHILARZA€ 276.442,00 AIDOMAGGIORE€ 257.570,00 GHILARZA SODDI'€ 65.988,00 TADASUNI€ 30.000,00 630.000,00 GONNOSNO'€ 182.051,59 ALES€ 280.886,15 MORGONGIORI€ - PAU € - SIAMANNA€ 83.099,66 GONNOSNO' USELLUS € 78.546,71 VILLAVERDE € 40.158,82 VILLAURBANA € 219.912,35 VILLA S ANTONIO€ 60.816,62 945.471,90 BONORVA€ 169.682,80 ALGHERO€ 141.309,07 BANARI€ 130.139,03 BESSUDE€ 64.954,72 BONNANARO€ 70.030,13 BORUTTA€ 132.662,01 COSSOINE€ 130.904,27 FLORINAS€ 92.840,99 GIAVE€ 129.097,24 BONORVA MARA€ 131.947,01 MONTELEONE ROCCA DORIA€ 124.765,75 PADRIA€ 144.000,00 POZZOMAGGIORE€ 134.738,32 ROMANA€ 131.781,64 SEMESTENE€ 130.072,80 THIESI€ 134.537,41 TORRALBA€ 132.696,63 VILLANOVA MONTELEONE€ 128.495,92 2.254.655,74 OZIERI€ 361.228,78 ARDARA€ 25.750,66 ITTIREDDU € 85.119,20 OZIERI MORES € 139.699,14 PATTADA€ 203.332,17 TULA€ 144.870,05 960.000,00 1 Bando Domos 2006 - Allegato A - Det. n.1501/G del 27/12/07 Comune capofila Comune Beneficiario Finanziamento ARITZO€ 298.532,82 ATZARA € 183.350,53 AUSTIS € 239.736,60 BELVI' € 73.237,40 GADONI € 105.578,06 ARITZO MEANA SARDO € 112.871,40 ORTUERI € 137.016,80 SORGONO€ 254.836,40 TONARA€ 194.839,99 1.600.000,00 GONNOSTRAMATZA€ 185.586,24 BARESSA € 30.191,84 BARADILI € 28.719,27 CURCURIS€ -

Relazione Di Fine Mandato
Comune di Nuraminis RELAZIONE DI FINE MANDATO (Anni di mandato 2015 – 2020) (art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 1 Premessa La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema e esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. -

Pier Virgilio Arrigoni the Discovery of the Sardinian Flora
Pier Virgilio Arrigoni The discovery of the Sardinian Flora (XVIII-XIX Centuries) Abstract Arrigoni, P. V.: The discovery of the Sardinian Flora (XVIII-XIX Centuries). — Bocconea 19: 7-31. 2006. — ISSN 1120-4060. The history of the floristic exploration of Sardinia mainly centres round the works of G.G. Moris, who in the first half of the XIX century described most of the floristic patrimony of the island. But it is important to know the steps he took in his census, the areas he explored, his publications, motivations and conditions under which he wrote the "Stirpium sardoarum elenchus" and the three volumes of "Flora sardoa", a work moreover which he left incomplete. Merit is due to Moris for bringing the attention of many collectors, florists and taxonomists to the Flora of the Island, individuals who in his foot-steps helped to complete and update the floristic inventory of the island. Research into the history of our knowledge of the Sardinian Flora relies heavily on the analysis of botanical publications, but many other sources (non- botanical texts, chronicles of the period, correspondence) also furnish important information. Finally, the names, dates and collection localities indicated on the specimens preserved in the most important herbaria were fundamental in reconstructing the itineraries of the sites Moris visited. All these sources allowed us to clarify several aspects of the expeditions, floristic col- lections and results of his studies. The "discovery phase" of Sardinian Flora can be considered over by the end of the XIX century with the publication of the "Compendium" by Barbey (1884-1885) and "Flora d'Italia" by Fiori & Paoletti (1896-1908). -

Linea 120 TUILI-PAULI ARBAREI-SARDARA-SANLURI-CAGLIARI
Linea 120 TUILI-PAULI ARBAREI-SARDARA-SANLURI-CAGLIARI Condizione pianificazione SCO SCO FER SCO GIO SCO SCO FNSC FNSC Numero corsa 1 13 3 5 7 9 11 15 17 TUILI via Roma-Chiesa 15:15 15:15 PAULI ARBAREI via Roma 5:56 15:25 15:25 LUNAMATRONA piazza IV novembre 6:00 15:29 15:29 LUNAMATRONA via Risorgimento 30-31 6:01 15:30 15:30 VILLANOVAFORRU via delle Tamerici 79 6:09 15:38 15:38 VILLANOVAFORRU piazza Costituzione-Museo 6:11 14:20 15:40 15:40 VILLANOVAFORRU via Umberto I 58 6:11 14:20 15:40 15:40 COLLINAS via Vittorio Emanuele 54 6:16 14:25 15:45 15:45 COLLINAS via Vittorio Emanuele 35 6:16 14:25 15:45 15:45 COLLINAS via Vittorio Emanuele 1 6:16 14:25 15:45 15:45 SARDARA via dei Platani 103 6:24 14:33 15:53 15:53 SARDARA via dei Platani 59 6:24 14:33 15:53 15:53 SARDARA via Cagliari 5 6:26 14:35 15:55 15:55 SARDARA via Oristano 127 - 11:08 - - - SARDARA via Oristano 3 - 11:09 - - - SARDARA via San Gavino 20 6:26 11:10 14:35 15:55 15:55 SANLURI viale Trieste 10 6:39 11:23 14:48 16:08 16:08 SANLURI Autostazione 6:40 6:40 6:40 11:24 14:49 16:09 16:09 16:10 SANLURI Piazza San Pietro - - 6:42 - - - SANLURI Porta nuova - - 6:42 - - - SERRENTI via Nazionale 257 6:53 6:53 6:53 11:37 16:22 16:23 SERRENTI via Nazionale 213 6:53 6:53 6:53 11:37 16:22 16:23 SERRENTI via Nazionale 83 6:54 6:54 6:54 11:38 16:23 16:24 SERRENTI via Nazionale 19 6:55 6:55 6:55 11:39 16:24 16:25 VILLAGRECA Centro - 7:05 7:05 11:49 - - NURAMINIS via Nazionale 297 7:08 7:13 7:13 11:57 16:37 16:38 NURAMINIS via Nazionale 170 7:09 7:14 7:14 11:58 16:38 16:39 NURAMINIS fronte -

Progetto “La Bottega Dei Sapori” CUP E87B16001320009 CLP 1001031811GA160005 DCT 2016A1RO143
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 – “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” – Linea A1 – Asse Prioritario 1 – Occupazione. Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo Progetto “La Bottega dei Sapori” CUP E87B16001320009 CLP 1001031811GA160005 DCT 2016A1RO143 Indirizzario Centri per l’Impiego – Ex Ufficio di collocamento Medio Campidano Sede Indirizzo Telefono Mail Comuni di competenza San Gavino Via Montevecchio (ex dopolavoro, 070 9376107/ 9377061 / [email protected] Pabillonis, Sardara, Villacidro, Arbus, Gonnosfanadiga, San Gavino Monreale, Guspini. Monreale fonderia) 9356900 rdegna.it Collinas, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, 0709307907 – Sanluri Via Cesare Pavese, 7 [email protected]. Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca, Barumini, Furtei, 0709370282 Genuri, Serramanna, Serrenti, Villanovaforru. Cagliari Sede Indirizzo Telefono Mail Comuni di competenza Sede decentrata Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Pula, Via Circonvallazione, 22 Domusdemaria, Elmas, Monastir, Pula, San Sperate, Sarroch, Sestu, Tel. 070 9245150 Assemini Via Lisbona, 3 070 94851 [email protected] Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa S.Pietro, Villa Speciosa, Mail: Siliqua, Villasor. [email protected] Viale Borgo Cagliari, Monserrato Cagliari 070 52844 [email protected] Sant’Elia, sn Muravera Via Tirso 0709931345 [email protected] Muravera, San Vito, Villaputzu, Armungia, Castiadas Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Serdiana, Settimo San Villasimius, Via Vittorio Veneto, 3 Quartu Via Bizet 070836741 [email protected] Pietro, Sinnai, Soleminis, Villasimius, Burcei, Maracalagonis, Tel. 0707930249 S.E. -
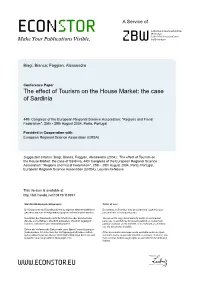
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Elenco Ditte Beneficiarie Determinazione N
Elenco ditte beneficiarie ALLEGATO 1 Determinazione N.___________________ del______________ IMPORTO MOD. PROG. CUAA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTA' IMPORTO RITENUTA PAGAMENTO 1 BSAMHL76H03B354Y ABIS MICHELE VIA DAMIANO CHIESA 48 SERRAMANNA€ 4.117,62 € - G 2 BSANLN43T16M025P ABIS NATALINO VIA Y GAGARIN 4 VILLASOR€ 1.499,19 € - G 3 00207620923 A.GRAMSCI COOPERATIVA AGRICOLA A RE LOCALITA' SAN GIORGIO SERRAMANNA€ 14.843,22 € 593,73 G 4 NGRLSS60C06D260V ANGIARGIA ULISSE VIA ALDO MORO, 6/B DECIMOPUTZU€ 11.151,00 € - G 5 NNANTN55M18F983P ANNI ANTONIO VICO MUNICIPIO N 10 NURAMINIS€ 7.743,75 € - G 6 NNANFR36H02F983X ANNI ONOFRIO VIA REGINA MARGHERITA 43 NURAMINIS€ 1.239,00 € - G 7 SSRNTN66T12L521P ASSORGIA ANTONIO VIA DE GASPERI 5 P 1 UTA€ 3.092,29 € - G 8 TZNMCL71L03I667G ATZENI MARCELLO VIA TOGLIATTI 9 SERRENTI€ 5.290,53 € - G 9 TZNNCL76E02L521V ATZENI NICOLA VIA DETTORI 6 UTA€ 7.211,10 € - G 10 02767510924 AZIENDA AGRICOLA DEI FRATELLI ALBER VIA GIUSTI N.9 SERRAMANNA€ 38.669,19 € 1.546,77 G 11 BTZMRC68L31B354M BATZELLA MARCO VIA NAZIONALE 211 NURAMINIS€ 2.230,20 € - G 12 BCCFCN50R53H738F BECCIU FELICINA CORSO XXV APRILE 6 VILLASOR€ 13.629,00 € - G 13 CBDDFN64D02B354R CABIDDU DELFINO VIA CONIUGI ROSEMBERG 13 SAMASSI€ 9.012,14 € - G 14 CBNLVE45R18H738J CABONI ELVIO VIA SACCO E VANZETTI 34 SAMASSI€ 855,53 € - G 15 CAOMCL38D13D259E CAO MARCELLO VIA VAL D'AOSTA 10 DECIMOMANNU€ 848,73 € - G 16 CPPGPR72E27F983H CAPPAI GIANPIERO VIA PALMIRO TOGLIATTI 14 NURAMINIS€ 4.968,39 € - G 17 CRBGRC51H66A474L CARBONI GRECA VIA CIMITERO 39 UTA€ 1.206,00 € - G -

Anno 2020 Nr
Elenco delle Imprese iscritte al Registro ex art. 68 del cod. nav. dell'AdSP del Mare di Sardegna - Anno 2020 Nr. Iscr. Impresa Indirizzo CAP Città PEC RN2016/00 A.P. ECO SERVICES SRL - ex Agus Paolo Loc. terr'e Mamusa 09047 Selargius [email protected] 3 Spurghi Srl RN2017/00 ALIMAK HEK Srl Località San Marziale n. 45/A 53034 Colle Val d'Elsa [email protected] 1 RN2018/01 ANTI CORROSIONE SARDEGNA Zona Industr. Portovesme 09010 Portoscuso [email protected] 2 RN2017/00 AGUECI FRANCESCO Noleggio Autogrù e Via Natta n. 15 09067 Elmas [email protected] 2 Trasporti Srl RN2019/03 AR.DE. Impianti di Sicurezza Snc S.S. 554 Km. 6,700 09047 Selargius [email protected] 0 RN2019/00 BANCHIERO Srl Via Betti n. 1 09067 Elmas [email protected] 9 RN2019/02 BLUE SHARK Srl Via Santa Maria Chiara n. 159 09134 Pirri [email protected] 2 RN2017 CA.GI Manutenzioni di Gianni Cauli Via Temo s.n. 09088 Simaxis [email protected] RN2017/00 CAGLIARI TOURING di Dessì Claudio Via S. Efisio n. 96 09124 Cagliari [email protected] 3 RN2019/03 CARLO PILI TRASPORTI Srl Via G. Cesare n. 1 9042 Monserrato [email protected] 2 RN2019/01 COREM Srl Costruzioni Revisioni Viale Monastir Km. 7,350 09028 Sestu [email protected] 0 Meccaniche RN2019/01 COSMIN SpA Località La Maddalena Spiaggia 09012 Capoterra [email protected] 8 RN2019/00 ECO.GE.M.MA. Srl Zona Industriale III° Strada 09032 Assemini [email protected] 1 RN2018/00 ECOSARDA Via Puglia n. -

Profilo Demografico E Sociale Dell'ambito Plus Area Ovest
Provincia di Cagliari – Provincia de Casteddu Settore Servizi sociali e di Istruzione Sistema integrato degli Osservatori sociali Profilo demografico e sociale dell’Ambito Plus Area Ovest Ottobre 2013 Indice Note di metodo Pag. 3 1. Le dinamiche e la struttura della popolazione Pag. 4 2 La popolazione straniera Pag. 9 3 La condizione scolastica Pag. 10 4 La ricerca di lavoro Pag. 18 5 I minori in affido Pag. 19 La progettazione delle ricerche di base e la supervisione del presente fascicolo è stata curata dalla società Nuova Teles Studi e Ricerche di Capoterra (Ca) 2 Note di metodo Il profilo demografico e sociale presentato di seguito costituisce un aggiornamento al mese di ottobre del 2013 dell’analogo profilo messo a punto nel mese di dicembre del 2011. Il lavoro di aggiornamento, oltre che sui nuovi dati messi a disposizione dall’Istat e dagli altri organismi deputati alla produzione di statistiche ufficiali, si basa anche sull’attività di indagine svolta autonomamente dall’Osservatorio delle politiche sociali della Provincia con il fine di acquisire nuovi o più dettagliati elementi di conoscenza con riferimento, in particolare, alle aree tematiche dell’istruzione, dei minori e degli anziani. Peraltro, nella prospettiva dell’avvio della nuova programmazione Plus per il triennio 2015/2017, l’Osservatorio ha messo a punto un nuovo e più articolato modello della struttura dell’archivio di dati e informazioni che dovranno costituire la base per la stesura del profilo d’ambito che sarà predisposto entro il mese di marzo del 2014. Il modello in questione – in armonia con le indicazioni contenute nelle linee guida della L.R. -

La Sardegna Cresce Con L'europa
La Sardegna cresce con l’Europa Cagliaritano Territory Basilica of Archaeological area Project jointly funded by the European Union San Saturnino of Sant’Eulalia Operational programme ERDF 2007 – 2013 Cagliari Cagliari EUROPEAN UNION ERDF - European Regional Development Fund - Axis I, Activity line 1.2.3.a. REPUBBLICA ITALIANA P.O.R. ERDF Sardinia 2007-2013, Line 1 “Information Society”, Specific Goal 1.2. “Promoting and developing the information society with a particular attention to those key aspects that will sustain the development of the territory and the quality of life, as health, education and the promotion of culture”, Operational Goal 1.2.3. “Increasing the production of the digital contents”, Action Line of 1.2.3.a. “Actions for the production, publication and sharing on the web and on new media (DTV, mobile T, etc.) of digital contents concerning Sardinia’s culture, literature, music, territory and images for a social fruition”. Cultural heritage Cagliaritano We thank the Superintendence for the Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-An - thropological Heritage for the metropolitan city of Cagliari and for the provinces of Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias and Ogliastra, for the kind cooperation. Territory Basilica of San Saturnino | Cagliari Archaeological area of Sant’Eulalia | Cagliari Cultural heritage Unicity Srl: Sardegna Virtual Archaeology Coordination and Production 3D and 3D Render Reconstruction Cagliaritano and Production Virtual Guided Territory Visits and Virtual Views Production Communication and Multimedia Basilica of San Saturnino Testaluna Srl: Text: Mrs. Lucia Mura 3D Planning and Interactivity Mrs. Rossana Martorelli Polonord Adeste Srl: Archeological area USB Pendrive Production of Sant’Eulalia Text: Mrs. -

Listino Dei Valori Immobiliari Dei Terreni Agricoli
ISSN: 2280-191X LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI CAGLIARI -CI-VS LISTINO 2017 RILEVAZIONE ANNO 2016 quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo e un massimo per le prin cipali colture in ciascun comune privati professionisti edizioni pubblica amministrazione O SSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI – PROVINCIA DI CAGLIARI – RILEVAZIONE 201 6 Hanno collaborato alla formazione del listino MASSIMO CURATOLO, ingegnere, membro di numerose commissioni di congruità presso enti pubblici. È stato capo area presso la struttura centrale della Agenzia del Territorio che si occupava di Osservatorio del mercato immobiliare. Ha diretto l’ufficio tecnico erariale di Isernia e di Viterbo. È stato capo del Servizio Tecnico 1° della Direzione Centrale dei SS.TT.EE. Autore/coautore di numerose pubblicazioni sia in campo estimale che catastale. Ha svolto numerosi incarichi di docenza. ANTONIO IOVINE, ingegnere consulente in materia di catasto ed estimo, attualmente direttore scientifico rivista informatica www.catastonline.it. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, responsabile dell’Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per conto della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e di altre strutture pubbliche o private tra cui, Scuola delle Autonomie locali, Consiel, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Verona, Synergia formazione. La redazione gradisce indicazioni costruttive o suggerimenti migliorativi ([email protected]). Disclaimer L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze.