Ambito 33B Montagnola 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geothermal Energy Use, Country Update for Italy
European Geothermal Congress 2019 Den Haag, The Netherlands, 11-14 June 2019 Geothermal Energy Use, Country Update for Italy Adele Manzella1, Davide Serra2, Gabriele Cesari3, Eleonora Bargiacchi1, Maurizio Cei2, Paolo Cerutti3, Paolo Conti1, Geoffrey Giudetti2, Mirco Lupi2, Maurizio Vaccaro1, 1 UGI – Italian Geothermal Union, c/o University of Pisa-DESTEC, Largo Lazzarino 2, 56122 Pisa, Italy 2 Enel Green Power, via Andrea Pisano, 120, 56122 Pisa, Italy 3ANIGHP – National Association of Geothermal Heat Pump, via Quintino Sella 23, 00187, Roma, Italy [email protected] Keywords: Electricity generation, Thermal uses, temperature systems tend to be in tectonically active District heating, Geothermal heat pumps, Thermal regions either in volcanic and intrusive or fault- balneology, Agricultural applications, Fish farming, controlled systems (Santilano et al., 2015 and ref. Industrial processes, Development, Market, Support therein). measures. Electricity from geothermal resources nowadays is ABSTRACT produced in the Tuscany region, central Italy. Many direct applications of geothermal heat are also located This paper presents an overview on the development of in Tuscany, however thermal uses are widespread in the geothermal energy applications in Italy for the year national territory, with district heating systems (DHs) 2018 for both electricity generation and thermal uses. mostly localised in the north and other direct uses and Geothermal power plants are located in Tuscany, in the ground source heat pumps (GSHPs) distributing on a two “historical” areas of Larderello-Travale and Mount much larger territory. Amiata. Thermal energy applications are widespread over the whole Italian territory. To date, Enel Green The first part of this paper (sections 2-5) deals with geo- Power is the only geo-electricity producer in Italy. -

SIENA Alelargoro En
SUGGESTED ROUTE FROM SIENA TO RADICONDOLI map downloaded from www.radiconventosservanza.it or From Siena follow the signposts for the dual www.ethoikos.it cariageway Siena-Firenze towards Firenze and stay Graphic design by Alessandro Belli and on this route until you reach the exit for Roberto Cozzolino Monteriggioni. Here turn left and follow the road for about 50 metres when you will come to a junction ©2002-2004 all rights reserve with a bar on your right. Take the right turn towards Colle di Val d’Elsa and proceed for just over 1 Km where you will take a left turn sign-posted to Abbadia Isola–Strove. Follow on this road until you Poggibonsi reach the SP541 route where you will turn sharp left over a bridge sign-posted to Grosseto. Stay on this road for about 10 km until you reach a right turn towards Radicondoli. You will recognise this turning as it is soon after a small petrol station also on your right. Follow the direction for Radicondoli which you SP 541 SS 2 will reach after about 13 km. Siena-Firenze Colle SP 5 Val D’Elsa MONTERIGGIONI exit Siena-Firenze SP 74 To w ards To w ards COLLE GROSSETO VAL D’ELSA Badesse SS 2 To w ards ABBADIA ISOLA- SP 541 STROVE SIENA Mensano Fuel station Pievescola SS 326 SP 541 Sovicille SP 3 To w ards SP 73 RADICONDOLI SS 2 Rosia SP 35 SP 3 SS 223 RADICONDOLI To w ards Chiusdino, Roccastrada How to get to the Convent Once you reach the village, past the Post Office, follow the road down to your left which is sign-posted to Castelnuovo Val di Cecina do not head for the town centre). -

Successe in Valdichiana
Successe in Valdichiana Copyright - © - 2010 - Thesan & Turan S.r.l. Via San Donato, 12 - 53045 Montepulciano (Si) www.thesaneturan.it ISBN 9 Alessandro Angiolini SUCCESSE IN VALDICHIANA Storie, luoghi e personaggi THESAN & TURAN EDITORE Prefazione dell’autore Ho raccolto in questo libro quasi un decennio di scritti nati dalla passione per la storia della mia terra, la Valdichiana. Una ela- borazione di una parte dei testi pubblicati negli anni su giornali e periodici toscani ai quali ancora oggi collaboro, o meglio, una dovuta rielaborazione con aggiunte di notizie e approfondimenti descrittivi resi possibili dalla libertà di battute che ti può concede- re una pubblicazione. Forse non leggerete nulla di nuovo di quello che è già stato scritto su questa terra da autori illustri negli anni e nei secoli pas- sati, ma nonostante questo credo di essere riuscito, senza lode e senza infamia, in modo scorrevole e semplice, a descrivere una serie di avvenimenti con una visione diversa dal solito raccontare, con qualche piccola ed inedita scoperta e con la consapevolezza che la storia, a volte, è anche intuizione. In queste pagine ho riversato il mio amore per la storia studiata in centinaia di libri e documenti, vecchi e nuovi, validi e meno validi, intonsi e strappati, appunti scarabocchiati da chissà chi, magari alcuni rarissimi recuperati per volontà del destino dall’oblio della spazzatura della carta straccia. E i protagonisti che troverete nei trentadue capitoli di questo libro saranno i nomi di vecchie strade e i loro millenari percorsi, i toponimi dimenticati che indicano ancora il passaggio di perdute vie etrusche e romane, le vicende di antichi luoghi abitati e oggi sconosciuti, le pionieristiche ferrovie con le loro stazioni nate e abbandonate, sognate o mai realizzate. -

*Chiusdino 01-02
I - IL CONTESTO TERRITORIALE 1. CARATTERI GEOMORFOLOGICI tre nelle tabelle verranno mantenute le informazioni di dettaglio (fig. 2) 2. Il comprensorio comunale di Chiusdino, situato a sud-ovest di Siena, occupa il settore centro-occidentale della Toscana meridio- Litotipo % nale, per un’estensione complessiva di 141,85 kmq. Confina a nord- ovest e nord-est rispettivamente con Radicondoli e Sovicille, a sud- Detriti e discariche 5,6% Depositi alluvionali 17% ovest con Montieri, a sud-est e sud con Monticiano e Roccastrada. Travertini e calcari organogeni 1,6% I limiti amministrativi non definiscono un ambito geografico- Argille 16% morfologico omogeneo e unitario. Argille e argille sabbiose con intercalazione 5,2% Sabbia con intercalazioni di argille e ciottoli 7,2% La porzione centrorientale del comune, a carattere prevalentemente Conglomerati poligenici con intercalazione 12% pianeggiante e basso collinare, rappresenta la zona medio-alta del ba- Flysh prevalentemente arenacei 0,04% cino idrografico del fiume Merse e del Feccia (affluenti dell’Om- Flysh prevalentemente argillitici 17,4% Rocce carbonatiche massicce 0,36% brone rispettivamente di destra e di sinistra); un lungo tratto del con- Rocce carbonatiche brecciate 7,2% fine orientale del comprensorio è demarcato proprio dal primo dei Rocce silicee 8,8% due fiumi. Ofioliti 1,5% Il paesaggio si modifica progressivamente fino ad assumere un ca- Tabella riassuntiva della distribuzione percentuale delle diverse formazioni geologiche pre- rattere più prettamente alto collinare e montuoso, procedendo senti nel comprensorio (le percentuali sono relative alla superficie totale del comprensorio) verso le porzioni estreme del comune; i versanti nord-est e sud- ovest coincidono infatti, l’uno con le ultimi propaggini della Mon- L’incrocio fra le caratteristiche morfologiche e quelle geo-litologiche tagnola Senese e l’altro con il sistema dei rilievi collinari delle Col- permette di individuare quattro unità paesaggistiche (descritte nella line Metallifere. -
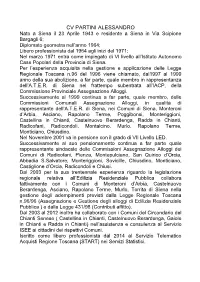
Cv Partini Alessandro
CV PARTINI ALESSANDRO Nato a Siena il 23 Aprile 1943 e residente a Siena in Via Scipione Bargagli 6; Diplomato geometra nell’anno 1964; Libero professionista dal 1964 agli inizi del 1971; Nel marzo 1971 entra come impiegato di VI livello all’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siena. Per l’esperienza acquisita nella gestione e applicazione delle Legge Regionale Toscana n.96 del 1996 viene chiamato, dal1997 al 1999 anno della sua abolizione, a far parte, quale membro in rappresentanza dell’A.T.E.R. di Siena nel frattempo subentrata all’IACP, della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi. Successivamente al 1999 continua a far parte, quale membro, delle Commissioni Comunali Assegnazione Alloggi, in qualità di rappresentante dell’A.T.E.R. di Siena, nei Comuni di Siena, Monteroni d’Arbia, Asciano, Rapolano Terme, Poggibonsi, Monteriggioni, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Montalcino, Murlo, Rapolano Terme, Monticiano, Chiusdino. Nel Novembre 2001 va in pensione con il grado di VII Livello LED. Successivamente al suo pensionamento continua a far parte quale rappresentante sindacale delle Commissioni Assegnazione Alloggi dei Comuni di Radicofani, Pienza, Montepulciano, San Quirico d’Orcia, Abbadia S.Salvatore, Monteriggioni, Sovicille, Chiusdino, Monticiano, Castiglione d’Orcia, Radicondoli e Chiusi. Dal 2003 per la sua trentennale esperienza riguardo la legislazione regionale relativa all’Edilizia Residenziale Pubblica collabora fattivamente con i Comuni di Monteroni d’Arbia, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Rapolano Terme, Murlo, Torrita di Siena nella gestione degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale Toscana n.96/96 (Assegnazione e Gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ) e dalla Legge 431/98 (Contributi affitto). -

ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA COGNOME NOME INDIRIZZO PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri
ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA CITTA' COGNOME NOME INDIRIZZO (di Residenza) PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri Veronica Via Umberto I°, 5 Piancastagnaio SI Alicia Andrea Loc. Monti 89 Gaiole in Chianti. SI Ambrosio Filomena Via Elia Mazzei, 34 Castelnuovo B.ga SI Amerighi Laura Montevarchi SI Angeli Pierluigi Via G. di Vittorio, 9 Chianciano Terme SI Angeletti Daniela Via Oslavia,105 Chiusi SI Ardenghi Daniela Via di Fontanella,21 Siena SI Aurigi Ilaria Via Alfieri, 23/B Castelnuovo B.ga SI Avanzati Alessandra Via Chianacce, 20 Montepulciano SI Azzalin Gianluca Piazza Nagj, 2 Poggibonsi SI Bacci Renato Via G..Matteotti 53 Volterra SI Baglioni Serena S.S. 146 Sud, 14 Montepulciano SI Baglioni Denise Loc. Terranera di Sotto, 172/A Subbiano (AR) Baiocchi Lisa Via Trento,48 Abbadia S.Salvatore SI Baldini Rita Via dello Spuntone, 2 Colle di Val D'Elsa SI Bandini Gaia Loc.Il Casalone Colle Val d'Elsa SI Bani Gloria Loc. Pancole, 19/A San Gimignano SI Baragli Viviana Località Sant'Andrea, 10 San Gimignano SI Barbagli Lisa Strada di Colle Pinzuto,52 Siena SI Barbetti Stefania Via Roma,2 Siena SI Barbetti Tiziana P.zza del Mercato 48 Siena SI Barbieri Gabriella Via dei Pispini,55 Siena SI Bardelli Federica Via Traversa Valdichiana Ovest , 62 Torrita di Siena SI Bardelli Sara Via Abruzzi, 20 Siena SI Bardelli Annalisa Via Leccetello, 53 Trequanda SI Bartalini Duccio P.zza G.Amendola.6 Siena SI Bartoli Francesca Via E.Fermi,14 Sinalunga SI Bassanelli Elisa Via Gallerani, 19 Siena SI Bastreghi Elena Via Lauretana Ovest, 1 Montepulciano SI Batelli Barbara Loc. -

Azienda USL 7 Di Siena
Emergenza Urgenza e Guardia Medica 118 Azienda USL 7 di Siena CUP AOUS e ASL 7 0577 767 676 Sede legale: Piazzale Rosselli, 26 53100 Siena Info Salute 0577 767 777 www.usl7.toscana.it [email protected] Prenotazione Libera Professione 0577 767 788 Sicurezza sul lavoro - Numero Verde 800 354 529 Dipartimento di Prevenzione 0577 536 690 Ospedale Montepulciano 0578 713 111 Ospedale Poggibonsi 0577 994 111 Ospedale Abbadia S. Salvatore 0577 782 111 ZONA SENESE Presidio di Rosia e San Rocco a Pilli ����������������� 0577 536 301/637 Riabilitazione ................................................0577 994 257 / 763 Centralino ...............................................................0577 535 111 ZONA VALDICHIANA Ospedale di Comunità .............................................0577 994 331 Accoglienza .............................................................0577 535 909 Centralino ...............................................................0578 713 111 SERT - Colle Val d’Elsa ....................................... 0577 994 984 / 5 Sert .........................................................................0577 535 965 Accoglienza Ospedale .............................................0578 713 201 Salute mentale - Colle Val d’Elsa .............................0577 994 981 Salute mentale adulti ..............................................0577 536 032 Ospedale di Comunità .............................................0578 713 078 Consultorio - Poggibonsi .........................................0577 994 045 Salute mentale -

Curriculum Dott. Galgani Francesco
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome GALGANI FRANCESCO Indirizzo VIA DEL POGGIO , 12 – FRAZIONE SAN ROCCO A PILLI , SOVICILLE (SI) Telefono 334 6603407 Fax - E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 02/02/1969 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) DALL ’11 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2014 • Nome e indirizzo del datore di Comune di Montalcino – Piazza Cavour, 13 – 53024 Montalcino (SI) lavoro • Tipo di azienda o settore Ente Locale • Tipo di impiego Attività svolta per 6 ore settimanali, in comando dall’Unione dei Comuni della Val di Merse • Principali mansioni e responsabilità Vice Segretario • Date (da – a) DAL 1^ GENNAIO 2009 AL 25 MAGGIO 2014 • Nome e indirizzo del datore di Unione dei Comuni della Val di Merse – Via Tiberio Gazzei, 24 – 53030 Radicondoli (SI) lavoro • Tipo di azienda o settore Ente Locale istituito dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille • Tipo di impiego Dirigente con contratto a tempo determinato, con incarico conferito dal Presidente a norma dell’art. 110 del Decreto Legislativo 267/2000 • Principali mansioni e responsabilità Segretario Generale, Responsabile del Settore Segreteria generale e del Settore Amministrativo-Contabile e Finanziario dell’Ente • Date (da – a) DAL 1^ GENNAIO 2006 AL 31 DICEMBRE 2008 • Nome e indirizzo del datore di Comunità montana Val di Merse – Via Tiberio Gazzei, 24 – 53030 Radicondoli (SI) lavoro • Tipo di azienda o settore Ente Locale • Tipo di impiego Dirigente con contratto a tempo determinato, -

Create by Pagemanager
Numero Unico delle Scuole di MONTERIGGIONI IL SALUTO DEL SINDACO L'attività di comunicazione sta assu mendo sempre più un ruolo di fon damentale importanza nello svilup po dei nostri rapporti sociali. Farsi conoscere e far conoscere le proprie idee, le proprie attività, costi tuisce un importantissimo segnale di coscienza civica ed esaita la voglia e le capacità di confrontarsi democraticamente e liberamente al fine di rimuovere i vari ostacoli ad una capacità di rapporti che diviene ogni giorno sempre più problemati ca. Rivolgo pertanto un plauso ai nostri alunni, agli insegnanti ed alle auto rità didattiche che hanno voluto e realizzato questa iniziativa, che sicuramente costituisce fin da ora un preciso contributo al migliora mento del messaggio educativo ed istituzionale degli alunni delle scuole di Monteriggioni. Il Sindaco Paolo Casprini SOMMARIO II Giornalino, perché, per chi... * Una storia antica 2 L'idea del giornalino secondo me è ...per far conoscere noi e la nostra ...per comunicare le cose di tutti i stata una buona cosa, sia per noi scuola, quello che facciamo. giorni e per far divertire le persone che per gli altri. Sono d'accordo a Martina Baccani 5A S.Martino che io leggono. • Abbadia Pisola 3 continuare questo giornalino perché Angela Fantappiè 5B S.Martino anche i più timidi o quelli più silen ...perché vogliamo provare ad esse • Tanti castelli 4 ziosi , che si vergognano di tutto, re dei veri giornalisti. Se passate per Monteriggioni Antonella Pappalardo comprate il nostro giornalino, 5A S.Martino costa poco ed è carino! • Una miriade di cento .... .5 Questo è utile per aiutarli ad espri mersi e per invitarli ad una comuni E'interessante e divertente, ...per ricordare ai bambini che ver compratelo pure, brava gente! • Un Comune, ma dov'è? 6 cazione più diretta. -

Via Francigena – a Walk Through Tuscany
Via Francigena: A walk through Tuscany Florence, San Miniato, San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Siena The Via Francigena route is an ancient pilgrimage route from Cantebury to Rome. The Italian section traverses through some iconic and beautiful Tuscan countryside combining a wealth of history, art and architecture. Throw in a world-famous cuisine and picture-postcard pretty landscape and you can be sure to experience the perfect balance of exploration and indulgence Highlights ➢ Travel an ancient pilgrimage route through beautiful Tuscan countryside ➢ Experience a unique Truffle Hunt in San Miniato ➢ Visit the distinctive trio of Tuscany’s medieval towns – Siena, San Gimignano and Monteriggioni ➢ Discover remarkable churches, abbeys and monasteries overlooking rolling hills ➢ Revel in your walk as you slow down to enjoy the beauty of Tuscany’s culture and traditions ➢ Enjoy delicious wine, wonderful local cuisine, traditional villages and stunning locations Day 1: 22 September 2020 - Arrival in Florence Today, arrival into Florence airport / station from where you will make your own way to the hotel. You will be booked at the Hotel Mercure Firenze or similar for a stay of 1 night Romantic, enchanting and so beautiful, Florence is a feast for the senses. You will have the afternoon at leisure to explore Florence on your own. Dinner tonight is not included. Day 2: 23 September 2020 Florence to San Miniato (Drive : Approx 1 hour) Post breakfast, this morning, we will depart for San Miniato, a small town perched on a hill. While this little hamlet may not be as famous as the other art cities along your path, we believe sometimes "the less known, the better". -

COMUNE DI SOVICILLE Provincia Di Siena
Dott.Geol.Alberto Tomei STUDIO DI GEOLOGIA 59100 PRATO - Via Frà Bartolomeo, 36 Tel/fax 0574/41.843 E-mail: [email protected] P.IVA 01728910975 C.F.TMOLRT61P06D612D COMUNE DI SOVICILLE Provincia di Siena Studio di Microzonazione Sismica di primo livello in aggiornamento al DPGR.n.53/R/11 Relazione Tecnica Sindaco: Giuseppe Gugliotti Responsabile del procedimento: Rossana Pallini Ottobre 2017 INDICE 1. Premessa.....................................................................................................................................1 1.1 Gli elaborati dello studio di MS di 1° livello....................................................................................3 2. Selezione e delimitazione delle aree di indagine..........................................................................4 3. Inquadramento geologico e geomorfologico del territorio comunale.............................................5 3.1. Inquadramento morfologico generale..........................................................................................5 3.2.Geologia...................................................................................................................................................5 3.2.1. Stratigrafia.........................................................................................................................5 3.3. Geomorfologia..........................................................................................................................7 4. La raccolta dei dati geognostici....................................................................................................9 -

UO EDILIZIA/LL.PP. OGGETTO: Piano Operativo – Adozione Nuove Aree
COMUNE DI SOVICILLE PROVINCIA DI SIENA AREA TECNICA - U.O. EDILIZIA/LL.PP. OGGETTO: Piano Operativo – adozione nuove aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio Con deliberazioni n. 66 del 30/11/2011 e n. 67 del 2/12/2011 il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano Strutturale. Con deliberazione C.C. n. 93 del 28/11/2014 il Consiglio Comunale ha dato avvio al procedimento per la redazione del primo Piano Operativo con contestuale Variante al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 17 L.R. 65/2014, secondo le disposizioni dell’art. 232 medesima legge. Con deliberazione del Consiglio Comunale n 54 del 24/07/2018 avente per oggetto: “Variante al Piano Strutturale – Adozione – art. 19 LR 65/2014” è stata adottata la variante al Piano Strutturale, come emendata, comprensiva dei documenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.19 L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 8 comma 6 e art. 25 LR 10/2010. Con deliberazione del Consiglio Comunale n 55 del 24/07/2018 avente per oggetto: “ Primo piano Operativo – Adozione – art. 19 LR 65/2014” è stato adottato il Piano Operativo, come emendato, comprensivo dei documenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.19 L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 8 comma 6 e art. 25 LR 10/2010. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 8/04/2019 sono stati approvati i criteri per l’esame delle osservazioni pervenute. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 8/04/2019 avente ad oggetto “Variante Piano Strutturale - Primo Piano Operativo - Esame osservazioni ed Approvazione controdeduzioni” sono state controdedotte le osservazioni alla variante al Piano Strutturale ed al Piano Operativo congiuntamente, poiché gran parte delle osservazioni si riferivano in modo unitario a entrambi gli strumenti, con la precisazione che l’approvazione definitiva fosse subordinata: per tutte le osservazioni: - agli adempimenti previsti dall'articolo 26 della L.R.