RITROVARSI ANCORA CONVERSANO-MONOPOLI Settore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Workshops of Apulian
- . WORKSHOPSOF APULIAN RED-FIGURE OUTSIDE TARANTO E. G. D. Robinson The publication of The Red-figured Vasesof Apulia brought, for the first time, structure to a massive body of information. The classification of thousands of vases, on the basis of style, has opened the way to other kinds of studies. One such study is offered here with gratitude to Alexander Cambitoglou from a colleague and former pupil. Since the beginning of the study of Apulian red-figured vases, there has been controversy over the localization of its workshops.l It is now accepted that Apulian red-figured vases were first made in Taranto; only late in the series are Apulian workshops outside Taranto postulated. It is widely recognized that one important late group, comprising the Baltimore Painter, Arpi Painter, White SaccosPainter and others, worked in Canosa or somewhere close by.2 Other painters, outside this broad stylistic grouping, may be strongly associatedwith one site, like the Laterza Painter with Salapia and the Lampas Painter with Canosa.3Caution should be exercised if, as in these two cases, a large proportion of the vases with proveniences come from one tomb.4 The acquisition of large groups of vases by one painter, who need not have been working locally, for placementin a tomb is commonin the later 4th cent. BC. The presencein : Rutigliano (1976) Tomb 24 of seven vases by the Painter of the Berlin Dancing Girl i shows that the phenomenon exists right from the beginning of the Apulian series.s The present study aims to use the stylistic groups and proveniences published in RVAp for a simple statistical survey.6 It will firstly look at the proveniences of vases in Late Apulian red-figure, to examine the possible localization of workshops in northern Apulia. -

Disciplinare Mozzarella Di Gioia Del Colle
Disciplinare Mozzarella di Gioia del Colle Articolo 1 Denominazione La Denominazione di Origine Protetta “Mozzarella di Gioia del Colle” è riservata al formaggio fresco a pasta filata che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Caratteristiche del prodotto La “Mozzarella di Gioia del Colle” è un formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da solo latte intero crudo di vacca, eventualmente termizzato o pastorizzato, ed è caratterizzato da una tecnologia di produzione basata sull’impiego di siero-innesto autoctono. Composizione chimica (valori su prodotto fresco): - lattosio ≤ 0,6 %; - acido lattico ≥ 0,20 % su s.s .; - umidità 58-68 %; - materia grassa 15-21 % su t.q.. Il prodotto ha sapore di latte delicatamente acidulo, con lieve retrogusto di fermentato/siero acido, più intenso nel formaggio appena prodotto; odore lattico, acidulo, con eventuali sfumature di burro. La “Mozzarella di Gioia del Colle” si presenta con una superficie liscia o lievemente fibrosa, lucente, non viscida, né scagliata. L’aspetto esterno è di colore bianco, con eventuali sfumature stagionali di colore paglierino. Al taglio la pasta, che deve avere consistenza elastica ed essere priva di difetti, presenta una leggera fuoriuscita di siero di colore bianco. Per il sapore le note prevalenti sono di latte delicatamente acidulo, con piacevole retrogusto di fermentato, più intenso nel formaggio appena prodotto. Le note odorose prevalenti sono di latte/yogurt bianco con eventuali sfumature di burro. Non è consentito l’impiego di conservanti e additivi/coadiuvanti. La “Mozzarella di Gioia del Colle” si presenta nelle seguenti tre diverse forme: sferoidale, di nodo e di treccia. -

Elenco Personale Docente Ed Ata Incaricati a Tempo Indeterminato Aventi Diritto Al Rapporto Di Lavoro a Tempo Parziale A.S
ELENCO PERSONALE DOCENTE ED ATA INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO AVENTI DIRITTO AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE A.S. 2018/2019 AMBITO PROVINCIA DI BARI E BAT DATA DI ORE ORE TIPO N. COGNOME NOME PROV. PROF. QUAL. C.d.C IST. SCOL. SEDE STATUS PAR TIME NASCITA SERV. DISP. RAPP. 1 ABBINANTE ROSA 27/03/1964 BA ATA AA AA IC "Capozzi Galilei" VALENZANO 30/36 6 Vert. PROSIEGUO 2 ANCONA ANTONELLA 14/06/1974 BA ATA AA AA IC"Perotti Ruffo" CASSANO 30/36 6 Vert. PROSIEGUO 3 BERLINO GRAZIA EMANUELA 03/06/1978 BA ATA AA AA 2°CD"S.G,Bosco" RUVO DI PUGLIA 25/36 11 Orizz. PROSIEGUO 4 BERNAUDO ORTENZIA 13/01/1960 BA ATA AA AA LS"Amaldi" BITETTO 30/36 0 Vert. RIENTRO A T.PIENO 5 CASSANO SERAFINA DORA 13/04/1962 BA ATA AA AA IISS"Gorjux Tridente Vivante" BARI CICLICO 0 BIENNIO 6 CLEMENTE ANGELA 30/06/1959 BA ATA AA AA IISS"Marconi Hack" BARI 18/36 18 Vert. BIENNIO 7 CORNACCHIOLI FRANCESCA RITA 22/05/1966 BA ATA AA AA IC"S.G.Bosco Venisti" CAPURSO 30/36 6 Vert. NUOVO PART TIME 8 DI CLAUDIO MARIA 03/01/1955 BA ATA AA AA IC"Pietrocola Mazzini" MINERVINO 30/36 6 Vert. NUOVO PART TIME 9 DI TERLIZZI BEATRICE 16/05/1964 BA ATA AA AA ITC"Dell'Olio" BISCEGLIE CICLICO 0 CICLICOPROSIEGUO 10 DIELLA MARIA 05/12/1975 BT ATA AA AA IPSIA"Archimede" BARLETTA 30/36 6 Vert. NUOVO PART TIME 11 FACCHINI MARIA 10/11/1964 BA ATA AA AA IISS"Galilei Ferraris" MOLFETTA 18/36 18 Vert. -

Acquaviva Delle Fonti Turi Valenzano Adelfia Conversano Conversano Corato Alberobello Altamura Binetto Bitetto Bitonto Bitritto
Molfetta Conversano BARI Corato Modugno Triggiano Mola di Bari Bitonto Noicattaro Bitetto Bitritto Capurso Polignano a Mare Palo del Colle Valenzano Cellamare Adelfia Rutigliano Binetto Conversano Sannicandro Monopoli di Bari Toritto Casamassima Turi Castellana Grotte Acquaviva delle Fonti Sammichele di Bari Altamura Putignano Alberobello Gravina in Puglia Locorotondo Gioia del Colle Noci Santeramo in Colle AGOSTO dal 14 Agosto 14/8 29/8 Serena branquartet Bitonto This is not a place for art - teatro e arte contemporanea Corato al 4 Ottobre 16/8 29/8 11/9 Spettacolo pirotecnico Locorotondo Lo cunto de li Cunti Modugno Malo et Malo - Amleto Bitetto 16/8 30/8 12/9 Boccasile e Maretti Show Sammichele di Bari Escort per caso con pupetta e le battagliere Palo del colle Tribute Show da Sinatra a Pavarotti Bitetto 17/8 30/8 12/9 Gianni Ippolito in Qui Pro Quo Corato Umberto Smaila Putignano Cover band dei Pooh Mola di Bari 17/8 30/8 12/9 Modando di Michele Errico Grumo Appula Stefania Di Pierro canta l’amore Sannicandro di Bari Festival Musicale S.O.S.2 Triggiano 17/8 31/8 13/9 Boccasile e Maretti Show Toritto Non dico bugie con Nicola Pignataro Bitetto I bambini di Vasco Toritto 17/8 13/9 SETTEMBRE Orchestra Dotti Valenzano Resto Zero Valenzano 3/9 18/8 14/9 Il cotto e il crudo con E. Solfrizzi e A. Stornaiolo Bitonto Il sindaco sono io con Gianni Colaiemma Noci Stefania Di Pierro Connection Italia-Brasil Bitritto 4/9 19/8 16/9 Na scernata terciute Cabaret Casamassima Miss Italia - La storia da Modugno a Mirigliani Cellamare Filarmonica di Bacau -
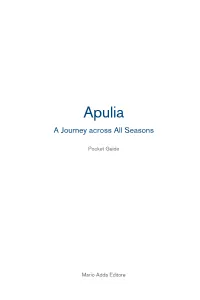
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

European Commission
C 356/10 EN Offi cial Jour nal of the European Union 21.10.2019 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2019/C 356/09) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months from the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE’ EU No: PDO-IT-02384 — 29.12.2017 PDO ( X ) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ 2. Member State or Third Country Italy 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ is a fresh stretched-curd cheese made with whole cow’s milk only and a whey starter culture. It is characterised by: a) The following chemical composition (values for fresh cheese): lactose ≤ 0,6 %, lactic acid ≥ 0,20 %, moisture 58-65 %, fat 15-21 % on a wet basis. b) A taste reminiscent of slightly soured milk, with a pleasant after-taste of fermentation or sour whey (stronger in freshly made cheese) and a sour milky aroma, sometimes accompanied by a slight hint of butter. c) The absence of preservatives, additives and processing aids. ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ has a smooth or slightly fibrous surface. -

Trasferimenti Classi Comuni E Posti Di Sostegno
SMOW5A 14-05-16PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : BARI ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016/17 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. ARCIERI NATALIA . 25/12/64 (BA) DA : BAAA07000V - 3 CD S.GIOVANNI BOSCO BISCEGLIE (BISCEGLIE) A : BAAA06900P - IICD.PROF.ARC.CAPUTI BISCEGLIE (BISCEGLIE) PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 39 2. ARDITO ANTONIA . 10/ 9/64 (BA) DA : BAAA87200D - SARNELLI-DE DONATO-RODARI (POLIGNANO A MARE) A : BAAA87100N - C.D. S.G. BOSCO - SM 2 GRUPPO (POLIGNANO A MARE) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 97 3. BERARDI FILOMENA CARMELA . 16/ 7/62 (BA) DA : BAAA882004 - SAN GIOVANNI BOSCO (MOLFETTA) A : BAAA85600G - 2 C.D."BATTISTI" - SM "PASCOLI" (MOLFETTA) PRECEDENZA: TRASFERITO D'UFFICIO NEL COMUNE PUNTI 48 4. CARBONE ANNA . 25/ 7/60 (BA) DA : BAAA201006 - S. DOMENICO SAVIO-TOMMASO FIORE (GRAVINA IN PUGLIA) A : BAAA811002 - "SANTOMASI SCACCHI" (GRAVINA IN PUGLIA) PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 63 5. CARNEVALE ANTONIA . 4/ 1/61 (BA) DA : BAAA89400A - 1 CD DE AMICIS - S.M.S."GIOVAN (ACQUAVIVA DELLE FONTI) A : BAAA895006 - 2 C.D." CAPORIZZI" - S.M.S. "L (ACQUAVIVA DELLE FONTI) PUNTI 84 (SOPRANNUMERARIO TRASFERITO CON DOMANDA CONDIZIONATA) 6. -

Bollettino Ufficiale Della Regione Puglia
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza Anno XXXIII BARI, 21 MAGGIO 2002 N. 61 Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti. Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì. Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379. Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i ver- samenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo. Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. -

Turi Nel Medioevo: Un Percorso Storiografico
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA CORSO DI LAUREA IN LETTERE EDITORIA E GIORNALISMO TESI DI LAUREA IN STORIA MEDIEVALE Turi nel Medioevo: un percorso storiografico Relatore Chiar.mo Prof. Pasquale Corsi Laureanda Anna Lizia D’Aprile Anno Accademico 2011-2012 Indice Introduzione……………………………………………………………….. 3 Capitolo I - Giovanni Bruno……………………………………………….. 8 Capitolo II - Donato Labate………………………………………………. 15 Capitolo III – Silvia De Vitis………………………………………………40 Capitolo IV – Raffaele Ruta………………………………………………. 47 Capitolo V – Pietro Antonio Logrillo………………………………............ 50 2 Capitolo VI – Maria Cioce…………………………………………............. 57 Capitolo VII – Domenico Resta………………………………………….. 60 INTRODUZIONE TURI: GENESI E CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO Turi è un comune della provincia di Bari di 12.664 abitanti. Sorge a 31 km a sud-est di Bari, a 254 metri sul livello del mare su una 3 superficie di 70,77 km2 confinante con Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Rutigliano e Sammichele di Bari. Si estende, quindi, sul territorio delle Murge, noto per la sua natura carsica e per questo ricco di doline, inghiottitoi, grotte e un'ampia idrografia sotterranea da cui si alimentano numerosi pozzi. Il paesaggio agrario di Turi è attraente: è caratterizzato, come il resto della Murgia, da lame e grotte, dislocate nelle contrade collinari intorno all’abitato, ma soprattutto da una serie di architetture in pietra e a secco che, dai muretti alle neviere, agli iazzi, alle fogge fino ai monumentali muri di recinzione, sono tutte costruzioni per lo più facenti parte dei servizi di masserie. Queste ultime, infatti, sono le protagoniste quasi assolute del paesaggio: tra le più note e ancora conservate troviamo Caracciolo, Musacco, Difesa, Orlandi, Serrone e il Santissimo che recano con sé tracce di un passato che le ha viste piene di vita e operosità. -

PUGLIA Provincia Nome Cognome Cell./Tel
PUGLIA Provincia Nome Cognome Cell./Tel. Disponibilità sul Comune di: Aldo Grosso 3392947481 Bari e limitrofi Sammichele di Bari, Turi, Acquaviva, Gioia del colle, Angelo Maggipinto 3929296357 Casamassima, Cassano delle murge, Conversano Conversano, Castellana, Polignano a mare, Monopoli, Antonio Marzico 3332584156 Rutigliano, Noicattaro, Mola di bari, Putignano Antonio Perrini 3331975925 Bitritto, Bari e dintorni 3735540705 Conversano, Mola, Rutigliano, Turi, Castellana, Cristian Astorina 3497444549 Noicattaro, Monopoli, Alberobello, Casamassima, Bari Altamura, Gravina, Santeramo, Cassano, Toritto, Filippo Ragone 3293289975 Grumo Filippo Di Venere 3383866515 Bari e dintorni Francesco Colafemmina 3482517086 Acquaviva delle Fonti Francesco Ferrante 3346595146 Conversano Francesco Morgese 3491362659 Castellana Grotte, Monopoli Gabriele Grossi 3383474552 Bari 3423183171 Giovanni Calia Altamura e tutta la provincia di Bari 3455289008 Giovanni Quarta 3288451391 Bari e dintorni Bari, Modugno, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Foggia, Canosa, Barletta, Trani, Lucia Lamonarca 3665011245 Molfetta, Bisceglie, Santo spirito, Minervino, Spinazzola, Poggiorsini, Gravina in Puglia Bari Lucia Genchi 3285330041 Bari, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Conversano Marco Silvestri 3661749116 Noci 3515566669 Mariella Brunetti Mola di Bari, Rutigliano, Conversano, Polignano 0804742988 Massimiliano De Filippis 3409473760 Bari e dintorni Ruvo di Puglia, Corato, Terlizzi, Bitonto, Palo del Michele Cantatore 3478021984 Colle, Canosa, Barletta, Trani, Bisceglie, Minervino, Bari 3493599072 Nicola Perniola Santeramo in colle e dintorni 0802481198 Paolo Cicorella 3294733608 Bari e dintorni Corato, Ruvo di Puglia, Trani, Andria, Barletta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Giovinazzo, Bari, Pierluigi Petrone 3394230293 Carbonara, Terlizzi, Molfetta, Bitonto, Gravina, Altamura, Poggiorsini, Minervino, Canosa Brindisi, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Rocco Marra 3334258351 Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre S. -

Comune Di Corato, P.Zza
C O M U N E DI C O R A T O (Prov. di Bari) Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55 del 19.03.1990, si rende noto l’esito della gara di pubblico incanto dei lavori di “Sistemazione di Via Giappone”. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Corato, P.zza Matteotti, 7 – 70033 Corato, tel. 080/9592256, fax 080/8721044. Sito internet: www. comune.corato.ba.it. Importo dell’appalto: € 150.000,00 di cui € 110.000,00 a base d’asta ed € 1.650,00 costo della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Sistema di gara: pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) della legge 109/94 e s.m. e i.. Imprese Partecipanti: 1) CONTRACTITALIA S.R.L. – Via Cervelli 9 – Bitonto; 2)CO.GE.STRA. S.R.L. – Via Magg. Galliano 46 – Andria; 3) SIESCA di LEONE D.CO & C. sas – Via Trani Km. 2.500 – Andria; 4) GECOS srl – Via A. Vespucci 84 – Andria; 5) LEONE geom. VINCENZO - Via Milano, 29 – Andria; 6) GERMINARIO GIACOMO – Via Trieste 43 – Molfetta; 7) DALESSANDRO NICOLA – Via Marconi 138 – Trinitapoli; 8) CALIA FILIPPO – Via Bachelet, 5 – Trani; 9) EDILSTRADE srl – Via Cuoco, 5 – Andria; 10) M & C. Soc. Coop. a r.l. – Via G. 1 Bovio, 122 – Trani; 11) DEL GIUDICE LUIGI – Via Duca D’Aosta 89 – Andria; 12) F.LLI CASSETTA s.n.c. – Via F. Redi, 8 – Andria; 13) CASSETTA VINCENZO – Via C. -

Conversano-Gigliozzi.Pdf
Conversano nel Medioevo Storia, arte e cultura del territorio tra IX e XIV secolo Saggi di storia dell’arte Campisano Editore Volume pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e dell’Università della Calabria, Dipartimento di Studi Umanistici. I testi contenuti in questo volume sono stati sottoposti ad un procedimento di peer review In copertina, lastra con leoni proveniente da San Benedetto, particolare. Conversano, Museo Civico Archeologico Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore. Progetto grafico Gianni Trozzi © copyright 2018 by Campisano Editore Srl 00155 Roma, viale Battista Bardanzellu, 53 Tel +39 06 4066614 [email protected] www.campisanoeditore.it isbn 978-88-85795-12-9 Atti Conversano.indb 2 03/12/2018 16:44:35 Conversano nel Medioevo Storia, arte e cultura del territorio tra ix e xiv secolo a cura di Gaetano Curzi Maria Antonella Madonna Stefania Paone Maria Cristina Rossi Campisano Editore Atti Conversano.indb 3 03/12/2018 16:44:35 Atti Conversano.indb 4 03/12/2018 16:44:35 Indice p. 7 Le ragioni del convegno Maria Antonella Madonna, Maria Cristina Rossi 9 Il territorio di Conversano nell’Alto Medioevo Daniela Uva 23 La cattedrale di Conversano in età angioina Maria Teresa Gigliozzi 31 Decorazioni esterne a mosaico in Terra di Bari tra xi e xii secolo: il caso di San Benedetto a Conversano Margherita Tabanelli 45 Il chiostro piccolo di San Benedetto a Conversano.