Studi Interculturali 11 (3, 2016)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dayah and Meunasah in Aceh: Reform in Local Context
J U R N A L T A T S Q I F P ISSN: 1829-5940 Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan E ISSN: 2503-4510 Volume 19, No. 1 (June) 2021 Site: http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tatsqif Email: [email protected] DAYAH AND MEUNASAH IN ACEH: REFORM IN LOCAL CONTEXT Moch. Khafidz Fuad Raya Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia [email protected] Abstract The history of Islamic education in the early 20th century led to various changes, especially the emergence of madrasas as an Islamic schooling system. Traditional Islamic educational institutions inevitably have to harmonise and open themselves to transformation, even though they initially experienced opposition. Using a qualitative approach with a narrative documentation method based on historical texts and observations in several Islamic educational institutions in Aceh, this article focuses on revealing the history of the dayah and meunasah as a traditional Acehnese Islamic educational institution that underwent some fundamental changes. The results found: First, the existence of the dayah is more long-term than the meunasah even though both forms of this institution are rooted in the same ideological principles with different patterns, seen from the early 20th century until implementing sharia law in Aceh after the Helsinki peace agreement, the dayah was still existed by maintaining its institutional form. Second, the emergence of madrasas as a formation of the government’s political policy on the social conditions of the people that occurred has provided space for traditional Islamic educational institutions (such as the dayah) to open themselves to including general subjects, although this second result has led to struggles; Third, there is a contestation between dayah, Islamic schools, and madrasas, with public schools driven by traditionalist and modernist groups in maintaining their existence. -

Ibadi (And Secondarily the So-Called “Sufri”) Connections to the Early Umayyad Amirs of Spain Have Not Been Well Understood
Project: Ibadi (and secondarily the so-called “Sufri”) connections to the early Umayyad Amirs of Spain have not been well understood. This paper re- examines Ibadi, Sufri and Spanish-Umayyad relations in order to prove that strong economic interests underlay the political ties that developed between these groups. The Ibadiyya are an Islamic sectarian group – related to the Kharijites – who controlled the Rustumid Empire, centered at Tahert (in present day Algeria), in the 2-3rd/8-9th centuries. The Sufriyya were likewise Kharijites who controlled a smaller Empire – the Midrarids – located in Sijilmassa (in present day Morocco). The research begins with the fairly well documented evidence for the political ties between Ibadis and Spanish Umayyads. This material remains interesting in and of itself for the simple fact that the Ibadiyya formed from the quietist Kharijites of Basra (around 720-740CE) and remained hostile to the Umayyad regime: when they had the capacity they frequently revolted against the Umayyads. In fact, the Akhbar Majmua describes the North African uprisings of the 740s CE as “Ibadi” or “Sufri” in inspiration; and these uprising spread to Spain. For this reason it is a bit surprising to find that only a few decades later – during the reign of the Umayyad Amir al-Hakam b. Hisham (al-Hakam I), a Rustumid named Muhammad b. Sa?id b. Muhammad b. ‘Abd al-Rahman b. Rustum - that is, the great-grandson of the founder of the Rustumids - became a confidant of ‘Abd al-Rahman II when he was prince in Medina-Sidonia (Shadhuna). Muhammad lived near Algeciras to be close to ‘Abd al-Rahman II, and when ‘Abd al-Rahman became the Amir, he brought Muhammad to Cordoba and employed him in the hijaba and the Wazirate. -

Fatima Es Fatima
Fatima es Fatima En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso Fatima es Fatima 'Ali Shariati Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P) - 1 - ‘Ali Shariati Título: Fatima es Fatima Autor: ‘Ali Shariati Editor de la versión original impresa: Al Hoda Nº 29 Shahid Hashemifar, St. Vali-E-Asr Ave Teherán 14155 República Islámica de Irán Publicación de la presente edición: Enero de 2004 Edición: Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P) www.biab.org [email protected] La Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P) es integrante de la Red Ahlul Bait (P) - 2 - Fatima es Fatima ‘Ali Shariati (1933-1977) Nacido en el tradicional pueblo de Mazinan, al borde del tórri- do Kavir, el extenso desierto central de Irán, en el Jorasan, la histó- rica provista nororiental de Irán, ‘Ali Shariati, el ideólogo de la Revolución Islámica de Irán, creció en circunstancias que fueron humildes materialmente pero ricas en la vida intelectual de la anti- gua cultura de Irán. Su primer maestro fue su padre, Ustad (maes- tro, profesor) Muhammad Taqi Shariati, cofundador del Centro para la Publicación de las Verdades Islámicas y el preparador e inspira- dor de cientos de revolucionarios en el nombre del Islam. Los antecedentes de pobreza de Shariati entre gente pisoteada de su tierra nativa y de su distrito le dio la experiencia del sufri- miento popular, mientras que la atmósfera cultural en la que creció le dio disciplina para analizar el estado de colonización que pesaba sobre su gente, en el contexto de la historia, de la filosofía y sabidu- ría tradicionales y de las ciencias de la presente generación. -

Bektashi Order - Wikipedia, the Free Encyclopedia Personal Tools Create Account Log In
Bektashi Order - Wikipedia, the free encyclopedia Personal tools Create account Log in Namespaces Views Article Read Bektashi OrderTalk Edit From Wikipedia, the freeVariants encyclopedia View history Main page More TheContents Bektashi Order (Turkish: Bektaşi Tarikatı), or the ideology of Bektashism (Turkish: Bektaşilik), is a dervish order (tariqat) named after the 13th century Persian[1][2][3][4] Order of Bektashi dervishes AleviFeatured Wali content (saint) Haji Bektash Veli, but founded by Balim Sultan.[5] The order is mainly found throughout Anatolia and the Balkans, and was particularly strong in Albania, Search BulgariaCurrent events, and among Ottoman-era Greek Muslims from the regions of Epirus, Crete and Greek Macedonia. However, the Bektashi order does not seem to have attracted quite as BektaşiSearch Tarikatı manyRandom adherents article from among Bosnian Muslims, who tended to favor more mainstream Sunni orders such as the Naqshbandiyya and Qadiriyya. InDonate addition to Wikipedia to the spiritual teachings of Haji Bektash Veli, the Bektashi order was later significantly influenced during its formative period by the Hurufis (in the early 15th century),Wikipedia storethe Qalandariyya stream of Sufism, and to varying degrees the Shia beliefs circulating in Anatolia during the 14th to 16th centuries. The mystical practices and rituals of theInteraction Bektashi order were systematized and structured by Balım Sultan in the 16th century after which many of the order's distinct practices and beliefs took shape. A largeHelp number of academics consider Bektashism to have fused a number of Shia and Sufi concepts, although the order contains rituals and doctrines that are distinct unto itself.About Throughout Wikipedia its history Bektashis have always had wide appeal and influence among both the Ottoman intellectual elite as well as the peasantry. -
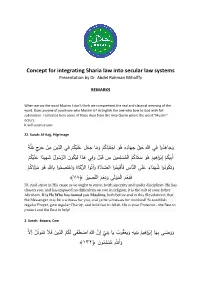
Concept for Integrating Sharia Law Into Secular Law Systems وَجَاهِدُوا فِي َّللاهِ
Concept for integrating Sharia law into secular law systems Presentation by Dr. Abdel Rahman Mihalffy REMARKS When we say the word Muslim I don’t think we comprehend the real and classical meaning of the word. Does anyone of you know who Muslim is? In English the one who bow to God with full submission. I collected here some of those Ayas from the Holy Quran where the word “Muslim” occurs. It will surprise you: 22. Surah: Al-Hajj, Pilgrimage ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِه َوَجاهُدوا في هَّللا َح هق جَهاده ُهَو ا ْجتََبا ُكْم َوَما َجَع َل َعَلْيُكْم في ال دي ِن م ْن َحَرٍج مل َة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ن ِ أَبيُكْم إْبَارهيَم ُهَو َسهما ُكُم اْل ُم ْسلمي َن من َقْب ُل َوفي َهَذا لَيُكوَ الهرُسوُل َشهيًدا َعَلْيُكْم ِ ِ ه ِ ِ ِ َوتَُكوُنوا ُشَهَداء َعَلى الهناس َفأَقي ُموا ال هصََلةَ َوآتُوا الزَكاةَ َوا ْعتَص ُموا با هَّلل ُهَو َمْوََل ُكْم َفِنعم اْلموَلى وِنعم الهن ِصير ﴿٧٨﴾ ْ َ َْ َ ْ َ ُ 78. And strive in His cause as ye ought to strive, (with sincerity and under discipline). He has chosen you, and has imposed no difficulties on you in religion; it is the cult of your father Abraham. It is He Who has named you Muslims, both before and in this (Revelation); that the Messenger may be a witness for you, and ye be witnesses for mankind! So establish regular Prayer, give regular Charity, and hold fast to Allah. He is your Protector - the Best to protect and the Best to help! 2. -

Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia
ISLAMIC STUDIES AND ISLAMIC EDUCATION IN CONTEMPORARY SOUTHEAST ASIA i ii ISLAMIC STUDIES AND ISLAMIC EDUCATION IN CONTEMPORARY SOUTHEAST ASIA Editors KAMARUZZAMAN BUSTAMAM-AHMAD PATRICK JORY YAYASAN ILMUWAN iii Perpustakaan Negara Malaysia Cataloguing-In-Publication Data Islamic studies and Islamic education in contemporary Southeast Asia / editors: Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Patrick Jory ISBN 978-983-44372-3-7 (pbk.) 1. Islamic religious education--Southeast Asia. 2. Islam--Education--Southeast Asia. I. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. II. Jory, Patrick. 297.77 First Printed 2011 © 2011 Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad & Patrick Jory Publisher: Yayasan Ilmuwan D-0-3A, Setiawangsa Business Suites, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur, Malaysia. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means – for example, electronic, photocopy, recording – without prior written permission of the publisher. The only exception is brief quotations in printed review. The opinions expressed in this publication is the personal views of the authors, and do not necessary reflect the opinion of the publisher. Layout and cover design: Hafizuldin bin Satar Font: Goudy Old Style Font size: 11 pt Printer: Gemilang Press Sdn Bhd iv ACKNOWLEDGEMENTS his book grew out of a three-day workshop jointly held by the Regional Studies TProgram, Walailak University, and the Department of Cross-Cultural and Re- gional Studies, Copenhagen University, in Nakhon Si Thammarat, southern Thai- land, in 2006. The theme of the workshop was, “Voices of Islam in Europe and Southeast Asia”. Its aim was to gather leading scholars in the fields of Islamic Stud- ies from diverse disciplinary backgrounds to discuss contemporary developments in the study of Islam and Muslim societies in these two regions. -

Sunni Myth of Love & Adherence to the Ahlulbayt (As)
Sunni myth of love & adherence to the Ahlulbayt (as) Work file: sunni_myth_of_loving_ahlulbayt.pdf Project: Answering-Ansar.org Articles Revisions: No. Date Author Description Review Info 1.0.0 31.08.2007 Answering-Ansar.org Created 1.0.1 07.09.2007 Answering-Ansar.org Spelling fixes. Copyright © 2002-2007 Answering-Ansar.org. • All Rights Reserved Page 2 of 72 Contents 1.I NTRODUCTION ..................................................................................................................... 3 2.CHAPTER TWO: THE VERDICT OF RASULULLAH (S) WITH REGARDS TO THE L OVERS AND THE ENEMIES OF THE AHL'UL BAYT (AS) ............................................ 4 3.C HAPTER THREE: NASIBISM IN THE ROOTS AHLE SUNNAH .............................. 10 4.C HAPTER FOUR: KHARJISM IN THE ROOTS OF AHLE SUNNAH ......................... 41 5.CHAPTER FIVE: THE BLASPHEMOUS VIEWS OF SOME SUNNI SCHOLARS A BOUT THE IMAMS OF AHLULBAYT [AS] ...................................................................... 52 6.C HAPTER SIX: CONCLUSION .......................................................................................... 69 7.C OPYRIGHT .......................................................................................................................... 72 Copyright © 2002-2007 Answering-Ansar.org. • All Rights Reserved Page 3 of 72 1. Introduction The inspiration behind this article, was not to spread hatred against or belittle the Ahle Sunna, on the contrary we were forced to write it to address the frequent attacks and acerbic remarks by the -

The Ibāḍī Traders of Bilād Al-Sūdān
The American University in Cairo School of Humanities and Social Sciences The Ibāḍī Traders of Bilād al-Sūdān. A Thesis Submitted to The Department of Arab & Islamic Civilizations In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts By J.H. van Riel Under the supervision of Dr. C. Gomez-Rivas May 2012 The American University in Cairo Contents. • Introduction. 2. • Chapter 1: The Ibāḍī community in the Maghreb. 12. • Chapter 2: The early Ibāḍī community in Basra and its trade connections. 24. • Chapter 3: The Ibāḍī community within trans-Saharan trade networks. 37. • Chapter 4: The Ibāḍī impact on trans-Saharan trade. 54. • Conclusion. 69. • Bibliography. 74. 1 Introduction. The great Saharan desert, the biggest desert on earth (measuring approximately 9,000,000 km2), has always been seen as a natural and formidable barrier between the people living to its north and the people living to its south. It may seem as a barrier, but in reality it was not so. Although the Sahara seems daunting – it stretches all the way from Mauritania to the Red Sea (approximately 5,600km) and from the Libyan Sirtica to Lake Chad and the River Niger (approximately 2,000km) – it is lined with oases that make it possible to hop from one oasis to the next. Therefore it has always been possible to cross the Sahara, as did numerous travelling scholars and men of religion, raiding warriors and profit-seeking traders carrying ideas, influences, warfare and goods and commodities into and across the desert. The romantic images of the Sahara show it as a vast mass of sand dunes, this is incorrect; only one-fifth of the Sahara is covered with these sand dunes and only one-fifteenth of the Sahara consists of the dreaded and avoided “deserts within desert”, this is considered to be the “land of fear” due to its deep sand; the Libyan Desert, the Téneré of north-East Niger and the great Ergs of the Algerian Sahara. -
La Tradición Jurídica Islámica Desde Los Orígenes Del Islam Al Modelo Político-Religioso Califal: Su Influencia E Interacción Cultural En La Europa Medieval
ARTIGOS anuario 1.qxd 15/1/06 19:15 Página 577 LA TRADICIÓN JURÍDICA ISLÁMICA DESDE LOS ORÍGENES DEL ISLAM AL MODELO POLÍTICO-RELIGIOSO CALIFAL: SU INFLUENCIA E INTERACCIÓN CULTURAL EN LA EUROPA MEDIEVAL Gloria M. Morán García La rivalidad que se desata desde finales el siglo VII entre el cristianismo y el islam enfrentará a dos concepciones político-religiosas monoteístas, desde la ideología universalista-teísta que enseña en ambas la posesión de la verdad espiritual plena, y cuya interacción llevará a la confrontación militar, desde la consideración del otro como enemigo e “infiel” a esa verdad, desatándose la guerra por la superioridad de una u otra como civilización dominante en la lucha por el poder político-religioso. Durante la hegemonía de la civilización islámica, que se inicia en el siglo VIII hasta el siglo XIII, la Europa cristiana se verá aislada y disminuirá enormemente su influjo evangelizador al restringir la expansión religiosa del cristianismo en los continentes de África y Asia, que serán en buena parte islamizados. A la vez, ese aislamiento europeo permitirá con- solidar y definir dos modelos de cristianismo, el bizantino y el romano, claves para la identificación cultural de Europa en la Edad Media como la cristiandad, en la que el papado y las monarquías de los reinos medievales tendrán un papel determinante en su lucha contra el islam, y Bizancio finalmente perderá su batalla frente al islam turco-oto- mano que emerge en el siglo XIV sometiendo políticamente a buena parte de la Europa oriental hasta el siglo XIX. El islam tendrá una fuerza arrolladora, y mientras la consolidación religiosa y política del cristianismo requirió varios siglos para ello, la consolidación político-reli- giosa del islam tendrá lugar en cuestión de décadas. -
Copyright by Christine Danielle Baker 2013
Copyright by Christine Danielle Baker 2013 The Dissertation Committee for Christine Danielle Baker certifies that this is the approved version of the following dissertation: Challenging the Shiʿi Century: the Fatimids (909-1171), Buyids (945-1055), and the Creation of a Sectarian Narrative of Medieval Islamic History Committee: ___________________________________________ Denise A. Spellberg, Supervisor ___________________________________________ Kamran Scot Aghaie ___________________________________________ A. Azfar Moin ___________________________________________ Alison Frazier ___________________________________________ Stephennie Mulder Challenging the ‘Shiʿi Century’: the Fatimids (909-1171), Buyids (945-1055), and the Creation of a Sectarian Narrative of Medieval Islamic History By Christine Danielle Baker, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin August 2013 For mom and Frank Acknowledgements This dissertation was produced over the course of several years, during which I was fortunate to have the support and assistance of many advisors, colleagues, friends, and family. I must begin by expressing my sincere gratitude to my advisor, Denise Spellberg, who patiently guided my inquiries without ever attempting to force me in a direction that was not mine. I know that, without her guidance, support, and careful comments on my many drafts and revisions, I would have never completed this dissertation. I must also thank the other members of my committee. Kamran Aghaie has always dealt well with my fits of enthusiasm and anxiety and was in his office when I needed someone to listen to my developing thoughts about early and medieval Shiʿi identity. -
![Abrahamic Religions [Edit]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5845/abrahamic-religions-edit-6275845.webp)
Abrahamic Religions [Edit]
Abrahamic religions [edit] Main article: Abrahamic religions A group of monotheistic traditions sometimes grouped with one another for comparative purposes, because all refer to a patriarch named Abraham. Babism [edit] Main article: Bábism • Azali Bahá'í Faith [edit] Main article: Bahá'í Faith Christianity [edit] Main article: Christianity See also: List of Christian denominations Catholicism Main article: Catholic Church Protestantism Main article: Protestantism Eastern Orthodoxy Main article: Eastern Orthodox Church Other Eastern Churches • Oriental Orthodox Church • Assyrian Church of the East Other groups [edit] • Bible Student movement • Christian Universalism • Latter Day Saint movement • Nontrinitarianism • Swedenborgianism • Unitarianism Druze [edit] Main article: Druze Gnosticism [edit] Main article: Gnosticism See also: List of Gnostic sects Christian Gnosticism • Ebionites • Cerdonians • Marcionism (not entirely Gnostic) • Colorbasians • Simonians Early Gnosticism • Borborites • Cainites • Carpocratians • Ophites • Hermeticism Medieval Gnosticism • Cathars • Bogomils • Paulicianism • Tondrakians Persian Gnosticism • Mandaeanism • Manichaeism • Bagnolians Syrian-Egyptic Gnosticism Main article: Syrian-Egyptic Gnosticism • Sethians • Basilidians • Valentinians • Bardesanites Islam [edit] Main article: Islam See also: Islamic schools and branches Kalam Schools Main article: Kalam • Ash'ari • Kalam • Maturidi • Murji'ah • Mu'tazili Kharijite Main article: Kharijite • Ibadi (Only surviving sect) • Azraqi • Haruriyya • Sufri Shia -

Studies in Ibadhism
STUDIES IN IBADHISM by Dr. Amr K. al-Nami Open Mind First in Open-Books Paperback 2007 published by Open Mind http://open-books.blogspot.com/ to contact: [email protected] ©2007 by Open Mind. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,in any form or by means electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without prior written permission of the publisher. Formatted using Open Office.org 3 ACKNOWLEGEMENTS Sincere thanks are extended to Professor R.B. Sergeant for many helpful suggestions, discussions and criticism, which he constantly rendered throughout the period in which he supervised the writing of this research. Special thanks are due to many Ibadhi friends and scholars in the Ibadhi communities of North Africa for their hospitality and unrestrained help. I am extremely grateful to the owners of private collections of Mss. for free access to their valuable libraries without which this work would have been impossible. Thanks are also due to Sheikh Muhammad al-Salimi, and Salim al-Harithi of Oman for lending me many valuable manuscripts, as well as all other friends who have helped me in one way of another. I would also like to thank the Libyan Ministry of Education for providing me with a grant for the duration of this research, and the Faculty of Arts, University of Libya, for granting me a study leave in which to undertake this work. My thanks are also due to Pr. Omar Shaibani, the president of the Libyan Unv, Dr. Mansur Kikhya, Dean of the faculty of Arts and Mr.