Tesi Marco Martino4def
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

I Laburisti Cristiani E I Democristiani
I LABURISTI CRISTIANI E I DEMOCRISTIANI di Giovanni Bianchi Eremo e Metropoli Saggi Nota sul Copyright: Tutti i diritti d’autore e connessi alla presente opera appartengono all’autore Giovanni Bianchi. L’opera per volontà degli autori e dell’editore è rilasciata nei termi- ni della licenza: Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/ Progetto grafico e copertina: www.walterferrario.it I lAburIstI CrIstiani e I demoCrIstiani di Giovanni bianchi Sesto San Giovanni, agosto 2014 s’alza il dolore e tenerezza scende: senza Confiteor non si sale altare Clemente Rebora, Curriculum Vitae pag 8 Sommario Alla fine di un ciclo 13 Nella stagione del disordine 13 Exit strategy? 14 Il riformismo cattolico-democratico 17 La profezia di De Luca 18 L’Ulivo come occasione (mancata) 20 Dopo Todi 22 Un Paese di “diversamente credenti” 27 Il PD come luogo ideologico 30 Gratuità e militanza 31 Crucialità della testimonianza 33 La grande fuga 36 I temi del ritorno 38 Partito e parte 40 Un punto di vista sulla storia 42 Il Paese oggi 49 Lavoro e cittadinanza 49 Sviluppo e lavoro 52 Lavoro e diritti 53 La sfida della povertà 55 pag 9 Il magistero di Alcide De Gasperi 57 La distanza 57 Le ragioni della memoria 60 Lo stile 61 Il mito degasperiano 62 Le lettere 64 La dottrina sociale della Chiesa 65 Le tre forme 66 Il popolarismo 67 Il laburismo cristiano 68 Lo Stato non crea la società 70 Le difficoltà 72 Il rapporto -

Segretari E Leader Del Socialismo Italiano
* SEGRETARI E LEADER DEL SOCIALISMO ITALIANO INTRODUZIONE Il socialismo è istinto, che diviene coscienza e si tramuta in volontà. Claudio Treves Mi sono chiesto più volte perché, qualche anno fa, decisi di intraprendere questo lavoro; la risposta che mi sono dato è stata sempre la stessa: <<Per soddisfare una mia curiosità>>; ed ora posso aggiungere, dal momento che ho deciso di pubblicarne i risultati, <<e quella di qualche altro>>. Questa curiosità era principalmente diretta a conoscere i nomi e alcune informazioni sui segretari nazionali, o meglio su coloro in genere che, nel corso di un secolo, avevano diretto e rappresentato al massimo livello il partito socialista italiano, in cui avevo militato dal 1957 al suo scioglimento nel 1994. Nel corso del lavoro sono “incappato” in alcuni fatti poco noti o dimenticati ed ho deciso di inserirli nel testo, così come ho deciso di estendere la ricerca ai partiti e movimenti socialisti derivati dal ramo principale, intendendo per ramo principale il PSI e per socialisti quei raggruppamenti che si sono proclamati tali, prescindendo dal fatto se l’aggettivo sia stato da loro appropriatamente utilizzato o inopinatamente usurpato. Mi preme anzitutto precisare che inizialmente il ruolo di un segretario di partito era appunto quello di fare il… segretario; egli aveva cioè il compito, di natura prevalentemente burocratica, di mantenere i contatti con e fra gli associati. Come appunto avveniva nella Prima Internazionale, dove c’era un segretario per l’Italia, un altro per la Germania, e così via. A livello internazionale il “salto di qualità” si ebbe nell’Unione sovietica nel 1922, quando nel Partito bolscevico (comunista), il cui leader indiscusso era Lenin, allora capo del governo (più precisamente: Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo), senza darvi troppa importanza, fu eletto segretario Giuseppe Stalin. -
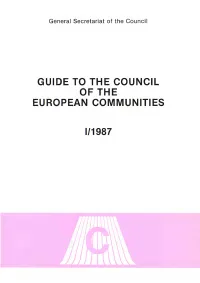
Guide to the Council of the European Communities : I/1987
General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1/1987 General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, April 1987 This publication is also available in: ES ISBN 92-824-0421-8 DA ISBN 92-824-0422-6 DE ISBN 92-824-0423-4 GR ISBN 92-824-0424-2 FR ISBN 92-824-0426-9 IT ISBN 92-824-0427-7 NL ISBN 92-824-0428-5 PT ISBN 92-824-0429-3 Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1987 ISBN 92-824-0425-0 Catalogue number: BX-48-87-953-EN-C © ECSC-EEC-EAEC, Brussels ■ Luxembourg, 1987 Printed in the Federal Republic of Germany CONTENTS pages Council of the European Communities 5 Presidency of the Council 7 Conference of Representatives of the Governments of the Member States 8 List of Representatives of the Governments of the Member States who regularly take part in Council meetings 9 Belgium 10 Denmark 12 Germany 13 Greece 16 Spain 19 France 21 Ireland 23 Italy 25 Luxembourg 29 Netherlands 30 Portugal 32 United Kingdom 34 Permanent Representatives Committee 37 COREPER II 38 COREPER I 40 Article 113 Committee 42 Special Committee on Agriculture 42 Standing Committee on Employment 42 Standing Committee on Uranium Enrichment (COPENUR) 43 Scientific and Technical Research Committee (CREST) 43 Energy Committee 44 Education Committee 44 Select Committee on Cooperation Agreements between the Member States and third countries 45 Working Parties 45 Permanent Representations 47 Belgium -

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Cerimoniale
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Cerimoniale - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA ******************************** venerdì 1 maggio 1987 (partenza dal Quirinale; ore 10,15) - Palazzo Civiltà del Lavoro all'EUR - Intervento alla cerimonia per la consegna delle Stelle al merito dei nuovi Maestri del Lavoro. (Termine: ore 11,15 circa) PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Cerimoniale - Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia per la consegna delle Stelle al merito ai nuovi -Maestri del Lavoro. Roma - Palazzo della Civiltà del Lavoro all'EUR Venerdì 1 maggio 1987 10,15 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina). (Corteo privato: vedi allegato) 10,30 Il Capo dello Stato giunge al Palazzo della Civiltà del Lavoro all'EUR. All'ingresso si trovano a riceverlo: i Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, il Prefetto di Roma, il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ed il Presidente della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia nonché il Presidente della Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. IL Presidente della Repubblica, ricevuto l'omaggio delle Autorità, accede nella Sala, dove prende posto nella poltrona centrale della prima fila, avendo a destra ed a sinistra le principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze. Ha inizio la cerimonia: - brevi parole del Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Sen. Dott. Alfredo Diana; - brevi parole del Presidente dell'Associazione Nazionale La- voratori Anziani, Dott. Gilberto Bernabei; - discorso del Presidente della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, Maestro del Lavoro Letterio Brunaccini; - discorso del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Dott. -

Luigi Granelli: Un Libro Di Ricordi
Luigi Granelli: un libro di ricordi a cura di Rita Batosti Granelli e Adriana Guerini Granelli edizioni Luigi Granelli nasce a Lovere l’1 marzo 1929. Ha lavorato alle acciaierie Italsider come operaio specializzato sino al 1952. Nel 1953 partecipa alla fondazione della corrente La Base all’interno della Democrazia Cristiana e nel 1957 entra per la prima volta nella Direzione Centrale del partito, da cui uscirà nel 1991. Nel 1958 si candida come deputato alle elezioni politiche ma non viene eletto, a causa anche dell’opposizione della Curia milanese guidata allora dal Cardinal Montini, il futuro Papa Paolo VI. Alle successive elezioni decide di non candidarsi. Dal 1960 al 1967 è presidente dell’INAPLI, unico ente nazionale di diritto pubblico rivolto all’addestramento dei lavoratori dell’industria. Nel 1965 viene eletto consigliere comunale a Milano dove sarà, per quattro anni, capogruppo consigliare della DC. Deputato dal 1968, rieletto nel 1972 e 1976. Membro della Commissione Esteri e Bilancio della Camera. Ha fatto parte della Commissione Vigilanza sulla RAI-TV. Sottosegretario agli Esteri dal 1973 al 1976, si è occupato in particolare dell’emigrazione, organizzando la prima Conferenza Nazionale dell’Emigrazione (24 febbraio-1 marzo 1975). Parlamentare europeo dall’ottobre 1976 al giugno del 1979 e capo della delegazione italiana. Senatore nel collegio di Cantù nel 1979. Membro della Commissione Esteri del Senato, della Giunta per gli Affari Europei, e della Commissione Antimafia. Senatore nel Collegio di Vimercate nel 1983, nel 1987, e nel 1992. Ha continuato a far parte della Commissione Esteri del Senato ed è stato membro della Commissione bicamerale sulle Stragi in cui ha diretto il gruppo di indagine sul sequestro e sull’assassinio dell’on. -

Download Quaderno 030.Pdf
I Quaderni del Ferrari 30 La “sinistra (cattolica) modenese” Cronache di una singolare esperienza politica di base a cura di Dario Mengozzi I Quaderni del Ferrari La “sinistra (cattolica) modenese” Cronache di una singolare esperienza politica di base a cura di Dario Mengozzi La pubblicazione de “I Quaderni del Ferrari” ha per obiettivo la diffusione di studi, ricer- che e contributi di analisi sulla realtà sociale della provincia di Modena, la cui evoluzione è tenuta sotto costante e attenta osservazione dal Centro culturale Francesco Luigi Ferrari. In particolare si intendono soddisfare tre ordini di esigenze: - favorire un’ampia circolazione dei risultati e delle riflessioni delle proprie ricerche e di quelle realizzate in collaborazione con terzi; - sviluppare un dialogo con quanti seguono i temi trattati, non solo per migliorare la conoscenza della realtà sociale, ma soprattutto per verificare l’impatto degli stru- menti dell’intervento sociale; - proporre un quadro non generico della realtà sociale modenese finalizzato a sensibi- lizzare non solo l’opinione pubblica ma soprattutto gli amministratori locali sui setto- ri vitali dell’intervento pubblico. Invito alla lettura La pubblicazione del lavoro di Dario Mengozzi si inserisce tra le iniziative che il nostro Centro culturale propone nel 75° anniversario della morte di Francesco Luigi Ferrari, avvenuta a Parigi nel 1933. Nella celebrazione di questo evento si è scelto di mettere in luce la forza innovativa e la passione per l’uomo che hanno caratterizzato e unifi- cato l’impegno pubblico e la dimensione privata della vita di Ferrari e di proporre un percorso di confronto, dibattito e ricerca il cui motivo conduttore è ripreso dal tema che dà il titolo al progetto, Il potere dell’amore. -

Governo Andreotti
I 63 Governi Italiani dal 1943 al 2001 EbookCafe XIV Legislatura 2° Governo Berlusconi (12 giugno 2001) XIII Legislatura 2° Governo Amato 1° Governo D'Alema (9 maggio 1996 - 11 giugno 2001) 2° Governo D'Alema 1° Governo Prodi XII Legislatura 1° Governo Dini (15 aprile 1994 - 8 maggio 1996) 1° Governo Berlusconi XI Legislatura 1° Governo Ciampi (23 aprile 1992 - 14 aprile 1994) 1° Governo Amato X Legislatura 7° Governo Andreotti 1° Governo De Mita (2 luglio 1987 - 22 aprile 1992) 6° Governo Andreotti 1° Governo Goria IX Legislatura 6° Governo Fanfani (12 luglio 1983 - 1° luglio 1987) 2° Governo Craxi 1° Governo Craxi VIII Legislatura 5° Governo Fanfani 1° Governo Forlani (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983) 2° Governo Spadolini 2° Governo Cossiga 1° Governo Spadolini 1° Governo Cossiga VII Legislatura 5° Governo Andreotti (5 luglio 1976 - 19 giugno 1979) 4° Governo Andreotti 3° Governo Andreotti VI Legislatura 5° Governo Moro 4° Governo Rumor (25 maggio 1972 - 4 luglio 1976) 4° Governo Moro 2° Governo Andreotti 5° Governo Rumor V Legislatura 1° Governo Andreotti 2° Governo Rumor (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972) 1° Governo Colombo 1° Governo Rumor 3° Governo Rumor 2° Governo Leone IV Legislatura 3° Governo Moro 1° Governo Moro (16 maggio 1963 - 14 maggio 1968) 2° Governo Moro 1° Governo Leone III Legislatura 4° Governo Fanfani 2° Governo Segni (12 giugno 1958 - 15 maggio 1963) 3° Governo Fanfani 2° Governo Fanfani 1° Governo Tambroni II Legislatura 1° Governo Zoli 1° Governo Fanfani (25 giugno 1953 - 11 giugno 1958) 1° Governo Segni 1° Governo -

I Segretari Della CGIL: Da Luciano Lama a Bruno Trentin a Cura Di ILARIA ROMEO 2013
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO I segretari della CGIL: da Luciano Lama a Bruno Trentin a cura di ILARIA ROMEO 2013 I segretari della CGIL: da Luciano Lama a Bruno Trentin della CGIL: da Luciano Lama a Bruno I segretari Manifestazione per le riforme e lo sviluppo del Mezzogiorno, Roma 30 mag. 1971. Luciano Lama a Piazza del Popolo PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO STRUMENTI CXCVII CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO I segretari della CGIL: da Luciano Lama a Bruno Trentin a cura di Ilaria Romeo MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI 2013 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Servizio III - Studi e ricerca Direttore generale per gli archivi: Rossana Rummo Direttore del Servizio III: Mauro Tosti Croce Cura redazionale: Maria Teresa Piano Mortari © 2013 Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi ISBN 978-88-7125-308-4 Vendita: Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato Piazza Verdi 10, 00198 Roma - [email protected] Finito di stampare da Antica Tipografi a dal 1876 nel mese di dicembre 2013 SOMMARIO Prefazione, di Adolfo Pepe IX Introduzione di Fabrizio Loreto XV Nota archivistica di Ilaria Romeo e Giovanna Bosman XLV Inventario 1 Luciano Lama 3 Antonio Pizzinato 77 Bruno Trentin 157 Fotografi co 201 Indici 203 Tavole foto 237 Inventari a cura di Ilaria Romeo, Gianni Venditti e Patrizia Ventura con il coordinamento di Teresa Corridori. Prezioso e insostituibile lavoro di ausilio all’opera degli schedatori è sta- to prestato da Giorgio Mercanti. PREFAZIONE L’attuale pubblicazione che contiene l’Inventario delle carte tratte dai fondi personali dei tre segretari generali della Cgil, che copre so- stanzialmente il cruciale ventennio degli anni settanta e ottanta, costitu- isce senza dubbio un pregevole contributo al riordino e alla sistemazione complessiva dell’archivio della Cgil, archivio per molti versi indispensa- bile per lo storico dell’Italia repubblicana. -

Gli Anni Di Craxi
GLI ANNI DI CRAXI Democristiani, cattolici e Chiesa negli anni di Craxi a cura di Gennaro Acquaviva, Michele Marchi e Paolo Pombeni Marsilio © 2018 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia Prima edizione: giugno 2018 ISBN 978-88-317-2942-0 www.marsilioeditori.it Realizzazione editoriale: passaggio a sud-est INDICE 9 Nota di Gennaro Acquaviva 13 Introduzione di Michele Marchi i cattolici, la dc, la politica, la riforma 21 La «questione cattolica» e la sfida socialista di Craxi di Paolo Pombeni 77 Chiesa, dc e politica nel post Concilio italiano di Guido Formigoni 107 Il progetto moroteo per la stabilizzazione dell’esperienza politica dei cattolici di Piero Craveri 123 L’annullamento del ruolo politico del cattolicesimo sociale. Ragioni e conseguenze di Gennaro Acquaviva dc e chiesa di fronte alla centralità craxiana 139 Un quadro d’insieme di Gennaro Acquaviva 155 La cei nell’epoca di Craxi di Alessandro Santagata 187 «Duello al centro»: Craxi versus De Mita di Giovanni Mario Ceci 247 dc, mondo cattolico e «Grande riforma» di Michele Marchi 5 indice 307 Craxi e i cattolici di sinistra (1978-1987) di Paolo Zanini 339 L’ultimo congresso (1989). La dc nella crisi della Repubblica di Paolo Acanfora documentazione 389 Nota introduttiva 391 L’azione dei padri gesuiti 393 La matrice culturale del craxismo di Italo Vaccarini 415 Sequestro della nave Achille Lauro e crisi del governo Craxi di Angelo Macchi 427 «Convenzione programmatica» del pci e «riformismo» del psi di Giuseppe De Rosa 441 La strategia dei gesuiti di Gianni Baget Bozzo 445 L’obiettivo