Ricerche Sociali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Experts Weigh in on Istrian Food
The “Authentic” Blend: Experts Weigh in on Istrian Food By: Daša Ličen Abstract This article examines the discourses and concepts of regional Istrian gourmet heroes, who bring into being and distribute ideas on what “authentic” Istrian cuisine is. Citizens of three different countries who speak four different languages, these experts consider themselves most of all Istrian and characterize Istrian foods as alternative foods in contrast to mainstream agro-industrial varieties. Drawing on ethnographic fieldwork, this essay focuses on how these experts arbitrarily use adjectives such as “authentic,” “traditional,” “natural” and others in overlapping ways which I will show create obstacles to labelling the precise terminology of each. Ultimately I argue that these descriptors are all interchangeable in the experts’ discourse(s) on Istrian food, furthermore denoting Istrian food itself, although most of the time they absolutely do not mean the same. This mishmash is nowadays one of the main elements unifying the Istrian region as such, and while similarly present in many different places, Istria’s food movement is unique, because of its geographical and historical contexts. Key terms: Istria, alternative foodways, experts, authenticity, region, Mediterranean diet. Introduction Experts like to put the word Istrian before the name of a recipe to denote that the dish belongs specifically to the Istrian region of Italy, Slovenia, and Croatia, or they use some other positive adjective to reconfirm the quality of the product. Dishes thus carry names such as “good homemade bread,” Ličen, Daša. 2016. “The “Authentic” Blend: Experts Weigh in on Istrian Food.” Digest: a Journal of Foodways and Culture 5:2: n. -

The Ethnographic Research of the Digital Divide
DIGITAL DIVIDE IN ISTRIA A dissertation presented to the faculty of the College of Communication of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Igor Matic August 2006 The dissertation entitled DIGITAL DIVIDE IN ISTRIA by IGOR MATIC has been approved for the School of Telecommunications and the College of Communication by Karen E. Riggs Professor, School of Telecommunications Gregory J. Shepherd Dean, College of Communication ABSTRACT MATIC, IGOR, Ph. D., August 2006, Mass Communication DIGITAL DIVIDE IN ISTRIA (209 pp.) Director of Dissertation: Karen E. Riggs This dissertation covers the Digital Divide phenomena in the Istrian region. Istria is a Northern Adriatic peninsula that is administratively divided between three European countries: Croatia (which covers approximately 90% of the peninsula), Slovenia (app. 7%), and Italy (app. 3%). In this dissertation my goal was to articulate the most influential theoretical frameworks that are used to explain the Digital Divide today and I try to give an explanation of the issue through ethnographic procedures. The goals of this research include the examination of the current Digital Divide debate, extension of the theory toward the local understanding and perception of this global phenomenon. Additionally, I wanted to identify different interpretations of the Digital Divide in three countries within one region and compare the differences and similarities in new technology usage and perceptions. Also, I was interested to see how age - which is described as one of the major Digital Divide factors - influences the relationships between older and younger generations, specifically relationships between parents and children, instructors, students and co-workers. -

The State Wants It So, and the Folk Cannot Do Anything Against the State Anyway
Nar, umjet. 3312, 1996, str. 139-155, B. Brumen, The State Wants It So, and the Folk. Izvorni znanstveni članak UDK 39:32 Primljeno: 8.10.1996. THE STATE WANTS IT SO, AND THE FOLK CANNOT DO ANYTHING AGAINST THE STATE ANYWAY BORUT BRUMEN Filozofska fakulteta, Ljubljana After Slovenia and Croatia proclaimed their independence, a new defining of the state borders took place. The result of a new situation is, among other things, that the population from the both sides of the border had to re-define their social and cultural space. The author did fieldwork in the village of Sv. Peter, placed on today's border between Slovenia and Croatia near the river Dragonja. On basis of his fieldwork, he analyses the process of disappearing of many intercultural communications between Croatian and Slovenian population, as well as the process of disappearing of kinship, friendship, economic and other relations. At the same time, he discovers new socio-cultural processes, such as a shift in identity, or, to be more precise, forming of new identity (from ethnic to national) and the changes that follow the new concept of time and space. As a political intervention in a particular space, the new state border between Slovenia and Croatia has changed not only the physical environment, but also forced the inhabitants of the border villages to 139 Nar. umjet. 3312, 1996, str. 139-155, B. Brumen, The State Wants It So, and the Folk. redefine their social space. In the village of Sv. Peter1 the border has broken numerous intercultural communications, kinship relations, friendships and economic relations by which the wider social environment of the border villages' inhabitants had been defined. -

For a Mapping of the Languages/Dialects of Italy And
For a mapping of the languages/dialects of Italy and regional varieties of Italian Philippe Boula de Mareüil, Eric Bilinski, Frédéric Vernier, Valentina de Iacovo, Antonio Romano To cite this version: Philippe Boula de Mareüil, Eric Bilinski, Frédéric Vernier, Valentina de Iacovo, Antonio Romano. For a mapping of the languages/dialects of Italy and regional varieties of Italian. New Ways of Analyzing Dialectal Variation, In press. hal-03318939 HAL Id: hal-03318939 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03318939 Submitted on 11 Aug 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. For a mapping of the languages/dialects of Italy and regional varieties of Italian Introduction Unifi ed late, Italy is well-known for its great linguistic diversity. This diversity has been thoroughly covered by linguistic atlases such as the Italian-Swiss Atlas (Jaberg / Jud 1928-1940), the Italian Linguistic Atlas (Bartoli et al. 1995), or the linguistic atlases of the Dolomites (Goebl 2003, 2012), Sicily (Sottile 2018), Calabria (Krefeld 2019) and the Piedmont mountains (Cugno / Cusan 2019), for which projects have undertaken to digitise a portion of the material (Tisato 2010) 1 . In other countries, too, various projects have aimed to make the dialect data collected in the 20th century more widely accessible: in France (Goebl 2002; Oliviéri et al. -

Istrian Folk Narrative Tradition from the Perspective of Changing Borders
ISTRIAN FOLK NARRATIVE TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF CHANGING BORDERS MONIKA KROPEJ This paper focuses on the folk narrative tradition of Istria, Članek obravnava ljudsko pripovedno izročilo Istre,v which reflect the area’s cultural landscape as well as the katerem odsevata kulturna krajina in vsakdanje življenje everyday life of its inhabitants. Presented is an overview ljudi. Predstavljen je kratek pregled spreminjajočega se of the changing narrative tradition in the area situated istrskega pripovednega izročila na tem območju, kjer danes along presently disappearing formal state borders within s širitvijo Evropske unije formalne meje počasi izginjajo. the expanded European Union. The author explores older Raziskava se opira na dela starejših piscev, prav tako pa studies and research conducted by contemporary scholars who tudi na objave novejših raziskovalcev in zbiralcev istrskega focused their scholarly interest in the spiritual culture of this duhovnega izročila. Posebna pozornost je namenjena area. Special interest is dedicated to the narrative tradition ljudskemu pripovednemu izročilu, povezanem s kulturno connected with cultural landscape, to traditional narra- krajino, in vlogi, ki ga lahko ima pri ohranjanju kulturne tives as part of intangible heritage, as well as their role in podobe krajin ter oživljanju nesnovne dediščine, prav tako overcoming ethnic as well as social and economic problems. pa tudi pri preseganju etničnih, posredno pa tudi družbenih Keywords: Istria, region, cultural landscape, ethnicity, bor- in ekonomskih problemov. der, folk narrative, intangible heritage, tradition, culture. Ključne besede: Istra, regija, kulturna krajina, etničnost, meja, ljudsko pripovedništvo, nesnovna dediščina, tradi- cija, kultura. A SHORT INTRODUCTION Istra/Istria is a European region with strong historic, cultural and strategic potential that is gaining in importance within the European Union. -

October 2014
10 October 2014 The latest from Slovenia IN FOCUS: Slovene 450 years old - Cerkovna Ordninga IN focus INTERVIEW: Professor Dr Janez Dular - Protecting Slovene language CULTURE: 2014 Slovenia’s first musical - Blossom in the Fall Contact Us! Join Us! E-mail Us! in your hands, on your computers and tablets. [email protected] CONTENTS EDITORIAL IN FOCUS 12 Cerkovna Ordninga Photo: Bruno Toič The treasured work of Primož Trubar returns to home soil Photo: Nebojša Tejić/STA IN FOCUS INTERVIEW 14 Professor Dr Janez Dular Protecting the Slovene language: it is up to us Tanja Glogovčan, Executive Editor Slovenians STA amino Petelinšek/ T An endangered language? Photo: Autumn and winter days are approaching. And as the temperature cools and the days grow shorter, more and more of us will prefer to stay indoors. So this is also the best time of the year for reading books! Slovenians can take pride in the many beautiful and interesting books written in their language, and much of the credit for this must go to Primož Trubar, the author of the first printed books in Slovene. CULTURE 35 In September, the National and University Library put on display Blossom in the Fall Trubar’s Cerkovna ordninga (Church Order). The first Slovenian musical - inspired by Ivan Tavčar’s novel Recently, moreover, a revised edition of the Dictionary of Standard Slovene has been published. It confirms – through different words estival F and phrases, their meanings and examples thereof – the existence ilm F of the Slovene language and the Slovenian nation, it describes the reality around us and presents our conceptual world. -

Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine Written Language: Guidelines and Criteria
Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine written language: guidelines and criteria. Part III. Morphology, II: adjectives, pronouns, invariables Claudi Meneghin Institud de studis Rhaeto-Cisalpins <[email protected]> Abstract This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary Rhaeto-Cisalpine written language, including ISO 639-3 Piedmontese, Lig- urian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot and Friulian. Following the assumptions and the conclusions of Part I we deal with the morphology of the adjective, adverb and invariables in the Padanese varieties. Keywords: Rhaeto-Cisalpine, Padanese, written language, parts of the speech, morphology, Piedmontese, Ligurian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot, Friulian, classical and ancient Lombard. Received: 25.ii.2009 – Accepted: 25.x.2009 Table of Contents 1 Introduction 2 The adjective: making up the feminine inflexion 3 The demonstrative pronoun/adjective 4 The possessive pronoun/adjective 5 Relative and interrogative pronouns/adjectives 6 Indefinite pronouns/adjectives 7 The numerals 8 The adverb 9 Prepositions 10 Conjunctions Appendix Acknowledgements References 37 Ianua. Revista Philologica Romanica ISSN 1616-413X Vol. 9 (2009): 37–94 http://www.romaniaminor.net/ianua/ c Romania Minor 38 Claudi Meneghin 1 Introduction This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary written- language system for the Rhaeto-Cisalpine (or Padanese) domain. The general framework we are working in is described in part I (Meneghin 2007) and II (Meneghin 2008) of this work; as far as specifically morphological issues are concerned, the reader is specifically referred to the introduction of Part II. This paper deals with matters related to the morphology of adjectives, pronouns and invariables in the Padanese varieties. -
Tasting Notes: Winery
(973) 687-2161 vinumusa.com Name: Pikasi Pinela Classification: Dry white wine Varietals: 100% Pinela Appelation: Brje, Vipava Valley, Slovenia Density & Yield: 4,000 vines/ha; 1.5 kg/vine Annual Production: 2,400 bottles Alcohol: 12.5% Climate: Mild Mediterranean, with dry and hot summers, and mild winters. Terrain: Vipava Valley is right on the border of Slovenia, just north of the Italian port city of Trieste. The area is made up of steep hills, where the continental climate of the Alps collides with the more moderate mild Mediterranean climate from the Adriatic. Vineyards are located on steep, karst mountain tops, where the temperature is cooler and the soil contains mineral-rich marl, which makes it incredibly helpful in drainage of rainfall. Farming: Practicing organic. The vineyards have no irrigation, and spraying is done only with sulfites and copper, if needed. Vinification: All grapes are hand-picked, de-stemmed, and pressed immediately. Spontaneous fermentation process is temperature controlled and takes place in stainless steel tanks. The wine is then matured on lees in stainless steels tanks for 5 months, then coarsely filtered before bottling, and released to the market 2 months after bottling. Tasting Notes: Pinela is a rare local variety from Vipava Valley, with only about 50 hectars cultivated currently. Pinela is a gentle grape offering elegant aromas of white peach, wild flowers and almonds. Pleasant creaminess and savory mouthwatering minerality linger on the palate. Fresh and fruity when served cold, but reveals more layers and complexity closer to room temperature. Try it with scampi risotto, white fish, scallops, pasta with white wine sauce and sushi. -
Istrian Exodus” and the Istrian Society That Followed It
DVE DOMOVINI • TWO HOMELANDS • 49 • 2019 DOI: 10.3986/dd.v0i49.7259 THE “ISTRIAN EXODUS” AND THE ISTRIAN SOCIETY THAT FOLLOWED IT Katja HROBAT VIRLOGET | COBISS 1.01 ABSTRACT The “Istrian Exodus” and the Istrian Society that Followed It This ethnologic study focuses on the aftermath of the “Istrian exodus”, including the conflicting national discourses concerning it and the related silenced memories. Var- ious migration processes are highlighted on the basis of memories. Analysing the social processes that took place in Istrian society after the exodus, the paper exam- ines the concepts of the “other” and of “home”, and the establishment of symbolic boundaries. KEY WORDS: exodus, aftermath, Istrian society, migrations, symbolic boundaries IZVLEČEK »Istrski eksodus« in istrska družba po njem Avtorica v etnološki raziskavi, ki se osredotoča na posledice »istrskega eksodusa«, obravnava tudi konfliktne nacionalne diskurze v zvezi z njim in z njim povezane utiša- ne spomine. Na primeru spominov osvetli različne procese migracij. Med družbenimi procesi v istrski družbi po »eksodusu« pokaže na koncept »drugega«, »doma« in na vzpostavitev simbolnih meja. KLJUČNE BESEDE: »eksodus«, posledice, istrska družba, migracije, simbolne meje | PhD in Ethnology, Assistant Professor and Research Fellow at the University of Primorska, Faculty of Humanities, Titov trg 5, SI-6000 Koper/Capodistria; [email protected] ― The research was conducted as part of an ongoing SRA project entitled “Migration Control in the Slovenian Ethnic Territory from the times of Austria-Hungary to Independent Slovenia”, project head Ale- ksej Kalc (J6-8250), and a previous postdoctoral SRA project entitled “The Burden of the Past: Co-existence in the (Slovenian) Coastal Region in light of the Formation of Post-war Yugoslavia” (Z6-4317). -

Jennie Parkinson Phd Thesis
A DIACHRONIC STUDY INTO THE DISTRIBUTIONS OF TWO ITALO-ROMANCE SYNTHETIC CONDITIONAL FORMS Jennie Parkinson A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St. Andrews 2009 Full metadata for this item is available in the St Andrews Digital Research Repository at: https://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/737 This item is protected by original copyright A Diachronic Study into the Distributions of Two Italo-Romance Synthetic Conditional Forms Jennie Parkinson January 2009 Thesis Declaration I, Jennie Parkinson, hereby certify that this thesis, which is approximately 70,000 words in length, excluding appendices and bibliography, has been written by me, that it is the record of work carried out by me and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. I was admitted as a research student in September 2003 and as a candidate for the degree of PhD in May 2004, the higher study for which this is a record was carried out in the University of St Andrews between 2003 and 2009. 22 January 2009 ……… I hereby certify that the candidate has fulfilled the conditions of the Resolution and Regulations appropriate for the degree of PhD in the University of St Andrews and that the candidate is qualified to submit this thesis in application for that degree. 22 January 2009 ……… In submitting this thesis to the University of St Andrews we understand that we are giving permission for it to be made available for use in accordance with the regulations of the University Library for the time being in force, subject to any copyright vested in the work not being affected thereby. -

Anali Za Istrske in Mediteranske Študije Annali Di Studi Istriani E Mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies
UDK 009 ISSN 1408-5348 Anali za istrske in mediteranske študije Annali di Studi istriani e mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia et Sociologia, 26, 2016, 4 KOPER 2016 ANNALES · Ser. hist. sociol. · 26 · 2016 · 4 ISSN 1408-5348 UDK 009 Letnik 26, leto 2016, številka 4 UREDNIŠKI ODBOR/ Simona Bergoč, Furio Bianco (IT), Milan Bufon, Lucija Čok, COMITATO DI REDAZIONE/ Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Goran Filipi (HR), Vesna BOARD OF EDITORS: Mikolič, Aleksej Kalc, Avgust Lešnik, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Claudio Povolo (IT), Vida Rožac Darovec, Mateja Sedmak, Lenart Škof, Tomislav Vignjević, Salvator Žitko Glavni urednik/Redattore capo/ Darko Darovec Editor in chief: Odgovorni urednik/Redattore Salvator Žitko responsabile/Responsible Editor: Uredniki/Redattori/Editors: Urška Lampe Gostujoči urednici/Guest editors: Tina Rožac, Klara Šumenjak Prevajalci/Traduttori/Translators: Tina Rožac (it., ang., slo.), Petra Berlot (it.) Oblikovalec/Progetto grafico/ Dušan Podgornik , Darko Darovec Graphic design: Tisk/Stampa/Print: Grafis trade d.o.o. Izdajatelja/Editori/Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper / Società storica del Litorale - Capodistria© Za izdajatelja/Per Editore/ Salvator Žitko Publisher represented by: Sedež uredništva/Sede della redazione/ SI-6000 Koper/Capodistria, Kreljeva/Via Krelj 3, Address of Editorial Board: e-mail: [email protected], internet: http://www.zdjp.si/ Redakcija te številke je bila zaključena 15. 12. -
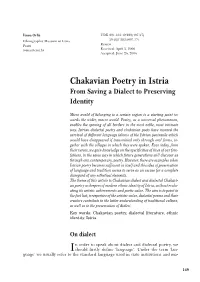
Chakavian Poetry in Istria from Saving a Dialect to Preserving Identity
Ivona Orlić UDK 821.163.42’282(497.57) Ethnographic Museum of Istria 39:821’282](497.57) Pazin Review [email protected] Received: April 3, 2006 Accepted: June 26, 2006 Chakavian Poetry in Istria From Saving a Dialect to Preserving Identity Micro world of belonging to a certain region is a starting point to- wards the wider, macro world. Poetry, as a universal phenomenon, enables the opening of all borders in the most noble, most intimate way. Istrian dialectal poetry and chakavian poets have insured the survival of different language idioms of the Istrian peninsula which would have disappeared if transmitted only through oral forms, to- gether with the villages in which they were spoken. Even today, from their verses, we gain knowledge on the specificities of lives of our fore- fathers, in the same way in which future generations will discover us through our, contemporary, poetry. However, there are examples when Istrian poetry becomes sufficient in itself and this idea of preservation of language and tradition seems to serve as an excuse for a complete disregard of any esthetical elements. The theme of this article is Chakavian dialect and dialectal Chakavi- an poetry as keepers of modern ethnic identity of Istria, without evalu- ating its artistic achievements and poetic value. The aim is to point to the fact hat, irrespective of the artistic value, dialectal poems and their creators contribute to the better understanding of traditional culture, as well as to the preservation of dialect. Key words: Chakavian poetry, dialectal literature, ethnic identity, Istria On dialect n order to speak about dialect and dialectal poetry, we Ishould firstly define ‘language’.