Collana Di Studi Storici, Economici E Sociali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

'Living Like a King? the Entourage of Odet De Foix, Vicomte De Lautrec
2015 II ‘Living Like a King? The Entourage of Odet de Foix, Vicomte de Lautrec, Governor of Milan’, Philippa Woodcock, University of Warwick, Department of History, Article: Living Like a King Living Like a King? The Entourage of Odet de Foix, Vicomte de Lautrec, Governor of Milan Philippa Woodcock Abstract: In the early sixteenth century, the de Foix family were both kin and intimate councillors to the Valois kings, Louis XII and François I. With a powerbase in Guyenne, the de Foix tried to use their connections at court to profit from the French conquest of Milan, between 1499 and 1522. This paper will explore the career of one prominent family member, Odet de Foix, vicomte de Lautrec (1483-1528). Lautrec was a Marshal of France, who served in Italy as a soldier and governor. He was key to the royal entourage, amongst François I’s intimates at the Field of the Cloth of Gold. His sister, Françoise, was also the king’s mistress. The paper will examine Lautrec’s entourage from two aspects. Firstly, it presents how Lautrec established his entourage from his experience in Navarre and Italy and as a mem- ber of the royal retinue. It establishes the importance of familial and regional ties, but also demonstrates the important role played by men of talent. Secondly, it explores Lautrec’s relationship to his entourage once he became governor of Milan. Were ties of blood, ca- reer or positions of Italian prestige the most important aspects for a governor when he chose his intimates? Were compromises made with Italian traditions and elites to sustain his rule? Did he learn from the experience and failures of previous governors? This article contributes to a gap in scholarship for the later period of French Milan from 1515 to 1522. -

„Historia Per Forma Di Diaria“ Venezianische Gegenwartschronistik Um 1500
„Historia per forma di Diaria“ Venezianische Gegenwartschronistik um 1500 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich – Wilhelms – Universität zu Bonn vorgelegt von Christiane Neerfeld aus Bonn Bonn 2001 Gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Danksagung Es ist eine schöne Aufgabe, an dieser Stelle all jenen zu danken, ohne die diese Arbeit nicht geschrieben worden wäre und die mir in den letzten Jahren mit In- teresse und Hilfsbereitschaft zur Seite standen. An erster Stelle möchte ich mich für die Unterstützung von Professor Bernd Roeck bedanken, der diese Arbeit an- geregt und betreut hat. Er war es, der meine Begeisterung für die venezianische Geschichte geweckt und mich vor vielen Jahren mit einer der Hauptfiguren die- ses Buches, Marin Sanudo, bekannt gemacht hat. Professor Wolf-Dieter Lange danke ich für Interesse, Ermutigung und Hilfsbereitschaft. Der Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf und dem Deutschen Studienzen- trum in Venedig bin ich für die finanzielle Unterstützung zu großem Dank ver- pflichtet, denn ihre großzügige Förderung hat die Durchführung dieses Projekts sowie die damit verbundenen Recherchen in Venedig möglich gemacht. Im Palazzo Barbarigo della terrazza hatte ich Gelegenheit zu vielen anregen- den Diskussionen mit den Mitstipendiaten, deren Fragen, Kritik und Kommenta- re meine Arbeit bereichert haben. Einige von ihnen sind meine Freunde gewor- den und wissen, daß ich ihnen mehr verdanke als den Hinweis auf Schleichwege zum Rialto oder die „Gebrauchsanweisung“ für die venezianischen Bibliothe- ken. Besonders herzlich danken möchte ich Daniela Bohde, Anja Wolkenhauer, Hedwig Nosbers, Christine Tauber und Daniela Hacke, die nicht nur die mühe- volle Arbeit des Korrekturlesens auf sich genommen haben, sondern auch durch viele wertvolle Anregungen, Hinweise und Ratschläge entscheidend zum Gelin- gen dieser Arbeit beigetragen haben. -

LES JUIFS À VENISE AUX Xiiie ET Xive SIÈCLES MÉDECINS, NÉOPHYTES ET BANQUIERS*
Renata SEGRE LES JUIFS À VENISE AUX XIIIe ET XIVe SIÈCLES MÉDECINS, NÉOPHYTES ET BANQUIERS* RÉSUMÉ Au sujet de l’histoire de la présence juive à Venise avant la création du ghetto (1516), la recherche d’archives permet de remonter jusqu’à la seconde moitié du XIIIe siècle. La première documentation, portant sur des dates précises, concerne un medecin, Elia de Ferrara, qui s’installe sur les Lagunes en 1276, et, sauf un séjour de quelques années dans ses domains maritimes, va y habiter jusqu’à sa mort en 1326. Sa condition religieuse n’est pas définie, ainsi qu’il arrive à d’autres de ses collègues. Ce n’est qu’après le baptême que l’appellatif olim judeus accompagne l’identité des nouveaux chrétiens, ce qui révèle l’ambiguïté de la politique vénitienne envers ces résidents. À ce phénomène de courte durée, qui s’arrête avant l’épidémie de peste noire (1348), fait suite, après une trentaine d’années de silence des sources, l’apparition des banquiers d’origine allemande, qualifiés officiellement de judei teo- tonici (ashkénazi). Mais leurs activités financières ne donnent pas de résultats satis- faisants aux yeux des autorités qui profitent en 1395 de la fin d’une période de guerre et de difficultés économiques pour les renvoyer, à l’échéance de leur condotta. Le patriciat pourra dès lors revendiquer pleinement le rôle primordial de Venise en tant que défenseur de la foi et rampart de l’Église. SUMMARY The ultimate scope of this archival research is the history of the Jewish presence in Venice before the creation of the ghetto (1516). -

IN MEDIAS RES: the LIFE of CLAUDE DE SEYSSEL for The
CHAPTER ONE IN MEDIAS RES: THE LIFE OF CLAUDE DE SEYSSEL For the historian, Claude de Seyssel has proved to be an extremely elusive gure. Unlike many of his contemporaries including Erasmus, who used friendly correspondence to boost his standing in the world of letters, Seyssel shunned even the most common forms of humanist self-promotion. He did not write many eloquent letters, and he seems to have had few friends, at least at the French court. All that remains of his correspondence is a collection of dry diplomatic dispatches. Clearly, he preferred the day-to-day, concrete world of shifting diplo- macy and policy-making to participation in the nascent Republic of Letters. Although he often appeared as a scholar, translating ancient histories, giving elaborate orations at court, and writing well-crafted works glorifying the French monarch, Seyssel’s biography indicates that at least during his lifetime, his identity as a scholar was overshadowed by his role as a political actor. Scholarship functioned as a tool in the service of his career as a diplomat and military advisor. He appears as a gure struggling to maneuver in a world characterized by the constant twists and turns of sixteenth century diplomacy, and reveals how the experience of political chaos lay at the heart of his search for order and stability.1 Seyssel was born around 1450 in Aix-les-Bains in the duchy of Savoy. Situated in the western Alps with its capital at Chambéry, the duchy of Savoy began as a county of the Holy Roman Empire in the Middle Ages. -

Sabaudian States
Habent sua fata libelli EARLY MODERN STUDIES SERIES GENEraL EDITOR MICHAEL WOLFE St. John’s University EDITORIAL BOARD OF EARLY MODERN STUDIES ELAINE BEILIN raYMOND A. MENTZER Framingham State College University of Iowa ChRISTOPHER CELENZA ChARLES G. NAUERT Johns Hopkins University University of Missouri, Emeritus BARBAra B. DIEFENDORF ROBERT V. SCHNUCKER Boston University Truman State University, Emeritus PAULA FINDLEN NICHOLAS TERPSTra Stanford University University of Toronto SCOtt H. HENDRIX MARGO TODD Princeton Theological Seminary University of Pennsylvania JANE CAMPBELL HUTCHISON JAMES TraCY University of Wisconsin–Madison University of Minnesota MARY B. MCKINLEY MERRY WIESNER-HANKS University of Virginia University of Wisconsin–Milwaukee Sabaudian Studies Political Culture, Dynasty, & Territory 1400–1700 Edited by Matthew Vester Early Modern Studies 12 Truman State University Press Kirksville, Missouri Copyright © 2013 Truman State University Press, Kirksville, Missouri, 63501 All rights reserved tsup.truman.edu Cover art: Sabaudia Ducatus—La Savoie, copper engraving with watercolor highlights, 17th century, Paris. Photo by Matthew Vester. Cover design: Teresa Wheeler Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Sabaudian Studies : Political Culture, Dynasty, and Territory (1400–1700) / [compiled by] Matthew Vester. p. cm. — (Early Modern Studies Series) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-61248-094-7 (pbk. : alk. paper) — ISBN 978-1-61248-095-4 (ebook) 1. Savoy, House of. 2. Savoy (France and Italy)—History. 3. Political culture—Savoy (France and Italy)—History. I. Vester, Matthew A. (Matthew Allen), author, editor of compilation. DG611.5.S24 2013 944'.58503—dc23 2012039361 No part of this work may be reproduced or transmitted in any format by any means without writ- ten permission from the publisher. -

Giovanni Giacomo Caroldo
Giovanni Giacomo Caroldo ISTORII VENEŢIENE Vol. I De la originile Cetăţii la moartea dogelui Giacopo Tiepolo (1249) Arhivele Nationale ale Romaniei Arhivele Nationale ale Romaniei ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI Giovanni Giacomo Caroldo ISTORII VENEŢIENE Vol. I: De la originile Cetăţii la moartea dogelui Giacopo Tiepolo (1249) Ediţie îngrijită de Şerban V. Marin Bucureşti Arhivele Nationale2008 ale Romaniei ISBN: 978-973-8308-38-1 Arhivele Nationale ale Romaniei CUPRINS Studiu introductiv 7 Paternitate şi datare 7 Surse şi influenţe 10 Manuscrisele cronicii pseudo-caroldiene 15 Secolul al XVI-lea 16 Secolul al XVII-lea 19 Secolul al XVIII-lea 22 Manuscrise caroldiene la Arhivele Naţionale ale României 30 Câte ceva despre necesitatea unei ediţii a cronicii 31 Textul cronicii 37 [Introducere] 37 Libro primo [421-697] 41 Libro II [697-811] 46 Libro terzo [811-1172] 54 Libro IIII [1172-1249] 148 Indici 241 Indice antroponimic 241 Indice toponimic 269 Arhivele Nationale ale Romaniei Arhivele Nationale ale Romaniei Studiu introductiv* Paternitate şi datare În privinţa paternităţii cronicii de faţă, marea majoritate a manuscriselor avute la dispoziţie face trimitere la persoana secretarului Consiliului celor Zece, Giovanni Giacomo Caroldo. Însă analiza detaliată oferită de J. Chrysostomides demonstrează că această apartenenţă declarată nu trebuie să inducă în eroare. Astfel, se ajunge la concluzia că autentica scriere a personajului în cauză este reprezentată doar de cele două manuscrise autografe, M 803 şi M 2448, alături de o copie din secolul al XVII-lea (anume, manuscrisul 6170 de la Viena)1, realizată ca o copie după M 2448. Restul, reprezentat de celelalte numeroase manuscrise atribuite lui Caroldo, nu ar constitui decât o versiune modificată a cronicii iniţiale. -

Reform and High Politics in France 1517-1525
CCHA Study Sessions, 36(1969), 57-77 Reform and High Politics in France 1517-1525 by Henry HELLER University of Manitoba In the period 1517 to 1525 Germany, ahead of all other countries, attracts the eye of the historian. The dramatic train of events which unfolded there following the posting of academic theses at Wittenberg – the Leipzig Debate, the Diet of Worms, the Knights’ War, finally, the Peasant’s Revolt – affords the uncanny sensation of a world shifting on its axis. Germany in these years is without doubt at the centre of European history. Indeed, developments th ere were closely followed by contemporaries throughout the rest of Europe. And in a way which p aral lels reaction to subsequent major upheavals like the French or Russian Revolutions, the religious reformation in Germany gradually had its effects on every European country.1 France is a particularly clear example of the transfer of these revolutionary currents. Its close proximity to Germany and its large and influential intellectual elite concentrated at such centres as Paris, Orleans and Lyons made it particularly open to new influences from across the Rhine. Luther’s name was known within months of the outbreak of the struggle in Germany and his works were being read at Paris as early as May, 1519.2 The submission of the proceedings of the Leipzig Debate between Luther and Johann Eck of the following summer to the judgment of the Sorbonne, stirred further widespread interest. Until a prohibition was imposed in March, 1521, Luther’s writings appear to have widely and freely circulated in the kingdom.3 Indeed, the prohibition of Lutheran books at that time as well as later did not create an effective obstacle to their dissemination. -

Alberto-Pio-Volume.Pdf
Collana di studi storici, economici e sociali Volumi pubblicati: 1. Natale Marri, Memorie storiche critico-toppograffiche della città di Carpi, suo principato antico e moderno con i luoghi adjerenti, e della sua diocesi nullius antica e moderna, sue parrocchie et adjerenze, a cura di Marzia Dezzi Bardeschi e Cinzia Rossi, Carpi 2002. 2. Le Clarisse in Carpi. Cinque secoli di storia (XVI-XX). Reggio Emilia 2004. Vol. I, Saggi, a cura di Gabriella Zarri. Vol. II, Fonti, a cura di Anna Maria Ori. 3. Giuseppe Saltini, Cronaca di Carpi (1796-1863) a cura di Alfonso Garuti, Anna Maria Ori, Gilberto Zacchè, Introduzione di Angelo Varni, Trascrizione a cura di Gianfranco Guaitoli, Modena 2005. 4*. Storia della Chiesa di Carpi, Volume I, Profilo cronologico, a cura di Andrea Beltrami, Anna Maria Ori, Modena 2006. 4**. Storia della Chiesa di Carpi, Volume II, Percorsi tematici, a cura di Andrea Beltrami, Alfonso Garuti, Anna Maria Ori, Modena 2007. 5*. Storia di Carpi, Volume I, La città e il territorio dalle origini all'affermazione dei Pio, a cura di Pierpaolo Bonacini, Anna Maria Ori, Modena 2008. 5**. Storia di Carpi, Volume II, La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII) a cura di Marco Cattini e Anna Maria Ori, Modena 2009. 5***/1. Storia di Carpi, Volume III, La città e il territorio nel lungo Ottocento (1796-1914). Tomo I – Istituzioni, Politica, Economia, a cura di Anna Maria Ori e Elio Tavilla, Modena 2010. 5***/2. Storia di Carpi, Volume III, La città e il territorio nel lungo Ottocento (1796-1914). -
A Salavastru
Patterns in the Construction of Public Discourse 62 Milton N. CAMPOS Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric 14 (1) : 63-83, 2016 The New Body Politic of the Renaissance in the Works of John Fortescue and Claude de Seyssel Andrei SALAVASTRU “Al. I. Cuza” University of Iași (Romania) Abstract: The use of corporal analogies, where the state was compared with the human body, had been a frequent occurrence in medieval political theory starting from the twelfth century and they can be encountered in some of the most influential political treatises of that period. It was a strong metaphor employed in order to strengthen the author‟s message – therefore, its use continued past the Middle Ages and well into the Renaissance period. Yet, the respective metaphor did not remain unchanged – on the contrary, the many changes which occurred during the fifteenth century had a noticeable impact upon it, leading to alterations in the traditional version, while retaining many of the old features. This article aims to provide an analysis of the shift which occurred during late fifteenth century and early sixteenth century by analyzing the cases of two of the most significant political writers of that period in England and France: John Fortescue and Claude de Seyssel. Keywords: body politic, Claude de Seyssel, John Fortescue, corporal analogy, humours. 1. The Concept of Body Politic and its Use in Medieval Political Thought During the Middle Ages, starting from the twelfth century, political theory witnessed the employment of an analogy between the human body and the polity, where the latter was described in what one could call “corporal terms”: the structure of the state was considered to imitate that of the body and the same was thought about the way both 64 Andrei SALAVASTRU functioned. -
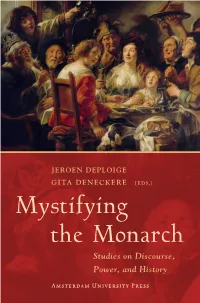
Mystifying the Monarch
omslag Monarch 31-10-2006 11:04 Pagina 1 Mystifying the Monarch The monarchy: no other political institution proved to be so durable and flexible through its age-long history. Despite the modernization, seculari- zation, and bureaucratization of power, the affective, archaic, and almost timeless relationship between sovereigns and their ‘subjects’ still prevails in several countries. Though troubled by the many recent scandals of their royals, many courts continue to perceive that the perennial maxim ‘the King can do no wrong’ has lost none of its strength. Yet the staging and sacralization of the monarchy in Western Europe have always been interwoven with practices of subversion and banalization. The different discourses aiming at the symbolic construction of royal power can not be studied without considering at the same time the popular appropriation of the official rhetoric. Hence, this collection of essays does not propose a strictly linear narrative from medieval sacralization to postmodern demystification of kingship. Choosing the perspective of the long run between the twelfth and the first half of the twentieth century, it clearly shows how the mystification and demystification of the monarch have always been two sides of the same coin. The contributors are Alain Boureau, Gita Deneckere, Jeroen Deploige, Lisa Jane Graham, Maria Grever, Marc Jacobs, Gilles Lecuppre, Elodie DENECKERE GITA JEROEN DEPLOIGE Lecuppre-Desjardin, Jürgen Pieters, Alexander Roose, Kevin Sharpe, Henk te Velde, Maarten Van Ginderachter, and Jaap van Osta. JEROEN DEPLOIGE The editors are Jeroen Deploige (Associate Professor of Medieval Cultural GITA DENECKERE [ EDS.] History, Ghent University) and Gita Deneckere (Associate Professor of Modern History, Ghent University). -

52 Soviet-Era Kozintsev and Welles in Hollywood Are Not Notably Sensi
52 SEVENTEENTH-CENTURY NEWS Soviet-era Kozintsev and Welles in Hollywood are not notably sensi- tive to Christian elements, and Luhrmann’s treatment of Catholic im- agery is not exactly subtle. The final chapter engages such critics who are alert to religious ideas as G. Wilson Knight and Roland Frye, and Baker properly responds to the issues raised by Stephen J. Greenblatt in Hamlet and Purgatory. But elsewhere in the book Baker misstates some crucial facts (Savonarola was burnt, not hanged; Erasmus was associated with Cambridge, not Oxford), and he cites approvingly the work of A. G. Dickens, whose partisan treatment of Protestantism has now largely been derided as naive and simplistic. Worse, he fails to engage at length the most recent scholarship on the persistence of Catholic faith in Shakespeare’s age, as in the work ofEamon Duffy and Richard Wilson. The collection of primary documents may well be helpful to students, but a number of the choices are readily avail- able elsewhere. Surely the space devoted to reprinting the Bower of Bliss episode from Book II of The Faerie Queene could have been given to key texts that are harder to find in literary anthologies, such as Hugh Latimer’s Sermon of the Plough. Also, a caveat about the cover illustration: the well-known painting of the interior of the Temple of Lyon is fine, but surely an English illustration would have been more to the point. This book is an interesting grab-bag, but one has to won- der how useful the student or the general reader will actually find it. -

The Renaissance Society of America Annual Meeting Program And
The Renaissance Society of America Annual Meeting Program and Abstract Book San Diego 4–6 April 2013 Giorgione (Giorgio da Castelfranco). Portrait of a Man. Oil on panel, 1506. 11 7/8 in. by 10 1/8 in. (30.16 cm by 25.72 cm). Gift of Anne R. and Amy Putnam. The San Diego Museum of Art, 1941.100. With kind permission of The San Diego Museum of Art. Contents RSA Executive Board .......................................................................5 Acknowledgments ............................................................................. 6 Registration and Book Exhibition ...................................................10 Business Meetings........................................................................... 11 Plenaries, Awards, and Special Events .............................................12 Program Summary Thursday ................................................................................. 17 Friday ..................................................................................... 23 Saturday ................................................................................. 30 Full Program with Abstracts Thursday 8:45–10:15 ...................................................................... 37 10:30–12:00..................................................................... 68 2:00–3:30....................................................................... 101 3:45–5:15 ...................................................................... 132 Friday 8:45–10:15 ...................................................................