Centro Storico, Saline E Pineta Di Pinarella
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sustainability Reporting 2011
The Hera Group Sustainability Report for 2011 contains figures for the three areas of responsibility: economic, social and environmental. Focus on commitments made, the results obtained and the outlook for the future. Contents Letter to stakeholders................................................................................................................................................ 4 The Report .................................................................................................................................................. 5 Reading this Report .................................................................................................................................................. 5 Drawing up this report .............................................................................................................................................. 7 About us .................................................................................................................................................... 11 Hera today............................................................................................................................................................... 11 History .................................................................................................................................................................... 11 Services managed .................................................................................................................................................. -

Good Practices Catalogue for International Knowlegde Exchange
Good Practices Catalogue for International Knowlegde Exchange 13 Good Practices in vallorization of water-linked heritage from 5 European locations Good Practices Catalogue CONTENTS Introduction by Delft University of Technology 1. The Adriatic Sea, a shared heritage (Italy) 1.1 Detailed information 1.2 Resources needed 1.3 Evidence of success 1.4 Difficulties encountered 1.5 Potential for learning or transfer 2. Aqua Phone cultural festival (Hungary) 2.1 Detailed information 2.2 Resources needed 2.3 Evidence of success 2.4 Difficulties encountered 2.5 Potential for learning or transfer 3. Vega Baja Artichoke, a product of traditional irrigation (Spain) 3.1 Detailed information 3.2 Resources needed 3.3 Evidence of success 3.4 Difficulties encountered 3.5 Potential for learning or transfer 4. Blue Routes, Alicante’s hydrogeological heritage (Spain) 4.1 Detailed information 4.2 Resources needed 4.3 Evidence of success 4.4 Difficulties encountered 4.5 Potential for learning or transfer 5. Bridge Guard residential art (Hungary) 5.1 Detailed information 5.2 Resources needed 5.3 Evidence of success 5.4 Difficulties encountered 5.5 Potential for learning or transfer 6. Urban Mediaspace, reconnecting Aarhus to the sea (Denmark) 6.1 Detailed information 6.2 Resources needed 6.3 Evidence of success 6.4 Difficulties encountered 6.5 Potential for learning or transfer 7. The Uncovering of the river Aarhus (Denmark) 7.1 Detailed information 7.2 Resources needed 7.3 Evidence of success 7.4 Difficulties encountered 7.5 Potential for learning or transfer 8. Provincial Water Board (Spain) 8.1 Detailed information 8.2 Resources needed 8.3 Evidence of success 8.4 Difficulties encountered 8.5 Potential for learning or transfer 9. -

Rural Itineraries
CERVIA ITINERARIES EDITION 2015 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali Edited by the Municipality of Cervia Piazza Garibaldi, 1 48015 Cervia (RA) tel. +39 0544/979111 www.comunecervia.it www.turismo.comunecervia.it [email protected] Coordination: Alessandra Giordano Creative design and editorial content: PubliOne Milano - Forlì - Napoli Photos: Archive of the Tourist Office of the Municipality of Cervia, photos on page 38-39 by GeaProgetti s.a.s. Cesena Printing: Tipo-Lito Wafra s.a.s TABLE OF CONTENTS The The PINEWOOD SEA page 8 page 16 Up and down the dunes pg. 9 From the lighthouse From the Tower to the sea pg. 17 to the centre pg. 10 Sailing through memory pg. 18 The Byzantine treasures pg. 12 A hidden treasure pg. 19 Relax in the Pinewood pg. 14 Fitness in the Pinewood pg. 15 The The GARDEN SALT PAN CITY page 20 page 28 From the centre From the square to the Salt pan pg. 21 to the mulberry tree pg. 29 History trail pg. 22 Cervia garden city pg. 30 Nature trail pg. 24 Wellness and Food and wine trail pg. 26 century-old pines pg. 32 RURAL PARKS AND ITINERARIES MUSEUMS page 34 page 42 Along the Savio Natural Park pg. 44 embankment pg. 36 Butterfly house & Co. pg. 46 Savio by bike pg. 40 Musa pg. 48 CERVIA ITINERARIES EDITION 2015 Cervia: environment and nature Tourism in Cervia has developed in total harmony with the environment and nature thanks to the extraordinary wealth of its green areas. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

1) Saliera Simonetta Vicepresidente 2) Bianchi Patrizio Assessore 3
Progr.Num. 777/2012 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno lunedì 11 del mese di giugno dell' anno 2012 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: 1) Saliera Simonetta Vicepresidente 2) Bianchi Patrizio Assessore 3) Bortolazzi Donatella Assessore 4) Freda Sabrina Assessore 5) Gazzolo Paola Assessore 6) Lusenti Carlo Assessore 7) Marzocchi Teresa Assessore 8) Mezzetti Massimo Assessore 9) Muzzarelli Gian Carlo Assessore 10) Peri Alfredo Assessore 11) Rabboni Tiberio Assessore Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta attesa l'assenza del Presidente Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: POR FESR 2007-2013 - ASSE 2 - ATTIVITÀ II. 1.2 - BANDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE P.M.I. E DELLE RETI DI P.M.I. DELL'EMILIA ROMAGNA - ANNO 2011, APPROVATO CON D.G.R. N. 666/2011. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI "AMMISSIBILI", DELL'ELENCO DEI PROGETTI "NON FINANZIABILI" E DELL'ELENCO DEI PROGETTI "ESCLUSI". CONCESSIONE CONTRIBUTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Cod.documento GPG/2012/730 pagina 1 di 78 Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2012/730 ----------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste: - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 47 e 49; - la propria deliberazione n. 666 del 16/05/2011 avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013 – Asse 2 – Attività II. 1.2 – Bando per l’innovazione tecnologica delle p.m.i. e delle reti di p.m.i. dell’Emilia-Romagna – anno 2011. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la realizzazione degli interventi e la concessione dei contributi” ed in particolare l’ALLEGATO A della deliberazione stessa (di seguito denominato semplicemente “bando”); - la determinazione dirigenziale n. -

Pinarella 1.1 Dati Identificativi 2.1 Descrizione Dell
Pinarella 1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione* Pinarella 4 Categoria Acque marino costiere: piana alluvionale ad alta stabilità 5 Regione Emilia-Romagna 6 Provincia Ravenna 7 Comune Cervia 8 Corpo idrico* Area Costiera Centro-Meridionale Nelle acque di balneazione relative al profilo e nel corrispettivo tratto di spiaggia, non sono presenti rilevanti lavori di 10 Informazioni ai sensi dell’Allegato III, comma 3 costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture. 15 Data di redazione del profilo Maggio 2019 16 Aggiornamento e riesame 2023 2.1 Descrizione dell’area di balneazione L’area si estende da 100 m a Sud del piede Sud della darsena del Portocanale di Cervia al Confine provinciale Ra-Fc. Descrizione generale della spiaggia e della zona 18 La costa, sabbiosa, è adibita alla balneazione. Nell’entroterra vasta area di tessuto residenziale rado che prosegue con circostante vaste aree a seminativi semplici. 20 Ampiezza della spiaggia 70-80 m 21 Fenomeni erosivi La spiaggia emersa e la linea di riva sono in equilibrio, mentre il fondale è in erosione. 22 Numero di bagnanti Media fruizione di bagnanti Nell'area sono presenti 103 stabilimenti balneari con servizi di primo soccorso, servizi igienici anche per diversamente 23 Infrastrutture/servizi abili, docce calde, assenza di barriere architettoniche, strutture sportive e punti ristoro 24 Accesso consentito ad animali L'accesso degli animali è regolamentato dall'Ordinanza Balneare Regionale ed eventuali Ordinanze Comunali. Arpae SSA Area Est (Sede Ravenna): Viale Alberoni 17 Ravenna – Tel 0544-210611 e-mail: [email protected]; Ausl Ravenna (Dott.ssa V. Contarini) – Via Fiume Abbandonato, 134 - Tel.0544-286698 e-mail: prevenzione. -
Rapporto Dell'evento Meteorologico Dal 22 Al 24 Luglio 2020
Rapporto dell’evento meteorologico dal 22 al 24 luglio 2020 A cura di: Virginia Poli, Unità Radarmeteorologia e Centro di Competenza Riccardo Bortolotti, Servizio Sala Operativa e Centro Funzionale BOLOGNA, 05/08/2020 Arpae Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima Riassunto Nelle giornate dal 22 al 24 luglio si sono susseguiti una serie di eventi temporaleschi, associati sia a fenomeni grandinigeni che a forti raffiche di vento, con conseguenti danni alle colture e caduta di rami ed alberi. In copertina: fulmine in provincia di Modena, a Ravarino (fonte: pagina Facebook di Emilia- Romagna Meteo, foto di Angela Maladugno). 2 Arpae Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima INDICE 1. Evoluzione meteorologica a grande scala ..................................................................................... 4 2. Analisi meteorologica in Emilia-Romagna .................................................................................. 7 2.1. Evoluzione alla mesoscala sul territorio regionale ................................................................... 7 2.2. Analisi delle precipitazioni cumulate sul territorio regionale ................................................. 10 2.3. Analisi della grandine sul territorio regionale......................................................................... 14 2.4. Analisi del vento sul territorio regionale................................................................................. 21 3. L’attività di previsione e monitoraggio del Centro Funzionale ................................................. -

Pinarella - Colonia - Soggiorno Estivo - Bambini Con Assistente Sulla Spiaggia
SIRBeC scheda AFRLIMM - IMM-2s020-0002111 Ritratto di gruppo - Pinarella - Colonia - Soggiorno estivo - Bambini con assistente sulla spiaggia Anonimo Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2s020-0002111/ Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-2s020-0002111/ SIRBeC scheda AFRLIMM - IMM-2s020-0002111 CODICI Unità operativa: 2s020 Numero scheda: 2111 Codice scheda: IMM-2s020-0002111 Visibilità scheda: 3 Utilizzo scheda per diffusione: 03 Tipo di scheda: AFRLIMM SOGGETTO SOGGETTO Indicazioni sul soggetto: didascalia: Soggiorno estivo dei bambini mantovani turno 25 giugno 19 luglio 1965 Identificazione: Ritratto di gruppo - Pinarella - Colonia - Soggiorno estivo - Bambini con assistente sulla spiaggia CLASSIFICAZIONE Altra classificazione: reportage Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia THESAURUS [1 / 4] Descrittore: servizi pubblici Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia THESAURUS [2 / 4] Descrittore: biografia / ritratto Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia THESAURUS [3 / 4] Descrittore: infanzia Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia THESAURUS [4 / 4] Descrittore: mare Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia LUOGO E DATA DELLA RIPRESA Pagina 2/11 SIRBeC scheda AFRLIMM - IMM-2s020-0002111 LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia-Romagna Provincia: RA Comune: Cervia Data: 1965/06-1965/07 DATAZIONE GENERICA Secolo: XX Frazione di secolo: terzo quarto DATAZIONE SPECIFICA Da: 1965/06/25 Validità: post A: 1965/07/15 Validità: ante DEFINIZIONE CULTURALE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA Nome scelto (autore personale): Anonimo Dati anagrafici/estremi cronologici: notizie terzo quarto sec. XX Riferimento all'intervento: fotografo principale Codice scheda autore: AUF-LOM60-0000176 Sigla per citazione: 00000176 Motivazione dell'attribuzione: n.r. -
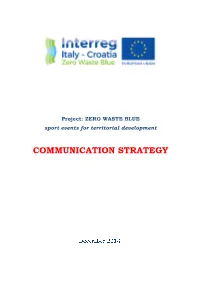
Communication Strategy
Project: ZERO WASTE BLUE sport events for territorial development COMMUNICATION STRATEGY Project: ZERO WASTE BLUE sport events for territorial development The project is implemented by: Town of Opatija from the Republic of Croatia, University of Rijeka - Faculty of Tourism and Hospitality Management from the Republic of Croatia, Zadar county Development agency ZADRA NOVA from the Republic of Croatia, Dubrovnik and Neretva Region from the Republic of Croatia, ERVET Emilia-Romagna Economic Development Agency L.T.D. from Italian Republic, Emilia-Romagna Region from Italian Republic, Veneto Region from Italian Republic, Molise Region from Italian Republic, Municipality of Ancona from Italian Republic and VENETO INNOVAZIONE S.P.A. from Italian Republic. COMMUNICATION STRATEGY October 2018 1 Table of contents SUMMARY ........................................................................................................................................... 3 1. Introduction .................................................................................................................................. 5 1.1. Project objectives ....................................................................................................................... 5 1.2. Project tools ................................................................................................................................ 5 1.3. Key message............................................................................................................................... 5 2. Project/programme -

Rapporto Dell'evento Meteorologico Del 25 E 26 Marzo 2019
Arpae Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima Rapporto dell’evento meteorologico del 25 e 26 marzo 2019 A cura di Miria Celano, Unità Radarmeteorologia, Nowcasting e Meteorologia da Satellite Roberto Stanzani, Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA, 01/04/2019 1 Arpae Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima Riassunto Flussi da nord-est a partire dalla tarda serata del 25 marzo portano precipitazioni, accompagnate da venti molto forti su tutto il settore centro orientale della Regione, che causano danni diffusi, quali abbattimenti di alberi, di pali, danni ad edifici e mareggiate sulla costa. Raffiche di oltre 100 km/h sono registrate nel Ravennate e nel Cesenate e di quasi 90 km/h nel Ferrarese, Bolognese e Riminese. Inoltre, dopo la presenza sul territorio di temperature molto miti nei giorni precedenti (con valori massimi ben oltre i 20 °C), un repentino abbassamento delle temperature dalla serata del 25 porta diffuse ma deboli nevicate su tutti i rilievi regionali, fino anche a quote collinari, in particolare dall’Appennino modenese al romagnolo (a partire da circa 400 metri). In copertina: albero caduto a Piangipane (RA), foto Giusy Simeri da ER-Meteo (in alto a sinistra), foto dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali a Camugnano (BO), in alto a destra, i danni del vento a Riccione, foto Concolino, da “Il Resto del Carlino” (in basso a sinistra) e molo allagato a Cervia, da “Il Resto del Carlino” (in basso a destra). 2 Arpae Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima INDICE 1. Evoluzione generale e zone interessate ........................................................................................ 4 2. Analisi dell’evoluzione alla mesoscala sull’Emilia-Romagna .................................................... -

Cycling Along the Adriatic Coast
Cycling along the Adriatic Coast. 16 itineraries from the Adriatic to the Tuscany-Romagna Apennines -"/055&304" 5IFJUBMJBOTVNNFSµT/FX:FBSµT&WF "QQPJOUNFOU JOKVMZ FNPUJPOT .it art IBWJOHGVOUPHFUIFS graphic design inèdit BNVTFNFOU QPFUSZ MPPL XXX MBOPUUFS PTBJU THE ADRIATIC COAST OF EMILIA ROMAGNA The most entertaining relaxation there is Bike People Someone’s going slowly along a road by a canal. On a bike of course. There can be no doubt that we’re in Romagna, and the image is the classic one made fa- mous by the films of Zavattini and Fellini. No official statistics exist on how many bikes there are in this region, for the simple reason that everybody goes by bike. It’s no coincidence that a lot of cycling champions come from around here. There are physical, cultural and organisational factors, over and above the economic ones, that make this territory especially suited to cyclists. First of all the variety of routes: in the space of a few miles you go from flatlands to hills and mountains, so bike enthusiasts can choose a whole day trip or a few hours’ spin. For some years now, particularly in spring, thousands and thousands of bike lovers and specialists have chosen the Adriatic Coast of Emilia Romagna as a competi- tion training ground. Professionals, amateurs and beginners find the right pedalling conditions in this area. The numerous cycling tour events organised here and the cycling schools held by expert professionals offer the chance to select a sports holiday at any time of the year. Many operators are specialised in the cycling field and their hotels are equip- ped with bicycle sheds, small workshops and menus suited to cyclists, as well as informative material about the various routes. -
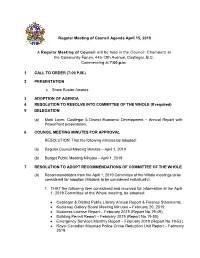
Regular Meeting of Council Agenda April 15, 2019 a Regular Meeting Of
Regular Meeting of Council Agenda April 15, 2019 A Regular Meeting of Council will be held in the Council Chambers at the Community Forum, 445-13th Avenue, Castlegar, B.C. Commencing at 7:00 p.m. 1 CALL TO ORDER (7:00 P.M.) 2 PRESENTATION • Snow Buster Awards 3 ADOPTION OF AGENDA 4 RESOLUTION TO RESOLVE INTO COMMITTEE OF THE WHOLE (If required) 5 DELEGATION (a) Mark Laver, Castlegar & District Economic Development – Annual Report with PowerPoint presentation. 6 COUNCIL MEETING MINUTES FOR APPROVAL RESOLUTION: That the following minutes be adopted: (a) Regular Council Meeting Minutes – April 1, 2019 (b) Budget Public Meeting Minutes – April 1, 2019 7 RESOLUTION TO ADOPT RECOMMENDATIONS OF COMMITTEE OF THE WHOLE (a) Recommendations from the April 1, 2019 Committee of the Whole meetings to be considered for adoption (Motions to be considered individually): 1. THAT the following item considered and received for information at the April 1, 2019 Committee of the Whole meeting, be adopted: • Castlegar & District Public Library Annual Report & Finance Statements. • Kootenay Gallery Board Meeting Minutes – February 20, 2019. • Business License Report – February 2019 (Report No.19-49). • Building Permit Report – February 2019 (Report No.19-50). • Emergency Services Monthly Report – February 2019 (Report No.19-53). • Royal Canadian Mounted Police Crime Reduction Unit Report – February 2019. Agenda Council of the City of Castlegar Regular Meeting – April 15, 2019 Page 2 of 5 • (Report No.19-16) Implications of a Herbicide Reduction Bylaw. 2. THAT Council approve the event recommendations listed in Report No. 19-51 for the 2019 Community Canada Day Celebration.