Labirinti 172.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Firmenzüge Der Russischen Eisenbahn
Firmenzüge der russischen Eisenbahn Der Eisenbahnverkehr zählt in Russland traditionell zu den gefragtesten und populärsten Verkehrsmitteln des Landes. Die russische Bahn legt seit einigen Jahren erhöhten Wert auf Komfort und Sicherheit. Zu diesem Zweck gibt es in Russland ein System von ca. 100 so genannten Firmenzügen. Der 1. Firmenzug wurde bereits 1931 zwischen Moskau und St.Petersburg als „Krasnaja Strela“ in Betrieb genommen. Die Firmenzüge verkehren zwischen den größten Städten Russlands und des nahen Auslands. Alle Züge haben gegenüber den „normalen“ Zügen bessere Ausstattung, Komfort, Service und Sicherheitsvorrichtungen. Die Firmenzüge haben eigene Namen mit Bezug auf die befahrene Region oder regionale Kultur und Geschichte. Hier finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Firmenzüge der russischen Eisenbahn: Name des Zuges Route Jarmarka Nishni Novgorod-Moskau Turgenev Moskau-Simferopol Ivan Paristyi Brjansk-Moskau Solovej Moskau-Kursk Rossija Moskau-Wladiwostok Pomorje Moskau-Severodwinsk Slawjanksij Express Moskau-Minsk Poljarnaja Strela Moskau-Labytnangi Stolitschnyi Express Moskau-Kiew Krasnaja Strela St.Petersburg-Moskau Express St.Petersburg-Moskau 1 von 5 Sputnik Travel GmbH, Stresemannstraße 107, 10963 Berlin Tel: 030-20454581, Fax: 030-20455998, E-Mail: [email protected] Afanassi Nikitin St.Petersburg-Moskau Lew Tolstoi Moskau-Helsinki Smena St.Petersburg-Moskau Pskow Pskow-Moskau Repin St.Petersburg-Helsinki Junost St.Petersburg-Moskau Nikolajewskij Express St.Petersburg-Moskau Aurora St.Petersburg-Moskau Newskij -

Kampf Um Wort Und Schrift
Vandenhoeck & Ruprecht Kampf um Wort Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz Beiheft 90 und Schrift Russifizierung in Osteuropa Nach den Teilungen Polens und der Eroberung des Kaukasus im 19.–20. Jahrhundert und Zentralasiens im 18./19. Jahrhundert erhielt das Zarenreich Kontrolle über alte Kulturräume, die es im Zuge der Koloniali- sierung zu assimilieren versuchte. Diese Versuche erfolgten nicht Herausgegeben von Zaur Gasimov zuletzt mittels der Sprachpolitik. Russisch sollte im Bildungs- und Behördenwesen im gesamten Imperium Verbreitung finden, andere Sprachen sollten verdrängt werden. Diese Russifizierung lässt sich Schrift und Wort um Kampf von einer kurzen Phase der »Verwurzelung« unter Lenin bis weit ins 20. Jahrhundert nachverfolgen. Erst im Zuge der Perestrojka wurde die sowjetische Sprachpolitik öffentlich kritisiert: Die einzelnen Republiken konnten durch neue Sprachgesetze ein Aussterben der lokalen Sprachen verhindern. Der Herausgeber Dr. Zaur Gasimov ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz. Zaur Gasimov (Hg.) (Hg.) Gasimov Zaur Vandenhoeck & Ruprecht www.v-r.de 9 783525 101223 V UUMS_Gasimov_VIEG_v2MS_Gasimov_VIEG_v2 1 005.03.125.03.12 115:095:09 Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz Abteilung für Universalgeschichte Herausgegeben von Johannes Paulmann Beiheft 90 Vandenhoeck & Ruprecht Kampf um Wort und Schrift Russifizierung in Osteuropa im 19.–20. Jahrhundert Herausgegeben von Zaur Gasimov Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN (Print) 978-3-525-10122-3 ISBN (OA) 978-3-666-10122-9 https://doi.org/10.13109/9783666101229 © 2012, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. -

Social Image of the Ural Region Mining Workers at the Post-Reform Time Period
Propósitos y Representaciones Aug. 2020, Vol. 8, SPE(2), e796 ISSN 2307-7999 Special number: Educational Psychology Practices in Europe and the Middle East e-ISSN 2310-4635 http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.796 RESEARCH NOTES Social Image of the Ural Region Mining Workers at the Post-Reform Time Period Imagen social de los trabajadores mineros de la región de los Urales en el período posterior a la reforma Yurii D. Korobkov Nosov Magnitogorsk State Technical University, 38 Lenin Avenue, 455000, Chelyabinsk Region, Magnitogorsk, Russia ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2084-3844 Elena M. Buriyak Nosov Magnitogorsk State Technical University, 38 Lenin Avenue, 455000, Chelyabinsk Region, Magnitogorsk, Russia ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5209-5262 Yevgenii V. Korobeynikov Nosov Magnitogorsk State Technical University, 38 Lenin Avenue, 455000, Chelyabinsk Region, Magnitogorsk, Russia ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8449-8357 Ilya O. Koldomasov Nosov Magnitogorsk State Technical University, 38 Lenin Avenue, 455000, Chelyabinsk Region, Magnitogorsk, Russia ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1527-6179 Tatiana G. Pashkovskaya Nosov Magnitogorsk State Technical University, 38 Lenin Avenue, 455000, Chelyabinsk Region, Magnitogorsk, Russia ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4589-2260 Received 01-12-20 Revised 01-25-20 Accepted 04-13-20 On line 06-29-20 *Correspondence Cite as: Email: [email protected] Korobkov, Y.D., Buriyak, E.M., Korobeynikov, Y.V., Koldomasov, I.O., & Pashkovskaya, T.G. (2020). Social Image of the Ural Region Mining Workers at the Post-Reform Time Period. Propósitos y Representaciones, 8 (SPE2), e796. Doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.796 © Universidad San Ignacio de Loyola, Vicerrectorado de Investigación, 2020. -
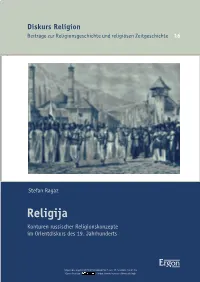
Open Access - Stefan Ragaz
DR Diskurs Religion 16 Beiträge zur Religionsgeschichte und religiösen Zeit ge schichte 16 Religija Stefan Ragaz Religija Konturen russischer Religionskonzepte im Orientdiskurs des 19. Jahrhunderts Stefan Ragaz ISBN 978-3-95650-783-0 https://doi.org/10.5771/9783956507847, am 17.12.2020, 18:21:16 Open Access - https://www.nomos-elibrary.de/agb Stefan Ragaz Religija https://doi.org/10.5771/9783956507847, am 17.12.2020, 18:21:16 Open Access - https://www.nomos-elibrary.de/agb DISKURS RELIGION BEITRÄGE ZUR RELIGIONSGESCHICHTE UND RELIGIÖSEN ZEITGESCHICHTE Herausgegeben von Ulrike Brunotte und Jürgen Mohn BAND 16 ERGON VERLAG https://doi.org/10.5771/9783956507847, am 17.12.2020, 18:21:16 Open Access - https://www.nomos-elibrary.de/agb Stefan Ragaz Religija Konturen russischer Religionskonzepte im Orientdiskurs des 19. Jahrhunderts ERGON VERLAG https://doi.org/10.5771/9783956507847, am 17.12.2020, 18:21:16 Open Access - https://www.nomos-elibrary.de/agb Diss-Info: Zugl.: Basel, Univ., Diss., 2020 Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Umschlagabbildung: Vasilij Vereščagin: Schiitische Muḥarram-Prozession in Schuscha, Bleistift auf Papier, 1865. Staatliches Museum für Religionsgeschichte, St. Petersburg. Wikimedia Commons Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Stefan Ragaz Publiziert von Ergon – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021 Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Umschlaggestaltung: Jan von Hugo www.ergon-verlag.de ISSN 2198-2414 ISBN 978-3-95650-783-0 (Print) ISBN 978-3-95650-784-7 (ePDF) DOI: 10.5771/9783956507847 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. -

Inventaire Du Fonds Schooneveld
C. H. van Schooneveld library p. 1 L van de Laar, Elisabeth Th. M., The Inner Structure of Wuthering Heights : a study of an imaginative field , The Hague 1969. no.23, De Proprietatibus Litterarum, series practica Laboratory of psycholinguistics of the University of Bucharest II, Survey of Research Activity (1972) 1973 Labov, William, The Social Stratification of English in New York City , Washington, D. C. 1966 Labuda, Gerard, Fragmenty dziejow slawianszczyzny zachodniej , Poznan vol.I 1960 Labuda, Gerard, Pierwsze panstwo slowianskie : panstwo samona , Poznan 1949. no.IV, Biblioteka historyczna, posnanskiego towarzystwa przyjaciol nauk Lachmann-Schmohl, Renate, Ignjat Dordic : eine stilistische Untersuchung zum slavischen Barock , Graz 1964. no.5, Slavistische Forschungen LACUS, Columbia, S.C. The First LACUS Forum 1974 (ed. Adam Makkai and Valerie Becker Makkai) 1975 The Second LACUS Forum 1975 (ed. Peter A. Reich) 1976 The Fourth LACUS Forum 1977 (ed. Michel Paradis), Columbis, S.C. 1978 The Fifth LACUS Forum 1978 (ed. Wolfgang Wölck and Paul L. Garvin), Columbia, S.C. 1979 Ladefoged, Peter, Elements of Acoustic Phonetics , Chicago 1962 Lado, Robert, Linguistics Across Cultures : applied linguistics for language teachers , Ann Arbor 1961 *Lagane, René and Jacqueline Pinchon, La norme , Paris 1972. no.16, Langue française Laichteruv vybor nejlepshich spisu pouchnych, Praha LIII, Jan Jakubec, Dejiny literatury cheske , I 1929 , II 1934 Laigonaite, A., Literaturines lietuviu kalbor kirchiavimas , Vilnius 1959 Lake Classical series, Chicago Selected Orations and Letters of Cicero (ed. Harold W. Johnston) 1906 Lakoff, George, Counterparts, or the Problem of Reference in Transformational Grammar , Bloomington, Ind. 1968. mimeograph, Indiana University linguistics club Lakoff, George, Pronouns and Reference , Bloomington, Ind. -
Regionalismus in Sibirien Im Frühen 20. Jahrhundert
Historisches Seminar der Universität zu Köln Abteilung für Osteuropäische Geschichte Regionalismus in Sibirien im frühen 20. Jahrhundert Vorgelegt von Stephan Stuch Köln Die vorliegende Dissertation ist von der Philosophischen Fakultät der Universität im Wintersemester 2001/2002 angenommen worden. Tag der mündlichen Prüfung war der 1. Februar 2002. Ich möchte mich bei den Betreuern der Promotion, Herrn Prof. Dr. Andreas Kappeler und Herrn Prof. Dr. Christoph Schmidt bedanken, ebenso bei Herrn Prof. Dr. Dittmar Dahlmann. Ein Teil der notwendigen Rechercheaufenthalte in Russland wurde durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes DAAD ermöglicht, wofür ich mich ebenfalls bedanken möchte. Nicht zuletzt danke ich sehr herzlich Frau Heike Wirtz und insbesondere Frau Elisabeth Richter, M.A., die die Entstehung der Arbeit mit Kritik und Anregungen begleitet haben. Berlin, im April 2003 Stephan Stuch Regionalismus in Sibirien im frühen 20. Jahrhundert Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierte in Sibirien eine Bewegung, die sich die Verfolgung regional definierter Ziele auf die Fahnen geschrieben hatte. Diese Bewegung, die von der bisherigen Forschung unter der Bezeichnung „sibirischer Regionalismus“ („sibirskoe oblastničestvo“) behandelt wurde, trat besonders in den 1860er Jahren und während der Revolutionsjahre 1905-1907 bzw. 1917/1918 in Erscheinung und erreichte ihren Höhepunkt mit der gleich zweifachen Ausrufung einer sibirischen Republik in der ersten Jahreshälfte 1918. Die vorliegende Dissertation konzentriert sich auf die Entwicklung des Regionalismus in Sibirien im frühen 20. Jahrhundert, zwischen der ersten russischen Revolution von 1905 und den ersten Jahren sowjetischer Herrschaft. Auf der Grundlage einer theoretischen Betrachtung der mit „Regionalismus“ verbundenen Erscheinungen werden die mentalen und kulturellen Grundlagen des sibirischen Regionalismus sowie die soziale Basis der regionalistischen Bewegung, ihre Organisationsformen und politischen Ziele untersucht. -

The Case of Durak Durakom 'A Fool Times Two'
Russ Linguist (2020) 44:109–127 https://doi.org/10.1007/s11185-020-09225-y Constructions, their families and their neighborhoods: the case of durak durakom ‘a fool times two’ Конструкции, их семьи и соседи: «Дурак дураком» Laura A. Janda1 · Mihail Kopotev2 · Tore Nesset1 Published online: 20 July 2020 © The Author(s) 2020 Abstract On the basis of data from the Russian National Corpus, we analyze the mean- ings and structure of the syntactic construction observed in phrases like durak durakom ‘fool-nom.sg fool-ins.sg’, which we term the ‘NOM∼INS construction’. We argue that the construction constitutes a network of three closely related subcategories, which we refer to as ‘Extreme’, ‘Paragon’ and ‘Discourse Change’. It is furthermore shown that a diachronic change has taken place, whereby Discourse Change has overtaken Extreme as the dominant subcategory. Our analysis provides ample evidence for the main tenets of Construction Gram- mar, namely that a language is a network of related constructions, that meaning is often not compositional, that there is a continuum from idiomatic to schematic uses of constructions, and that constructions evolve over time. Аннотация В статье на основе Национального корпуса русского языка анализируют- ся значение и структура синтаксической конструкции типа ‘Дурак дураком’, которую мы для краткости обозначаем ‘NOM∼INS’. Мы показываем, что указанная конструк- ция представляет собой радиальную категорию, состоящую из трёх взаимосвязанных подтипов, которые в соответствии с их значением можно назвать ‘экстремальный’ (‘Extreme’), ‘образцовый’ (‘Paragon’) и ‘смена дискурса’ (‘Discourse Change’). В ста- тье показано, что в процессе диахронического развития подтип со значением ‘смена The research for this paper was financially supported by the Russian Science Foundation, project “Structures with lexical repetitions from the viewpoint of contemporary linguistic theories” No. -

Social and Behavioural Sciences Phr 2019 Philological Readings
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS www.europeanproceedings.com e-ISSN: 2357-1330 DOI: 10.15405/epsbs.2020.04.02.56 PhR 2019 Philological Readings SPECIFICITY OF RUSSIAN NATURALISM. NATURALISTIC TENDENCIES IN A.P. CHEKHOV WORKS Olga N. Provatorova (a)* *Corresponding author (a) Department of Russian Philology and Methods of Teaching Russian, Orenburg State University, 13, Pobedy Avenue, Orenburg, Russia, [email protected] Abstract In the article naturalism is defined as a separate method which had arisen in the end of 19th century, emerged and was realized in the works of second- and third- rate authors and mass literature. In the Russian literature of the final third of the 19th century there were reflected principals of Zola’s naturalistic concept, but another historical conditions and characteristics of Russian mentality such as prevalence of spiritual and ideal over physical and material all these determined national identity of Russian naturalism. It is legitimate to take into consideration the influence of naturalism on the works of the greatest writers including A. P. Chekhov. That is why there is such terminology as «naturalistic tendencies» and «naturalistic colours», which are necessary to establish this phenomenon in Chekhov’s works as a realist writer. Scientific novelty of the study can be seen in the fact that it is the first time in the literature when the influence of naturalism on the A. P. Chekhov works is proved and naturalistic tendencies in A. P. Chekhov novels of 1880s («The Mire», «The Witch») are considered. Story theme, which was relevant for that time, had required naturalistic view used by Chekhov to create an image of a «beast in man», to intensify an impression from created realistic human character and reality. -

Firmenzüge Der Russischen Eisenbahn
Firmenzüge der russischen Eisenbahn Der Eisenbahnverkehr zählt in Russland traditionell zu den gefragtesten und populärsten Verkehrsmitteln des Landes. Die russische Bahn legt seit einigen Jahren erhöhten Wert auf Komfort und Sicherheit. Zu diesem Zweck gibt es in Russland ein System von ca. 100 so genannten Firmenzügen. Der 1. Firmenzug wurde bereits 1931 zwischen Moskau und St.Petersburg als „Krasnaja Strela“ in Betrieb genommen. Die Firmenzüge verkehren zwischen den größten Städten Russlands und des nahen Auslands. Alle Züge haben gegenüber den „normalen“ Zügen bessere Ausstattung, Komfort, Service und Sicherheitsvorrichtungen. Die Firmenzüge haben eigene Namen mit Bezug auf die befahrene Region oder regionale Kultur und Geschichte. Hier finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Firmenzüge der russischen Eisenbahn: Name des Zuges Route Jarmarka Nishni Novgorod-Moskau Turgenev Moskau-Simferopol Ivan Paristyi Brjansk-Moskau Solovej Moskau-Kursk Rossija Moskau-Wladiwostok Pomorje Moskau-Severodwinsk Slawjanksij Express Moskau-Minsk Poljarnaja Strela Moskau-Labytnangi Stolitschnyi Express Moskau-Kiew Kostenpflichtiges Angebot im Abteil Speisewagen Krasnaja Strela St.Petersburg-Moskau 1 von 5 Sputnik Travel GmbH, Stresemannstraße 107, 10963 Berlin Tel: 030-20454581, Fax: 030-20455998, E-Mail: [email protected] Express St.Petersburg-Moskau Afanassi Nikitin St.Petersburg-Moskau Lew Tolstoi Moskau-Helsinki Smena St.Petersburg-Moskau Pskow Pskow-Moskau Repin St.Petersburg-Helsinki Junost St.Petersburg-Moskau Nikolajewskij Express St.Petersburg-Moskau -
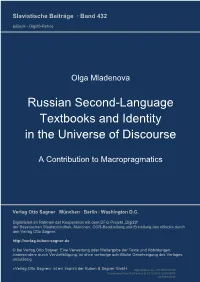
Russian Second-Language Textbooks and Identity in the Universe of Discourse
Slavistische Beiträge ∙ Band 432 (eBook - Digi20-Retro) Olga Mladenova Russian Second-Language Textbooks and Identity in the Universe of Discourse A Contribution to Macropragmatics Verlag Otto Sagner München ∙ Berlin ∙ Washington D.C. Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner: http://verlag.kubon-sagner.de © bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig. «Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH. Olga Mladenova - 9783954796335 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:04:08AM via free access Sl a v i s t i c h e Be it r ä g e Herausgegeben von Peter Rehder Beirat: Tilman Berger • Walter Breu •Johanna Renate Döring-Smirnov Walter Koschmal • Ulrich Schweier • Milos Sedmidubskÿ • Klaus Steinke BAND 432 V erlag O tto Sagner M ü n c h e n 2004 Olga Mladenova - 9783954796335 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:04:08AM via free access 00055998 Olga Mladenova Russian Second-Language Textbooks and Identity in the Universe of Discourse A Contribution to Macropragmatics V erlag O tto Sagner M ü n ch en 2004 Olga Mladenova - 9783954796335 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:04:08AM via free access '0065998 PVA 2004. 1143 ISBN 3-87690-881-7 Ѳ Verlag Otto Sagner, München 2004 Abteilung der Firma Kubon & Sagner D-80328 München Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier Bayerische Staatsbibliothek München Olga Mladenova - 9783954796335 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:04:08AM via free access ^־־*׳׳־' 04 יל 4 0 00055998 Table of Contents Foreword vu I. -

Prepositions: a Corpus-Based Study Dissertation
The Semantics of Russian 'About' Prepositions: A Corpus-Based Study Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Andrew James Kier, B.M., M.A., M.A. Slavic and East European Languages and Literatures The Ohio State University 2013 Dissertation Committee: Daniel Collins, Advisor Charles Gribble Brian Joseph Copyright by Andrew James Kier 2013 Abstract This study examines, for the purpose of comparison, the semantic content of several important prepositions in modern Russian which translate ‘about, concerning’. It focuses primarily on the two primary prepositions o+LOC and pro, and includes the two secondary prepositions nasčet and po povodu, which also translate ‘about, concerning’. Historically, several scholars have acknowledged that o+LOC and pro express slightly different nuances, although the exact nature of these nuances has become less clear over time (Peškovskij 1928/2001, Vinogradov 1947/2001). How has pro survived and remained productive, if the distinction between it and o+LOC has been fading for so long? Vinogradov predicted its demise in the 1940’s, yet it still enjoys a robust presence in both the spoken and written language of the present day. Furthermore, pro in the ‘about’ sense is historically neither rare nor limited to the recent past. Likewise, nasčet and po povodu (both fairly recent additions to the stable of Russian prepositions), which have both undergone subtle lexical shifts of their own in the past few ii centuries (Čerkasova 1967), are also in need of a more articulated semantic description. -

Jahresbericht 2017 Jahresbericht Jahresbericht 2017
Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien JAHRESBERICHT 2017 JAHRESBERICHT JAHRESBERICHT 2017 IV Annual Conference of the Graduate School for East and Southeast GRADUIERTENSCHULE FÜR OST- UND SÜDOSTEUROPASTUDIEN European Studies in cooperation with School of Slavonic and East European Studies, University College London Gestaltung: Holger W. John; Illustration: Tine Schmid John; Illustration: Tine Gestaltung: Holger W. 1–3 JUNE 2017 THURSDAY, JUNE 1 18.00 – 20.00 18.00 – 19.30 www.gsoses.de REGENSBURG KEYNOTE: THE POPULIST EXPLOSION: ÖFFENTLICHES PODIUMSGESPRÄCH IN DEUTSCHER SPRACHE Das fünfte Jahr How the Great Recession Transformed DAS ENDE DER LIBERALEN ORDNUNG ? Landshuter Str. 4 American and European Politics Zentral-, Ost- und Südosteuropäischer Room 319 (3rd floor) John B. Judis (Washington) Populismus im Vergleich Chair: Ger Duijzings (Regensburg) Andreas Ernst (Belgrad/Zürich), Boris Schumatsky (Berlin) Please register until und Reinhold Vetter (Warschau/Berlin), May 22, 2017 via email: Moderation: Marie-Janine Calic (München) [email protected] FRIDAY, JUNE 2 9.00 – 17.45 THE LANGUAGE OF POPULISM SATURDAY, JUNE 3 9.00 – 16.00 KEYNOTE: Michał Krzyz˙anowski (Örebro) Chair: Björn Hansen (Regensburg) HISTORICAL TRAJECTORIES Daniel Weiss (Zurich), Tanja Zimmermann (Leipzig), KEYNOTE: Jan Kubik (London) Peter Zusi (London) Chair: Martin Schulze Wessel (Munich) Egbert Klautke (London), Elizabeth White (Bristol), TYPOLOGIES OF POPULISM Balázs Trencsényi (Budapest) KEYNOTE: Gwendolyn Sasse (Berlin) Chair: Melanie Arndt (Regensburg)