San Marco in Syivis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exporting the Cult of Martyrs to Lands of Exile. the Communities of Banished Italians in France and Piedmont-Sardinia in the Early 1850S Pierre-Marie Delpu
Exporting the cult of martyrs to lands of exile. The communities of banished Italians in France and Piedmont-Sardinia in the early 1850s Pierre-Marie Delpu To cite this version: Pierre-Marie Delpu. Exporting the cult of martyrs to lands of exile. The communities of banished Italians in France and Piedmont-Sardinia in the early 1850s. Catherine Brice. Exile and the circulation of political practices, Cambridge Scholars Publishing, 2020, 978-1527548121. halshs-02924904 HAL Id: halshs-02924904 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02924904 Submitted on 28 Aug 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Exporting the cult of martyrs to lands of exile. The communities of banished Italians in France and Piedmont-Sardinia in the early 1850s Pierre-Marie Delpu 1. Exile and martyrdom, two tools for mass liberal politicisation The aftermath of the 1848 European revolutions saw significant increase in political exiles. The drift back towards authoritarian monarchies, coupled with the new role played by measures to take in political migrants in certain European states (France, Great Britain, and Piedmont), contributed to a massive increase in their number and the generalisation of the practice of exile. -

Alessandro Poerio Fin Dallautunno Del 1895, Visitando La Mostra Del
ALESSANDRO POERIO ’ v Fin dall autunno del 1895, isitando la Mostra del Risorgi mento italiano inaugurata nella Vittorio Emanuele per la cura nte e intelli ente dello noli fet di uella Bi li teca pazie d g G , pre to q b o , ’ d i cui mi sorse l i ea di pubblicare gli autografi da me possedut , fra ’ i i n lia oerio . più mportanti appartene ti , a Pepe ed alla famig P i lmo or a o vevano al n rale aliante Gugl e e Fl est n Pepe scri ge e V , vo m n m d h da Dir torio fu messo a Mar a ater o di io pa re , c e l et ’ ’ ’ Il siglia a capo d una commissione d ausilio pe profughi italiani . barone Giuseppe Poerio fu avvocato di mia famiglia ed amico ca i iva n l 1 4 E li riheiwa di mio nonno sicchè quando quest mor e 8 0, g , scriveva a mio padre : la sua perdita mi è di tanto dolore che dovete considerarmi come un m embro della vostra famiglia ' n i Possedevo uindi tutta che soflre e pia ge con tu tti Vo l ) . q l a 1 8 6 di i se e e arlo oerio una collezione di ettere d l 0 , G u pp C P , - l ssa dro Giacché di Carolina e Luisa Sossi Sergio e liriche di A e n . ’ ’ ra i fi liuoli Durante la l amicizia de padri continuò fraterna t g . o d a e e are orea nulla faceva ch e galera di Carl , il i lui cur tor C s C , prima non si fosse consultato con mio padre ; e fu continua fra ’ l l i l nza d l com arato che nel m ez la famig ia Poerio e a m a, usa e p , ’ ’ zodì d Italia ha quasi forza d un vincolo di parentela ; consuetu v d a 1 i ri ae tano d l iu d ice . -

The Original Documents Are Located in Box 16, Folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R
The original documents are located in Box 16, folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Copyright Notice The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Gerald R. Ford donated to the United States of America his copyrights in all of his unpublished writings in National Archives collections. Works prepared by U.S. Government employees as part of their official duties are in the public domain. The copyrights to materials written by other individuals or organizations are presumed to remain with them. If you think any of the information displayed in the PDF is subject to a valid copyright claim, please contact the Gerald R. Ford Presidential Library. Digitized from Box 16 of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library 792 F TO C TATE WA HOC 1233 1 °"'I:::: N ,, I 0 II N ' I . ... ROME 7 480 PA S Ml TE HOUSE l'O, MS • · !? ENFELD E. • lt6~2: AO • E ~4SSIFY 11111~ TA, : ~ IP CFO D, GERALD R~) SJ 1 C I P E 10 NTIA~ VISIT REF& BRU SE 4532 UI INAl.E PAL.ACE U I A PA' ACE, TME FFtCIA~ RESIDENCE OF THE PR!S%D~NT !TA y, T ND 0 1 TH HIGHEST OF THE SEVEN HtL.~S OF ~OME, A CTENT OMA TtM , TH TEMPLES OF QUIRl US AND TME s E E ~oc T 0 ON THIS SITE. I THE CE TER OF THE PR!SENT QU?RINA~ IAZZA OR QUARE A~E ROMAN STATUES OF C~STOR .... -

Vico, Hegel and a New Historicism
Hegelians on the Slopes of Vesuvius: A Transnational Study in the Intellectual History of Naples, 1799-1861 Alessandro De Arcangelis, University College London Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University College London, April 2018 I, Alessandro De Arcangelis, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 Acknowledgments I would like to express my gratitude to all the people who supported me in this challenging and exciting journey and contributed, in many ways, to its development and completion. Working with my main supervisor, Prof. Axel Körner, has been a terrific experience and I am deeply grateful for his undefeated enthusiasm, impeccable support, steady encouragement and, above all, for offering me so many opportunities to grow as a researcher. My second supervisor, Prof. Avi Lifschitz, has always been a dedicated mentor, whose point of view has been helping me improve my way of engaging with intellectual history since the very first day of my MA degree in 2013. I genuinely hope that the future may hold many more opportunities for me to work with them. A special mention goes to Dr. Fernanda Gallo: our common passion for Neapolitan Hegelianism has introduced us to a priceless friendship and enabled us to work together on several projects during the last year. Dr. Maurizio Isabella provided me with useful comments that greatly helped my argument to come into focus, as did Prof. Gareth Stedman Jones in 2015 and 2017. I also want to thank Dr. -

Studi Desanctisiani
STUDI DESANCTISIANI rivista internazionale di letteratura, politica, società 1 · 2013 estratto PISA · ROMA FABRIZIO SERRA EDITORE MMXIII Direttori / Editors Toni Iermano · Pasquale Sabbatino Comitato Editoriale / Editorial Board Clara Allasia (Università degli Studi di Torino) Johannes Bartuschat (Universität Zürich) Gerardo Bianco (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, Roma) Rino Caputo (Università degli Studi Tor Vergata, Roma) Gabriele Clemens (Universität des Saarlandes) Silvia Contarini (Université de Paris x, Nanterre) Costanza D’Elia (Università degli Studi di Cassino) Pasquale Guaragnella (Università degli Studi di Bari) Paolo Macry (Università degli Studi di Napoli «Federico II») Nelson Moe (Columbia University, New York) Paolo Saggese (Parco Letterario «Francesco De Sanctis») Gino Tellini (Università degli Studi di Firenze) Segreteria di redazione / Secretary Board Vincenzo Caputo (Napoli) · Giuseppe Varone (Cassino) Indirizzo di invio dei materiali: Toni Iermano, Dipartimento di Lettere e Filosofia Via Zamosch 43, i 03043 Cassino (Fr), [email protected] Pasquale Sabbatino, [email protected] * Si invitano gli autori ad attenersi, nel predisporre i materiali da consegnare alla Redazione e alla Casa editrice, alle norme specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali, Pisa · Roma, Serra, 20092 (ordini a: [email protected]). Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., consultabile Online alla pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net. «Studi desanctisiani» is a Peer-Reviewed Journal. « LA SVENTURA NON È GIUNTA A DOMARMI ». DE SANCTIS NELL’ESILIO CALABRESE TRA LEOPARDI E LA SCONFITTA DELLA RIVOLUZIONE Toni Iermano Chi scioglierà l’enigma de’ nostri tempi ? F. De Sanctis, Delle « Opere drammatiche » di Federico Schiller, 1850 Vendetta unica ch’è forse lecito all’uomo dabbene, e che fa la disperazione e la rabbia dei suoi nemici : mirarli in faccia e ridere e disprezzarli.. -

Tesi Focetola.Pdf
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA Facoltà di Lettere e Filosofia Dipartimento di Filologia Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie. Retorica e Tecniche dell'Interpretazione XXII ciclo Settore disciplinare M- STO/08 Tesi di Dottorato Gli SCIIttOII calabresi neli'editoria napoletana del XIX secolo Coordinatore saMarghetaGEffl Supervisore Candidata Prof.ssa Carmela REALE DanielaFOC TOLA LL b3JQQs INDICE GENERALE Introduzione………………………………………p. 2 I Capitolo………………………………………….p. 5 II Capitolo…………………………………………p. 26 III Capitolo………………………………………..p.125 Catalogo…………………………………………...p.164 Indice biografico………………………………....p.317 Indice cronologico……………………………….p.389 Indice delle tipografie…………………………...p.393 Bibliografia……………………………………….p.405 1 Introduzione Il lavoro di ricerca, all’interno del settore di studi relativo alla bibliografia e alla storia della stampa e dell’editoria, si è concentrato su una realtà considerata a volte marginale e minore nel più generale panorama bibliografico italiano ossia lo scenario tipografico-editoriale del mezzogiorno d’Italia, in particolare essa prende in esame gli scrittori calabresi che nel corso del XIX secolo affidarono le proprie opere ai torchi della capitale partenopea. Essa è il frutto di un paziente lavoro di spoglio di una serie di repertori sia di carattere generale (come ad esempio CLIO, DBI, SBN) sia repertori di interesse locale quali ad esempio le opere di Valente, Capialbi, Borretti, Accattatis, Aliquò Lenzi, Andreotti, Falcone e molti altri. Il cuore della tesi è rappresentato dal Catalogo che offre in sequenza alfabetica le opere di scrittori calabresi editi a Napoli nel corso dell’Ottocento. Esso può definirsi un vero e proprio repertorio bibliografico circoscritto nel tempo e nello spazio, che si propone di registrare ed esaminare la realtà tipografica e quindi culturale di uno tra i centri editoriali più importanti del Sud della penisola nel corso del secolo decimo nono. -

Pubblicazione Poerio a Montesarchio.Pdf
GenealogiaestoriadellafamigliaPoerio GiuseppePoerio,padreepatriota AlessandroPoerio,poetaesoldatodellalibertà CarloPoerio,difensoredelpopoloedeldiritto Durante l'intero medioevo e nei secoli successivi i Normanni, gliAngioini e gliAragonesi utilizzarono quella che è diventata l'attuale Montesarchio come appetibile merce di scambio per ingraziarsi ed ottenere i favori dei “signorotti” di turno. Da casato in casato si giunse così ai D'Avalos, i quali conservarono il principato per oltre 340 anni. In particolare, Alfonso è ricordato per avere concesso il castello a Ferdinando II di Borbone; questi lo trasformò, insieme alla torre, in prigione di Stato. Fu proprio in quel periodo che molti valorosi uomini di Montesarchio, mossi da un fervido patriottismo, presero parte attiva ai moti napoletani, scrivendo indelebili pagine di storia. Attraverso le società segrete, i moti rivoluzionari e l'opera dei pensatori, patrioti e poeti nei loro scritti cominciarono a diffondere le idee di libertà, di unità e di indipendenza. Tra i “ribelli” c'erano professionisti, avvocati, possidenti, artigiani, classe media e anche qualche nobile cui non mancava di certo il benessere eppure misero in gioco tutto, alcuni di essi anche la vita. Questi autori del "canone risorgimentale" furono capaci di un' operazione quasi prodigiosa: dar vita, grazie a una straordinaria costruzione retorica, a qualcosa che non esisteva nella realtà e cioè la nazione italiana. Essi non volevano affermare ideali di forza, di potenza, di superiorità, ma al contrario volevano difendere, con moderazione, il diritto alla libertà, per cooperare con altri popoli alla creazione di un mondo fondato su ideali di giustizia, di comprensione, di pacificazione, di convivenza rispettosa. La memoria storica di questi valorosi uomini va conservata ed il comune di Montesarchio intende ricostituire, prima di tutto, le fonti della sua storiae le fonti d'archivio che sono la base prioritaria per il periodo moderno e contemporaneo. -

Piperno Temporalities and Fractures in Post-Napoleonic Italy Final
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/79412 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications TEMPORALITIES AND FRACTURES IN POST -NAPOLEONIC ITALY : LEOPARDI AND VICO ’S LEGACY by Martina Piperno A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Italian Studies University of Warwick, School of Modern Languages and Cultures March 2016 TEMPORALITIES AND FRACTURES IN POST -NAPOLEONIC ITALY : LEOPARDI AND VICO ’S LEGACY TABLE OF CONTENTS Acknowledgements ………………………………………………...... p. 4 Declaration …………………………………………………………... p. 5 Abstract ……………………………………………………………… p. 6 Abbreviations ………………………………………………………... p. 7 INTRODUCTION ………………………………………………………. p. 8 1. The Main Research Questions. Vico’s Legacy, Vico’s ‘Heir’…………… p. 8 2. Existing Scholarship and Its Gaps………………………………………... p. 11 3. Diffraction as a Methodological Framework……………………………... p. 18 4. Diffractive Mapping. Organization of the Material in this Work………… p. 29 Chapter 1. FROM NAPLES TO VENICE AND LOMBARDY The Oblique Paths of Vico’s Interpretation(s) (1708-1815) ……… p. 35 1. 1 – Naples 1708: An Italian Response to the ‘Querelle Des Anciens et des Modernes’……………………………………..………………………… p. 36 1. 2 – Venice 1763: Translating and Mediating the Ancient World……….. p. 48 1. 3 – Vico in Lombardy (1800-1815): Post-Revolutionary ‘Vichismo’ and the Revision of Italian Identity……………………………………………… p. -

Bibliografia Unificata Degli Scritti Di Francesco Novati*
BIBLIOGRAFIA UNIFICATA DEGLI SCRITTI DI FRANCESCO NOVATI* 1. PREMESSA na recente mostra dedicata a Francesco Novati (1859-1915), alle- U stita a Brera sotto gli aspici della Biblioteca Nazionale Braidense e della Società Storica Lombarda,1 ha rilanciato, insieme ai necessari lavori di puntualizzazione e focalizzazione biografica, anche gli studi sull’ope- ra critica del filologo cremonese, tra i quali si inserisce a pieno titolo la presente edizione – aggiornata, corretta ed emendata – della bibliografia completa dei suoi scritti. Il lavoro, che parte dagli studi preparatori alla tesi di dottorato di Leonardo Andreoli (2010-2011: XVII-LXXXIX), sistema in forma uni- taria e definitiva il mare magnum della produzione scientifica edita di No- vati (costituita da volumi, saggi, capitoli di libri, articoli in rivista, testi di conferenze e d’occasione, recensioni, necrologie, articoli di giornale, scritti letterari, lettere) che era già stata oggetto di quattro distinte bi- bliografie (Cochin 1909; Sepulcri 1917; Dervieux 1935; Gonelli 1980), ciascuna delle quali incompleta o portatrice di notizie parziali e talora imprecise o scorrette. Il riordino su base cronologica dell’ampia produzione di Novati fa- vorisce la sondabilità dei campi d’indagine nei quali lo studioso ha ope- rato e, nel contempo, permette la piena intelligenza dello stato dell’arte della produzione critica dello studioso, premessa necessaria a ogni rilet- tura della sua complessa fisionomia intellettuale. Durante la sua pur bre- ve esistenza, Novati sviluppò ricerche occupandosi di argomenti all’ap- parenza diversissimi e lontani tra loro, ma a ben vedere ricollegati e in- * Il presente lavoro, frutto di un’idea condivisa dai due autori, è cosí articolato: il § 1 è a firma congiunta, il § 2 è di Roberto Tagliani, il § 3 è di Leonardo Andreoli; il ma- teriale del § 4 è stato raccolto, trascritto, ordinato, riscontrato sugli originali e indiciz- zato da Leonardo Andreoli, con la supervisione editoriale finale di Roberto Tagliani. -
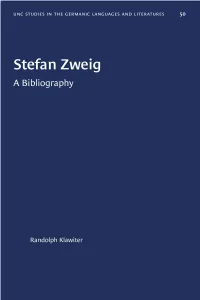
Stefan Zweig
Stefan Zweig From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Stefan Zweig A Bibliography randolph j. klawiter UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 50 Copyright © 1965 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Klawiter, Randolph J. Stefan Zweig: A Bibliography. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1965. doi: https:// doi.org/10.5149/9781469657660_Klawiter Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Klawiter, Randolph J. Title: Stefan Zweig : A bibliography / by Randolph J. Klawiter. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 50. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1965] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. Identifiers: lccn 65003222 | isbn 978-1-4696-5765-3 (pbk: alk. paper) | isbn 978-1-4696-5766-0 (ebook) Subjects: Zweig, Stefan, 1881-1942 — Bibliography. Classification: lcc pd25 .n6 no. 50 | dcc 016/ .838912 PREFACE To compile a completely comprehensive bibliography is a task as futile as it is seemingly vain.