Emma Ivon Al Veglione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
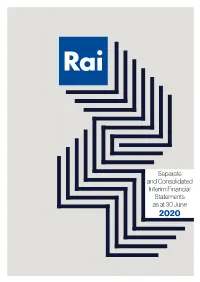
Separate and Consolidated Interim Financial Statements As at 30 June 2020
Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Contents 7 Introduction 17 Report on Operations 171 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 239 Interim Consolidated Financial Statements as at 30 June 2020 303 Corporate Directory 4 Contents Introduction 7 Corporate Officers 8 Organisational Structure 9 Introduction from the Chairman of the Board of Directors 11 Financial Highlights 12 Report on Operations 17 Mission 18 Market scenario 18 The Rai Group 24 Television 41 Radio 97 RaiPlay and Digital 107 Public broadcasting service function 116 TV production 119 Technological activities 120 Transmission and distribution activities 129 Sales activities 130 Other activities 135 Changes in the regulatory framework 143 Corporate governance 148 Corporate Governance Report - the Rai Control Governance Model and the Internal Control and Risk Management System (SCIGR) 150 Other information 155 Human Resources and Organisation 155 Safety & Security 159 Intercompany Relations 161 Significant events occurring after 30 June 2020 168 Outlook of operations 168 5 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 171 Analysis of the results and performance of operating results, financial position and cash flows for the first half of 2020 172 Financial Statements of Rai SpA 186 Notes to the Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 191 Certification pursuant to article 154-bis of Italian Legislative Decree 58/98 235 Independent -

Gfk Italia CERTIFICAZIONI ALBUM Fisici E Digitali Relative Alla Settimana 47 Del 2019 LEGENDA New Award
GfK Italia CERTIFICAZIONI ALBUM fisici e digitali relative alla settimana 47 del 2019 LEGENDA New Award Settimana di Titolo Artista Etichetta Distributore Release Date Certificazione premiazione ZERONOVETOUR PRESENTE RENATO ZERO TATTICA RECORD SERVICE 2009/03/20 DIAMANTE 19/2010 TRACKS 2 VASCO ROSSI CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2009/11/27 DIAMANTE 40/2010 ARRIVEDERCI, MOSTRO! LIGABUE WARNER BROS WMI 2010/05/11 DIAMANTE 42/2010 VIVERE O NIENTE VASCO ROSSI CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2011/03/29 DIAMANTE 19/2011 VIVA I ROMANTICI MODA' ULTRASUONI ARTIST FIRST 2011/02/16 DIAMANTE 32/2011 ORA JOVANOTTI UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2011/01/24 DIAMANTE 46/2011 21 ADELE BB (XL REC.) SELF 2011/01/25 8 PLATINO 52/2013 L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2011/11/28 8 PLATINO 52/2013 TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO TIZIANO FERRO CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2014/11/25 8 PLATINO 15/2017 MONDOVISIONE LIGABUE ZOO APERTO WMI 2013/11/26 7 PLATINO 18/2015 LE MIGLIORI MINACELENTANO CLAN CELENTANO SRL - PDU MUSIC SONY MUSIC ENTERTAINMENT 2016/11/11 7 PLATINO 12/2018 INEDITO LAURA PAUSINI ATLANTIC WMI 2011/11/11 6 PLATINO 52/2013 BACKUP 1987-2012 IL BEST JOVANOTTI UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2012/11/27 6 PLATINO 18/2015 SONO INNOCENTE VASCO ROSSI CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2014/11/04 6 PLATINO 39/2015 CHRISTMAS MICHAEL BUBLE' WARNER BROS WMI 2011/10/25 6 PLATINO 51/2016 ÷ ED SHEERAN ATLANTIC WMI 2017/03/03 6 PLATINO 44/2019 CHOCABECK ZUCCHERO UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2010/10/28 5 PLATINO 52/2013 ALI E RADICI EROS RAMAZZOTTI RCA ITALIANA SONY MUSIC ENTERTAINMENT 2009/05/22 5 PLATINO 52/2013 NOI EROS RAMAZZOTTI UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2012/11/13 5 PLATINO 12/2015 LORENZO 2015 CC. -

Carlo Goldoni As Musical Reformer
CARLO GOLDONI AS MUSICAL REFORMER IN SEARCH OF REALISM IN THE DRAMMA GIOCOSO La vraisemblance doit toujours être la principale règle, et sans laquelle toutes les autres deviennent déréglées. -l’Abbé d’Aubignac, La Pratique du Théâtre by Pervinca Rista Dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Baltimore, Maryland March 18, 2015 © Pervinca Rista All Rights Reserved Abstract Venetian playwright Carlo Goldoni (1707-1793), who is best remembered in literary history for his realist ‘reform’ of comic theatre, was also a prolific librettist. In particular, his texts for music written from 1748 onwards remain understudied but warrant significant reappraisal, for Goldoni was one of the first to give shape to the dramma giocoso, an innovative and realistic new genre of opera that went on to have a lasting legacy all the way to W. A. Mozart and Lorenzo da Ponte. Through an interdisciplinary, historical approach and intertextual analysis, the present study reevaluates Goldoni’s drammi giocosi, largely overlooked by scholarship, to uncover the lasting innovations in form and content introduced by the Venetian playwright. Analysis of these texts also reveals clear affinity between Goldoni's contributions to the dramma giocoso and his reform of prose theatre. Most importantly, unlike other types of comic opera, the dramma giocoso has the particularity of combining buffo with serio, a dynamic that, through Goldoni's mature output, continually evolves to bring new realism and social relevance to opera theatre. Goldoni’s influence on this type of musical representation has not been fully considered, but the realism in music that he achieves through the dramma giocoso must be acknowledged as a lasting contribution to modern literature, and to operatic history. -

Italian Artists Mon, 30
Italian Artists www.redmoonrecords.com Artist Title ID Format Label Print Catalog N° Condition Price Note 24 GRANA Underpop 32842 1xCD La canzonetta Self IT 80124323000292 USED 8,00 € Digipack 360 GRADI Farenight 16088 1xCD Universal EU 731454280723 USED 7,00 € 6 SUOI EX Paola non è un uomo 10701 1x12" Emergency music IT 74321-10125-1 EX+/EX 6,00 € BMG 883 1 in + 3370 1xCD Warner GER USED 7,00 € 883 Grazie mille 19068 1xCD Marton corp. RTI IT 5099749617421 USED 7,00 € Without OBI & 3D glasses 883 / MAX PEZZALI Hanno ucciso l'uomo ragno 2012 33892 1xCD Atlantic Warner EU 5053105299829 USED 7,00 € 99 POSSE Corto circuito 13061 1xCD RCA BMG EUEU 0743215804222 USED 7,00 € Enhanced CD 99 POSSE Comincia adesso remix (9 tracks+1 video track) 25305 1xCDs Tutto IT none USED 3,00 € Free CD with magazine "Tutto" - Enhanced CD 99 POSSE Cerco tiempo 26275 2xCD BMG Ricordi IT 0743215707226 USED 10,00 € 99 POSSE Cattivi guagliuni 27940 1xCD Musica Posse / IT 8033954531483 USED 8,00 € Novenove / Artist first 99 POSSE La vida que vendrà 27980 1xCD Novenove BMG IT 0743217370022 USED 8,00 € Ricordi 99 POSSE NA 90 10° 29768 2xCD Novenove RCA BMG IT 0743218952128 USED 10,00 € A.L.I.A.S. Se io se lei (2 tracks) 14059 1xCDs Clacsonic Universal IT 9810438 USED 3,00 € ABIOGENESI Le notti di Salem 5931 1xCD Black widow IT BWRCD046-2 12,90 € ACCADEMIA Accademia in classics part one & two 17119 1x7" Ariston Ricordi IT AR/00930 EX/EX 3,00 € ACID GROUP Dedicato 23039 1xCD Giallo records IT SAF030 USED 22,00 € ACQUA FRAGILE Mass-media stars 18908 1xCD RCA Sony EU 0888430999824 -

Ricochet 2004 Rriiccoocchheett
Irene Schiavetta RICOCHET 2004 RRIICCOOCCHHEETT di Irene Schiavetta Nel regno della Regina di Fiori vive il musico Ricochet. Gli si offre l'opportunità di compiere un viaggio nel mondo reale, dove spera di trovare l'ispirazione per le sue composizioni. Si troverà così a Parigi, nel pieno del carnevale… PERSONAGGI N.B.: alcuni personaggi possono essere interpretati dalla stessa persona in quanto non compaiono mai simultaneamente. Parti recitate e cantate: RICOCHET, musico di corte GARAFALDO, servitore; cammina ingobbito, zoppicando GARAFALDA, sua moglie; donna molto bella GRAN CIAMBELLANO REGINA DI FIORI REGINA DI CUORI SCIACCARETTA, maschera Parti recitate: CARAMELLA, ancella GIROMINA, ancella SCRIFFELIA, ancella SPECCHIO MAGICO UN PAGGIO CAVALIERE DI CUORI MONSIEUR LEBLANCHE MADAME LEBLANCHE COSIMO, cameriere GRANDE ASSO DUE DI PICCHE QUATTRO 'QUATTRO' GENDARME PRIMA MASCHERA SECONDA MASCHERA TERZA MASCHERA Gruppi corali: ANCELLE BAMBINI, figli di Garafaldo e Garafalda SEGNI MUSICALI: note, pause, chiavi di violino, pentagrammi ecc. MASCHERE di CARNEVALE Comparse: Ancelle Spargitrici di fiori Cortigiani dei Fiori Cortigiani dei Cuori Maschere Danzatori: Arlecchino e Colombina 1 Irene Schiavetta RICOCHET 2004 PRIMO ATTO SCENA I Nella stanza da musica di Ricochet, musico della Regina di Fiori. Buio; è illuminato solo Ricochet Ricochet, i Segni Musicali, poi Gran Ciambellano. RICOCHET - (suona l’organo con ferrea concentrazione) SEGNI MUSICALI - (entrano poco a poco mentre la luce si allarga; per un po' danzano e giocano sulla musica) GRAN CIAMBELLANO – (entra) RICOCHET – (non nota il Gran Ciambellano, continua a suonare) SEGNI MUSICALI – (spaventati dal Gran Ciambellano, corrono a nascondersi) SCENA II Gran Ciambellano, Ricochet, Garafaldo, poi Segni Musicali GRAN CIAMBELLANO - (si ferma ad ascoltare, poi, piuttosto seccato, si avvicina a Ricochet, e senza riguardo lo interrompe) Che cos'è 'sta lagna? RICOCHET – (smette di suonare, si scuote) Chi.. -

Paolo Benvegnù E Marina
Marina Rei e Paolo Benvegnù a Femminile Singolare Valdagno Biografie MARINA REI Figlia di genitori musicisti (madre violinista e padre batterista) Marina Restuccia, in arte Marina Rei, ha sempre respirato musica di diverse ispirazioni, una musica che ha alimentato in lei contrasti e nutrito al tempo stesso la ricchezza della sua formazione. Intorno ai 18 anni, alla ricerca di una identità artistica autonoma dalle influenze familiari, Marina ha formato un suo gruppo grazie al quale ha iniziato a mettere a fuoco l’obiettivo artistico da perseguire. Contemporaneamente ha registrato due dischi dance in inglese, con i quali ha riscosso un discreto successo in Giappone. Ma soprattutto è in quel periodo che ha iniziato a suonare nei locali, scoprendo la varietà di sensazioni che solo i concerti sanno suscitare ed è questa la forma espressiva che lei tuttora predilige. Nel 1994, dopo anni di concerti dal vivo e di studio delle percussioni, grazie anche all’aiuto di Paolo Micioni, all’epoca suo manager, firma con una major, la Virgin, con la quale pubblica il suo primo singolo importante (“Sola”, aprile 1995) e partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il pezzo “Al di là di questi anni”, col quale vince il Premio della Critica 1996. Nello stesso anno pubblica il suo primo album in italiano, “Marina Rei”. Ai tempi del secondo album, “Donna” (1997), il meccanismo discografico si era già fatto impegnativo e logorante, sottraendole tempo ed energie alla scrittura di testi e musica, alla ricerca di un suono appropriato e che le rispondesse. Marina inizia a non condividere a pieno le scelte della casa discografica, tra queste – la più sofferta – quella di una seconda partecipazione al Festival di Sanremo. -

GIOCO in RIMA Conte E Filastrocche Per Giocare
GIOCO IN RIMA Conte e filastrocche per giocare Comune di Venezia Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale Settore Servizi Educativi Servizio di Progettazione Educativa GIOCO IN RIMA Conte e filastrocche per giocare In occasione della 7aedizione di Dritti sui Diritti il Servizio di Progettazione Educativa ha realizzato questa piccola raccolta di “Conte e filastrocche in rima” che verrà messa a disposizione di genitori e bambini. Lo strumento si inserisce nell’ottica dell’art. 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”. L’idea nasce quindi per contribuire a fornire spunti per giocare assieme tra bambini e tra adulti e bambini riscoprendo anche qualche tradizionale cantilena con cui si divertivano i bambini e le bambine in passato. Buon divertimento! Dott.ssa Daniela Galvani Responsabile Progettazione Educativa Comune di Venezia Pum! Passa Paperino Orlando paladino Sotto la pergola Il serpente Pum! Passa Paperino Orlando paladino Sotto la pergola nasce l'uva, con la pipa in bocca avea un bel cavallino. prima acerba, poi matura. Trippe trappe con rose e fiori guai a chi la tocca Trotterella, trotterella Zeffirin, zeffirà, questo è dentro e questo è fuori chi la toccherà per cercar la caramella. -

Mosaico June 2013 Copy
Il Manoscritto Palatino 313 - Dante Poggiali La Divina Commedia - Tiratura limitata e numerata unica al mondo "Riproduzione in facsimile del Manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, si colloca nel secondo quarto del sec. XIV, sia in base alla scrittura, sia in base alle illustrazioni che corredano il testo. Considerata la più antica Commedia miniata conosciuta,Type to contieneenter text 37 preziose miniature attribuite alla bottega di Pacino di Buonaguida, per cui, secondo alcuni critici, s’imporrebbe fin dall’inizio una preminenza di gusto giottesco June 2013 nell’illustrazione del poema; a su#ragare tale ipotesi starebbe l’a#ermazione del Benvenuto, secondo il quale Dante avrebbe incontrato Giotto a Padova, quando l’artista era impegnato nella Cappella degli Scrovegni e aveva iniziato a dipingere il Giudizio universale, in cui la ra$gurazione dei dannati e dell’Inferno trova largo spazio. "Il codice Palatino 313, contiene grandissima parte del Commento di Jacopo, figlio di Dante, sebbene spesso le sue chiose siano corrotte e alterate. Quasi ogni chiosa è segnata della sigla Jac (Jacopo). Entrambi i figli di Dante furono commentatori della Commedia: Pietro di tutto il poema, Jacopo non andò oltre la prima Cantica. Nel tempo in cui Jacopo dimorò a Firenze molti facevano capo a lui per richiedere spiegazioni sui passi più ardui della Commedia. “E’ curioso che il possessore di un antichissimo codice scrivesse in margine dove non si intendeva: Jacobe, facias declarationem”. "Il codice è scritto in littera textualis, una grafia nata nella Francia del nord nella seconda metà del XII sec. come evoluzione della minuscola carolina. -

Divina...Creatura.Pdf
1 JOLANDA PIETROBELLI DIVINA... CREATURA Edizioni 2 Jolanda Pietrobelli DIVINA...CREATURA © Copyright CristinAPietrobelli ebook E-Book 2013 In copertina: Mina, elaborazione grafica Silvia Cozzolino Vietato qualsiasi tipo di riproduzione, senza il consenso dell'editore Molte delle foto pubblicate sono di Mauro Balletti Questa pubblicazione viene scaricata gratuitamente dal sito www.libreriacristinapietrobelli.it 3 4 Dedicato A Benedetta perché ama tantissimo sua madre, quanto io ho amato la mia. E continuo ad amarla... nella sua alta dimensione! 5 6 Nota dell'A. Da tempo progettavo un lavoro del genere. Tra le mie tante pubblicazioni, tutte rivolte al mondo dell'arte e ai vari metodi olistici, tesi alla <crescita interiore>, mi ero presa uno svago, raccontando a modo mio, un mito <Oriana Fallaci>, a cui ho sempre guardato con grande interesse, per il suo modo di fare <GIORNALISMO>. Mina era <l'altro mito> che prima o poi avrei celebrato, sempre a modo mio, ma i tempi forse non erano ancora maturi. O forse io ero molto distratta dall'immaginario dei deva, che curavano la mia espansione di coscienza. Adesso è giunto il momento di dedicarmi a lei <Divina Creatura> e ciò che ha fatto scattare in me l'irrefrenabile necessità intellettuale, è stato un brano del suo repertorio...di qualche anno fa: OM MANI PADME HUM Perché? Si tratta di un potente mantra che i monaci tibetani, cantilenano fino all'ossessione, sgranando il Mala, lo conosco molto bene perché io stessa quando vado in samadhi, lo uso. Mina ne ha fatto un brano che ha interpretato straordinariamente. Solo lei poteva inventarsi una cosa del genere, impensabile là dove ci si perde in <cieli sempre più blu, tutti al mare, cuori matti, gelati al cioccolato, basta un panino e un bicchiere di vino>.. -

Igiene Salute Sommario
Periodico distribuito gratuitamente Periodico Periodico distribuito gratuitamente Periodico Periodico distribuito gratuitamente Periodico CONTENUTO SPECIALE igiene salute Sommario EDITORIALE La gravosa eredità della pandemia .............. 2 Progetto PROCHILD ..................................................... 3 Figli: sempre più sani, ma sempre di meno E crescono le diseguaglianze territoriali .......... 4 Collirio, soluzione Abbi cura di me. 12 piccole regole DIRETTORE SCIENTIFICO per rendere più sicura la casa ........................... 6 Marcello Lanari DIRETTORE RESPONSABILE Franca Golisano SPECIALE COMITATO DI REDAZIONE IGIENE È SALUTE Antonella Abbinante Rino Agostiniani L’igiene è presupposto di salute .................. 11 Laura Andreozzi Giovanni Corsello Igiene delle mani ................................................... 12 Monia Gennari Mario Rusconi Ti conosco mascherina ..................................... 14 Piercarlo Salari Laura Serra Igiene della pelle Paola Sogno Valin La rivoluzione “omica” ....................................... 16 Loredana Straccamore Maria Grazia Zanelli Igiene del naso www.sip.it Una buona abitudine quotidiana .............. 18 SEGRETERIA DI REDAZIONE [email protected] AREA COMMERCIALE Sull’igiene orale non si scherza E PUBBLICITÀ ma insegnamola come un gioco ............... [email protected] 21 I disturbi del sonno dei bambini aumentati con la pandemia, Copyright © 2021 continuano a richiedere attenzione .......... 23 EDITEAM Gruppo Editoriale Via del Curato 19/11, 44042 Cento (FE) Tel. e -

Translating the Vanderbeeker Family
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e Corso di Laurea MagistraleCooperazione in Lingue Internazionale Moderne (Classe per LMla -Comunicazione38) e Cooperazione InternazionaleUniversitàTesi deglidi Laurea Studi di Padova Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e CooperazioneDipartimento Internazionale diTesi Studi di Laurea Linguistici e Letterari Translating the Vanderbeeker Family How to be a vender of a beaker of familiarities adapting communication Relatore Laureanda Prof. Fiona Dalziel Serena Andorlini Translating the Vanderbeekern° Familymart. 1176830 / LMLCC Relatore Anno Accademico 2019 / 2020 n° matr. 1176830 / LT How to be a vender of a beaker of familiarities adapting Prof. Fiona Dalziel communication Anno Accademico 2019 / 2020 Laureanda Serena Andorlini n° matr. 1176830 / LT To my family, my grandmother Roberta, and Luis Sepúlveda. 2 Table of Contents INTRODUCTION .......................................................................................................... 5 CHAPTER 1 What is Children’s Literature: the Five Ws and H Questions applied to Children’s Literature ................................................................................................. 9 CHAPTER 2 The Vanderbeeker family: content analysis ....................................... 25 2.1 Gender issues ........................................................................................................ 33 CHAPTER -

Mineral County Land Expansion Comment Period Extended
Hawthorne The Week of January 3, 2019 America’s Patriotic Home Mineral County 75¢ | Vol. 87 • No. 48 | A BattleIndependent-NewsIndependent-News Born Media newspaper The oldest continuous privately owned business in Mineral County. Published in Hawthorne, Nevada, since 1933 opinion | 10 sports | 12 Ending net neutrality speeded up Internet Wolf Pack wins Arizona Bowl Fallon range training Complex eConomy Land expansion comment period extended Report: Nevada’s infrastructure By Heidi Bunch tation for residents of Mineral County on to be considered for the final EIS. All MCIN Staff Dec. 10. The presentation explained the comments submitted become public needs reflect potential environmental and financial record and substantive comments will The comment period for the expansion impacts that the proposed moderniza- be addressed in the final EIS. Comments the state’s of the Fallon Range Training Complex tion of the Fallon Range may have in the can be submitted online at http://www. Modernization draft Environmental Im- county. The modernization may include, FRTCModernization.com or sent to: rural-urban divide pact Statement (EIS) has been extended the renewal of the Navy’s current pub- Naval Facilities Engineering Command for the public review and comment pe- lic land withdraw, additional withdraw Southwest, Attn: Code EV21.Sg, 1220 Pa- By Daniel Rothberg riod an addition 30 days. of public lands for a larger land range cific Highway, Bldg. 1, 5th Fl., San Diego, The Nevada Independent Those wishing to make a comment expansion, expansion of airspace and CA 92132. have now been extended to Feb. 14, 2019 range infrastructure modifications and To review the draft EIS, visit the fol- When it comes to infrastructure, there for their comments to be considered in upgrades.