Il Suono Prima Di Tutto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulgaria Is Expecting You! the ROSE FESTIVAL KAZANLAK 2012
Festival: “Wine and Roses in the Valley of Thracian Kings” The Historical • National rosé wine competition;; 08.06.- • Gallery of Modern Bulgarian winemaking practices 10.06 Museum “Iskra” – Exhibition; • Art demonstration of antique painting techniques – THE ROSE FESTIVAL rose oil icon painting; KAZANLAK 2012 Date Time Place Festival Events OpeROSE: “Bulgarians of Yore” to music by Assen 19th May – 24th June “Arsenal” Cultural 19.00 Karastoyanov, performance by the Stara Zagora State 8.06 Center Opera and the “Zagore” folklore ensemble 9.06 10.00 The village of Rajena „Rose picking“ ritual „Queen of the Rose Valley “ – competition - 19.30 “Sevtopolis” Square 9.06 performance Community Center “The best of the Operettas” – concert of the “Petko Imagine a spring field, saturated with the • Evaluate the quality of the Bulgarian wines 15.06 “Iskra” Staynov” choir and soloists scent of roses and lavender. See how in early and vote for the best Bulgarian rosé during summer the sun caresses gently the earth and the “Wine and Roses Festival” in The Valley of how it returns the gesture with the smiles of Thracian Kings (8.06 - 10.06); “The best new Bulgarian cosmetic product based on Information Center the sunflowers. Enjoy the huge dark green 17.06 18.00 Bulgarian rose oil and other essential oils” – The “Rosa • Take part in the rose picking rituals (25.05, 4 “Iskra” Street crowns of the walnut trees, feel the breath of Damascena” Award of the Kazanlak Municipality 03.06 and 09.06); the oak forests on the Balkan mountain, inhale the aroma of the fragrant herbs. -
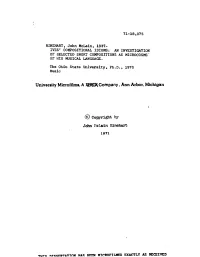
University Microiilms, a XERQ\Company, Ann Arbor, Michigan
71-18,075 RINEHART, John McLain, 1937- IVES' COMPOSITIONAL IDIOMS: AN INVESTIGATION OF SELECTED SHORT COMPOSITIONS AS MICROCOSMS' OF HIS MUSICAL LANGUAGE. The Ohio State University, Ph.D., 1970 Music University Microiilms, A XERQ\Company, Ann Arbor, Michigan © Copyright by John McLain Rinehart 1971 tutc nTccrSTATmil HAS fiEEM MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED IVES' COMPOSITIONAL IDIOMS: AM IMVESTIOAT10M OF SELECTED SHORT COMPOSITIONS AS MICROCOSMS OF HIS MUSICAL LANGUAGE DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy 3n the Graduate School of The Ohio State University £ JohnfRinehart, A.B., M«M. # # * -k * * # The Ohio State University 1970 Approved by .s* ' ( y ^MrrXfOor School of Music ACm.WTji.D0F,:4ENTS Grateful acknov/ledgement is made to the library of the Yale School of Music for permission to make use of manuscript materials from the Ives Collection, I further vrish to express gratitude to Professor IJoman Phelps, whose wise counsel and keen awareness of music theory have guided me in thi3 project. Finally, I wish to acknowledge my wife, Jennifer, without whose patience and expertise this project would never have come to fruition. it VITA March 17, 1937 • ••••• Dorn - Pittsburgh, Pennsylvania 1959 • • • • • .......... A#B#, Kent State University, Kent, Ohio 1960-1963 . * ........... Instructor, Cleveland Institute of Music, Cleveland, Ohio 1 9 6 1 ................ • • • M.M., Cleveland Institute of ITu3ic, Cleveland, Ohio 1963-1970 .......... • • • Associate Professor of Music, Heidelberg College, Tiffin, Ohio PUBLICATIONS Credo, for unaccompanied chorus# New York: Plymouth Music Company, 1969. FIELDS OF STUDY Major Field: Theory and Composition Studies in Theory# Professor Norman Phelps Studies in Musicology# Professors Richard Hoppin and Lee Rigsby ill TAPLE OF CC NTEKTS A C KI JO WLE DGEME MT S ............................................... -

Andrián Pertout
Andrián Pertout Three Microtonal Compositions: The Utilization of Tuning Systems in Modern Composition Volume 1 Submitted in partial fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy Produced on acid-free paper Faculty of Music The University of Melbourne March, 2007 Abstract Three Microtonal Compositions: The Utilization of Tuning Systems in Modern Composition encompasses the work undertaken by Lou Harrison (widely regarded as one of America’s most influential and original composers) with regards to just intonation, and tuning and scale systems from around the globe – also taking into account the influential work of Alain Daniélou (Introduction to the Study of Musical Scales), Harry Partch (Genesis of a Music), and Ben Johnston (Scalar Order as a Compositional Resource). The essence of the project being to reveal the compositional applications of a selection of Persian, Indonesian, and Japanese musical scales utilized in three very distinct systems: theory versus performance practice and the ‘Scale of Fifths’, or cyclic division of the octave; the equally-tempered division of the octave; and the ‘Scale of Proportions’, or harmonic division of the octave championed by Harrison, among others – outlining their theoretical and aesthetic rationale, as well as their historical foundations. The project begins with the creation of three new microtonal works tailored to address some of the compositional issues of each system, and ending with an articulated exposition; obtained via the investigation of written sources, disclosure -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 128, 2008-2009
2008-2009 SEASON i**f Bernard Haitink Conducto M& Seiji Ozawa Music Director Laureate . the Clarendon BACK BAY The Way to Live D nyi m H ' • utt. win j m: in* i ! || |Ifi| »!i»U IB, p !i« on IIP !CfU ' !' r,-—1_ x, 1IINHI Hi !! li ' !! : Ill HI. IHI mil : Il; U J 'I K • ? I! ,1 m nil ; t i :: ^ - INTRODUCING FIVE STAR LIVING™ WITH UNPRECEDENTED SERVICES AND AMENITIES DESIGNED BY ROBERT A.M. STERN ARCHITECTS, LLP ONE TO FOUR BEDROOM LUXURY CONDOMINIUM RESIDENCES STARTING ON THE 15TH FLOOF CORNER OF CLARENDON AND STUART STREETS THE CLARENDON SALES AND DESIGN GALLERY, 14 NEWBURY STREET, BOSTON, MA 617.267.4001 www.theclarendonbackbay.com BRELATED DC/\Lcompai REGISTERED WITH THE U.S. GREEN BUILDING COUN( ANTICIPATED LEED SILVER CERTIFICATION fg> The artist's rendering shown may not be representative of the building. The features described and depicted herein are based upon current development plans, v, No S subject to change without notice. No guarantee is made that said features will be built, or. if built, will be of the same type, size, or nature as depicted or described. prohit agency has judged the merits or value, if any, of this property. This is not an offer where registration is reguired prior to any offer being made. Void where Table of Contents | Week 19 15 BSO NEWS 21 ON DISPLAY IN SYMPHONY HALL 23 BSO MUSIC DIRECTOR JAMES LEVINE 26 THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA 29 A BRIEF HISTORY OF SYMPHONY HALL 33 A "MULTIPLICITY OF MUSICS": THE PREMIERE OF CHARLES IVES'S SYMPHONY NO. -

2015,3 Interview with Johnny Reinhard
Рецензии, интервью • Reviews, Interviews 2015,3 INTERVIEW WITH JOHNNY REINHARD Anton Rovner: Can you tell me about your the Pompidou Centre. I have held important concert activities with the microtonal festival? concerts of microtonal music in Switzerland, What cities have you performed in the United for which I took eight people from New York, States besides New York, as well as what other where we introduced the music of Harry Partch countries? for concerts in Zurich and Kreuzlingen, and a Johnny Reinhard: I started my musical Zurich Radio broadcast. activities as a bassoonist. During my graduate AR: Can you tell about your microtonal studies in bassoon at the Manhattan School of festival, how it began, where do you perform Music and in ethnomusicology at Columbia and what kind of music do you perform there? University, I began to be interested in JR: In 1980 I received my Master’s degree microtonal music, which I decided to devote from Manhattan School of Music, and I learned to my full time to. In 1981 I founded the American play quartertones on the bassoon, so composers Festival of Microtonal Music, which has been began writing pieces for me. I enrolled in the in existence since then. The festival has held Music Department of Columbia University, performances of numerous musical works where I studied ethnomusicology, and I started incorporating microtones and alternate tunings to learn that different types of music of different by many composers throughout the world, peoples of past ages had different tunings. As both contemporary and from earlier times. In a result, I came up with the idea of a festival addition to that, I have performed with recitals of microtonal music, which would be inter- on the bassoon and with concerts of microtonal stylistic, where I would put together on one stage music in most European countries, different such diverse types of music as Middle Ages and cities across Canada – St. -
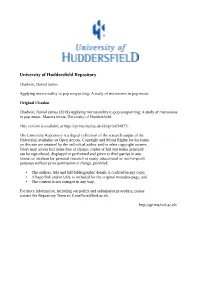
A Study of Microtones in Pop Music
University of Huddersfield Repository Chadwin, Daniel James Applying microtonality to pop songwriting: A study of microtones in pop music Original Citation Chadwin, Daniel James (2019) Applying microtonality to pop songwriting: A study of microtones in pop music. Masters thesis, University of Huddersfield. This version is available at http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/34977/ The University Repository is a digital collection of the research output of the University, available on Open Access. Copyright and Moral Rights for the items on this site are retained by the individual author and/or other copyright owners. Users may access full items free of charge; copies of full text items generally can be reproduced, displayed or performed and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided: • The authors, title and full bibliographic details is credited in any copy; • A hyperlink and/or URL is included for the original metadata page; and • The content is not changed in any way. For more information, including our policy and submission procedure, please contact the Repository Team at: [email protected]. http://eprints.hud.ac.uk/ Applying microtonality to pop songwriting A study of microtones in pop music Daniel James Chadwin Student number: 1568815 A thesis submitted to the University of Huddersfield in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts University of Huddersfield May 2019 1 Abstract While temperament and expanded tunings have not been widely adopted by pop and rock musicians historically speaking, there has recently been an increased interest in microtones from modern artists and in online discussion. -
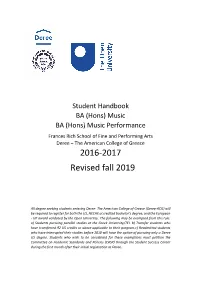
2016-2017 Revised Fall 2019
Student Handbook BA (Hons) Music BA (Hons) Music Performance Frances Rich School of Fine and Performing Arts Deree – The American College of Greece 2016-2017 Revised fall 2019 All degree seeking students entering Deree- The American College of Greece (Deree-ACG) will be required to register for both the US, NECHE accredited bachelor’s degree, and the European - UK award validated by the Open University. The following may be exempted from this rule: a) Students pursuing parallel studies at the Greek University/TEI. b) Transfer students who have transferred 92 US credits or above applicable to their program.c) Readmitted students who have interrupted their studies before 2010 will have the option of pursuing only a Deree US degree. Students who wish to be considered for these exemptions must petition the Committee on Academic Standards and Policies (CASP) through the Student Success Center during the first month after their initial registration at Deree. Contents 1. Welcome to the Music Programme 1.1 Message from the Dean .................................................................................................. 3 1.2 Message from the Department Head…………………………………………………………………………. 3 1.3 Academic Calendar Academic Policies links .................................................................... 4 1.4 Key Contacts ................................................................................................................... 4 1.5 Keeping in Touch ........................................................................................................... -

BRATIMENE Arcángel & Theodosii Spassov
BRATIMENE Arcángel & Theodosii Spassov a musical encounter A musical encounter between two geniuses who present a energetic and exquisite multi- flavoured dish of flamenco and Bulgarian rhythms. Flautist Theodosii Spassov is a master of improvisation on the kaval, the Bulgarian wooden shepherd’s flute. He is a storyteller, blending traditional Bulgarian folk music with jazz and classical music into his own unique, highly individual style. In this concert his rich musical world will join up with the extraordinary universe of cantaor Arcángel , who the critics unanimously praise as the heir of the late and great flamencosinger Enrique Morente. The singer from Huelva is one of the leading lights of a new generation of vocalists who is making waves internationally with his creative renditions of the classical jondo repertoire. Arcángel transcends flamenco borders with a subtle and rich imagination, always grasping the roots. He collaborated with the Orchestre Tetuan from Morocco and lent his voice to a number of contemporary pieces of the Spanish composer Mauricio Sotelo, with whom he performed during ‘Flamenco Sin Fin’, the final gala at the III Dutch Flamenco Biennial in 2011. Arcángel and Spassov explore musical horizons from the Balkans to the flamenco breeding grounds of Andalusia and back again. This musical dialogue will offer both maestros the chance to follow their instincts in a swinging “open flamenco space”, demonstrating the ease with which the shepherd’s flute combines with flamenco rhythms, as well as the richness and boundlessness of the world heritage treasure that is flamenco. Arcángel gives part of his solo part away to a phenomenal Bulgarian flute player with whom he initiates a musical dialogue that brings about the deepest feelings of two different cultures. -

Explorations of Equal-Tempered Microtonality / Ivan Wyschnegradsky, Manual of Quarter-Tone Harmony, Edited by Noah Kaplan and Tr
Document generated on 09/27/2021 5:49 p.m. Circuit Musiques contemporaines Explorations of Equal-Tempered Microtonality Ivan Wyschnegradsky, Manual of Quarter-Tone Harmony, Edited by Noah Kaplan and translated by Rosalie Kaplan, Brooklyn, Underwolf, 2017. 28 pages with online audio supplement Julia Werntz, Steps to the Sea: Ear Training and Composing in a Minute Equal Temperament, Frog Peak Music, 2014. 47 pages with online audio supplement Robert Hasegawa Les voies de la pansonorité : la musique microtonale d’hier à aujourd’hui Volume 29, Number 2, 2019 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1062570ar DOI: https://doi.org/10.7202/1062570ar See table of contents Publisher(s) Circuit, musiques contemporaines ISSN 1183-1693 (print) 1488-9692 (digital) Explore this journal Cite this review Hasegawa, R. (2019). Review of [Explorations of Equal-Tempered Microtonality / Ivan Wyschnegradsky, Manual of Quarter-Tone Harmony, Edited by Noah Kaplan and translated by Rosalie Kaplan, Brooklyn, Underwolf, 2017. 28 pages with online audio supplement / Julia Werntz, Steps to the Sea: Ear Training and Composing in a Minute Equal Temperament, Frog Peak Music, 2014. 47 pages with online audio supplement]. Circuit, 29(2), 99–102. https://doi.org/10.7202/1062570ar Tous droits réservés © Circuit, musiques contemporaines, 2019 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. -

1-5 Frontespizio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” CENTRO DI STUDI EBRAICI ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI III\5 ALOMA BARDI ESOTISMI MUSICALI DEL DIBBUK ISPIRAZIONI DA UN SOGGETTO DEL FOLCLORE EBRAICO UniorPress AdSE III\5 ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI DIRETTO DA GIANCARLO LACERENZA REDAZIONE: DIANA JOYCE DE FALCO, DOROTA HARTMAN CENTRO DI STUDI EBRAICI DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” PIAZZA S. DOMENICO MAGGIORE 12, 80134 NAPOLI TEL.+39 0816909675 - FAX.+39 0815517852 E-MAIL: [email protected] In copertina: Solomon Epstein, The Dybbuk: An Opera in Yiddish in Three Acts. Atto III, Scena 7 (Finale dell’opera): la sposa velata; trasfigurazione e morte di Leah. Il soprano Camilla Griehsel nella parte di Leah; regia Rachel Michaeli. Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre, Tel Aviv, 2 maggio 1999. Used by permission. © Rachel Michaeli, [email protected] ISBN 978-88-6719-056-0 Prodotto da IL TORCOLIERE – Officine Grafico-Editoriali di Ateneo © Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 2014 Edizione digitale UniorPress - 2020 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” CENTRO DI STUDI EBRAICI ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI III\5 ALOMA BARDI ESOTISMI MUSICALI DEL DIBBUK ISPIRAZIONI DA UN SOGGETTO DEL FOLCLORE EBRAICO Napoli 2014 A Gabriele Boccaccini con gratitudine per quello che mi ha insegnato sull’ebraismo e ancor di più per il suo esempio di studioso AB SOMMARIO PREFAZIONE Il dramma Der Dybuk di S. An-Ski e la musica 11 I. RICERCA ETNOGRAFICA E ORIGINI DELL’INTERESSE MUSICALE 15 An-Ski e la musica del Dibbuk 17 Le musiche di scena di Yoel Engel 22 Le trascrizioni di A.Z. -

Pitch Cd Cover Designs
CLASSIC P-200210 Nicolo Vicentino Musica prisca caput Giuseppe Tartini Devil’s Tril in G Minorl Johannes Brahms Trio in Eb Major Ludwig van Beethoven Trio in B Major Béla Bartok Presto Andreas Werckmeister Preludium und Fuga in G Major Johann Sebastian Bach A Musical Offering Douglas Frank Chorale Joshua Pierce, piano Gilad Harel, clarinet James Ferree, natural horn Johnny Reinhard, bassoon Dan Auerbach, violin Julianne Klopotic, violin Daniel Barrett, cello American Festival of Microtonal Music, Inc. © 2004 All Rights Reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. www.afmm.org WORLD P-200211 Reza Derakhshani Chargah-Shur Cameron Hitami, kemanche Hearn Gadbois, percussion Theodosii Spassov Kaval Fryd Ensemble Brureslag Frå jerkreim & Jeg Ser Deg, O Guds Lam, Å Stå Frank J. Oteri Just Salsa Mark Rankin Will the Circle Be Unbroken? Svjetlana Bukvich-Nichols Before & After the Tekke Ana Milosavljevic, violin American Festival of Microtonal Music, Inc. © 2004 All Rights Reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. www.afmm.org IDEAS P-200212 Charles Ives Unanswered Question Paolo Bellomia, conductor Julian Carrillo I Think of You Meredith Borden, soprano Johnny Reinhard, conductor Harry Partch Ulysseus Departs From the Edge of the Earth Johnny Reinhard, conductor Lou Harrison Simfony in Free Style Nathan Fuhr, conductor David Beardsley Sonic Bloom Percy Grainger Free Music Gloria Coates Lunar Loops Ruth Fischer & Stephen Steins, guitars Georgy Rimsky-Korsakov Prelude John Cage In the Name of -

Music Inspired by Astronomy, Organized by Topic an Annotated Listing by Andrew Fraknoi
Music Inspired by Astronomy, Organized by Topic An Annotated Listing by Andrew Fraknoi © copyright 2019 by Andrew Fraknoi. All rights reserved. Used with permission. Borresen: At Uranienborg Cage: Atlas Eclipticalis Glass: Orion Connections between astronomy and music have been proposed since the time of the ancient Greeks. This annotated listing of both classical and popular music inspired by astronomy restricts itself to music that has connections to real science -- not just an astronomical term or two in the title or lyrics. For example, we do not list Gustav Holst’s popular symphonic suite The Planets, because it draws its inspiration from the astrological, and not astronomical, characteristics of the worlds in the solar system. Similarly, songs like Soundgarden’s “Black Hole Sun” or the Beatles’ “Across the Universe” just don’t contain enough serious astronomy to make it into our guide. When possible, we give links to a CD and a YouTube recording or explanation for each piece. The music is arranged in categories by astronomical topic, from asteroids to Venus. Additions to this list are most welcome (as long as they follow the above guidelines); please send them to the author at: fraknoi {at} fhda {dot} edu Table of Contents Asteroids Meteors and Meteorites Astronomers Moon Astronomy in General Nebulae Black Holes Physics Related to Astronomy Calendar, Time, Seasons Planets (in General) Comets Pluto Constellations Saturn Cosmology SETI (Search for Intelligent Life Out There) Earth Sky Phenomena Eclipses Space Travel Einstein Star Clusters Exoplanets Stars and Stellar Evolution Galaxies and Quasars Sun History of Astronomy Telescopes and Observatories Jupiter Venus Mars 1 Asteroids Coates, Gloria Among the Asteroids on At Midnight (on Tzadik).