Gli Eubei Nella Penisola Calcidica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Archaic Eretria
ARCHAIC ERETRIA This book presents for the first time a history of Eretria during the Archaic Era, the city’s most notable period of political importance. Keith Walker examines all the major elements of the city’s success. One of the key factors explored is Eretria’s role as a pioneer coloniser in both the Levant and the West— its early Aegean ‘island empire’ anticipates that of Athens by more than a century, and Eretrian shipping and trade was similarly widespread. We are shown how the strength of the navy conferred thalassocratic status on the city between 506 and 490 BC, and that the importance of its rowers (Eretria means ‘the rowing city’) probably explains the appearance of its democratic constitution. Walker dates this to the last decade of the sixth century; given the presence of Athenian political exiles there, this may well have provided a model for the later reforms of Kleisthenes in Athens. Eretria’s major, indeed dominant, role in the events of central Greece in the last half of the sixth century, and in the events of the Ionian Revolt to 490, is clearly demonstrated, and the tyranny of Diagoras (c. 538–509), perhaps the golden age of the city, is fully examined. Full documentation of literary, epigraphic and archaeological sources (most of which have previously been inaccessible to an English-speaking audience) is provided, creating a fascinating history and a valuable resource for the Greek historian. Keith Walker is a Research Associate in the Department of Classics, History and Religion at the University of New England, Armidale, Australia. -

The Children of Earth and Starry Heaven: The
Bryn Mawr College Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College Greek, Latin, and Classical Studies Faculty Research Greek, Latin, and Classical Studies and Scholarship 2010 The hiC ldren of Earth and Starry Heaven: The Meaning and Function of the Formula in the 'Orphic' Gold Tablets Radcliffe .G Edmonds III Bryn Mawr College, [email protected] Let us know how access to this document benefits ouy . Follow this and additional works at: http://repository.brynmawr.edu/classics_pubs Part of the Classics Commons, and the Religion Commons Custom Citation R. G. Edmonds III, “The hiC ldren of Earth and Starry Heaven: The eM aning and Function of the Formula in the 'Orphic' Gold Tablets,” in Orfeo y el orfismo: nuevas perspectivas, Alberto Bernabé, Francesc Casadesús y Marco Antonio Santamaría (eds.), Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (2010), pp. 98-121. This paper is posted at Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College. http://repository.brynmawr.edu/classics_pubs/98 For more information, please contact [email protected]. 4 THE CHILDREN OF EARTH AND STARRY HEAVEN: THE MEANING AND FUNCTION OF THE FORMULA IN THE ʹORPHICʹ GOLD TABLETS Radcliffe G. Edmonds III Bryn Mawr University The most striking aspect of the tiny gold tablets often known as the Orphic gold leaves is undoubtedly the enigmatic declaration: ʺI am the child of Earth and starry Heavenʺ. All of the tablets which, following Zuntzʹs classification, have been labelled B tablets, contain this mysterious formula, whether the scenario of the deceasedʹs journey through the underworld is described in greater or lesser detail1. The statement captures the imagination with its imagery and its simplicity, but also with its mysterious nature. -

Reading the Presence of Both Male and Female Sex Organs
214 HORMONESG. 2006, ANDROUTSOS 5(3):214-217 Historical note Hermaphroditism in Greek and Roman antiquity George Androutsos Institute of History of Medicine, University Claude Bernard, Lyon, France ABSTRACT Since antiquity hermaphrodites have fascinated the mind and excited the imagination. In this paper, such subjects are discussed as legends about the nativity of Hermaphroditus, son of Hermes and Aphrodite, the social status of these bisexual beings, and their fate in Greek- Roman antiquity. Key words: Female pseudohermaphroditism, Hermaphroditism, Male pseudohermaphroditism. INTRODUCTION The cult of the dual being is also to be found amongst the numerous arcane sciences of the mys- Hermaphroditism is a state characterized by tical religions of Hindu peoples, before spreading the presence of both male and female sex organs. through Syria to Cyprus, and then into Greece. Here Recent developments in the understanding of the it degenerated and met the same fate as the hyste- pathogenetic mechanisms involved in defective sex- ro-phallic cults. During such times of decadence, ual differentiation and the social repercussions of hermaphroditism was looked upon as the embodi- the term hermaphrodite have created the need for ment of sexual excess, while for philosophers, it rep- new terminology. Hence, such disorders are today resented the twofold nature of the human being, designated as genetic defects in the differentiation considered as the original being.3 of the genital system.1 HERMAPHRODITES IN ANCIENT GREECE THE FORERUNNERS Greek mythology abounds in examples of such Beings that are simultaneously both male and dual beings. Even the gods themselves were often female have stirred the human imagination since hermaphrodites: Dyalos, the androgyne; Arse- ancient times. -
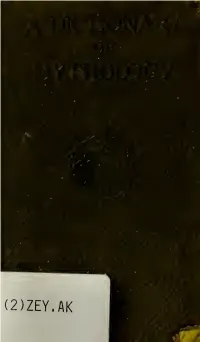
A Dictionary of Mythology —
Ex-libris Ernest Rudge 22500629148 CASSELL’S POCKET REFERENCE LIBRARY A Dictionary of Mythology — Cassell’s Pocket Reference Library The first Six Volumes are : English Dictionary Poetical Quotations Proverbs and Maxims Dictionary of Mythology Gazetteer of the British Isles The Pocket Doctor Others are in active preparation In two Bindings—Cloth and Leather A DICTIONARY MYTHOLOGYOF BEING A CONCISE GUIDE TO THE MYTHS OF GREECE AND ROME, BABYLONIA, EGYPT, AMERICA, SCANDINAVIA, & GREAT BRITAIN BY LEWIS SPENCE, M.A. Author of “ The Mythologies of Ancient Mexico and Peru,” etc. i CASSELL AND COMPANY, LTD. London, New York, Toronto and Melbourne 1910 ca') zz-^y . a k. WELLCOME INS77Tint \ LIBRARY Coll. W^iMOmeo Coll. No. _Zv_^ _ii ALL RIGHTS RESERVED INTRODUCTION Our grandfathers regarded the study of mythology as a necessary adjunct to a polite education, without a knowledge of which neither the classical nor the more modem poets could be read with understanding. But it is now recognised that upon mythology and folklore rests the basis of the new science of Comparative Religion. The evolution of religion from mythology has now been made plain. It is a law of evolution that, though the parent types which precede certain forms are doomed to perish, they yet bequeath to their descendants certain of their characteristics ; and although mythology has perished (in the civilised world, at least), it has left an indelible stamp not only upon modem religions, but also upon local and national custom. The work of Fruger, Lang, Immerwahr, and others has revolutionised mythology, and has evolved from the unexplained mass of tales of forty years ago a definite and systematic science. -

Daphnis & Chloe. with the English Translation of George Thornley, Rev
Digitized by the Internet Archive in 2008 with funding from IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/daphnischloewithOOIonguoft DAPHXIS & CHLOE BY LONG US WITH THE ENGLISH TRANSLATION OF GEORGE THORNLEY REVISED AND AUGMENTED BY J. M. EDMONDS FELLOW OF JESrS COLLEGE, CAMBRIDGE THE LOVE ROMANCES OF PARTHENIUS AND OTHER FRAGMENTS WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY S. GASELEE KELLOW OF MAGDALENE COLLEGE. rAMBRIDi^E % / LONDON : WILLL\M HEINEMANN NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS MCMXVI PA 4 7 ';, H 1.% THE LOEB CLASSICAL LIBRARY i EDITED BY CAPPS, Ph.D.,XL.D. T. E. page, Litt.D. W. H. D. ROUSK, Litt.D. LONGUS DAPHNIS AND CHLOE PARTHENIUS CONTENTS PACK LONG US (DAPHNIS AND CHLOE)— IXTRODUCTION vii BIBLIOGRAPHY Xxiii PROEM 7 BOOK I 11 BOOK II 63 BOOK III 125 BOOK IV 185 PARTHEXIUS— iXTBOurcTiox 251 THE LOVE KOMAXCES 257 [ FRAGMENTS 351 THE ALEXANDRIAN EROTIC FRAGMENT . 374 THE NINUS ROMANCE 382 APPENDIX ON THE GREEK NOVEL 401 INDEX TO DAPHNIS AND CHLOE 417 INDEX TO PARTHENIUS, THE ALEXANDRIAN EROTIC FRAGMENT, THE NINUS ROMANCE, AND APPENDIX ON THE GREEK NOVEL . 419 Tell me, thou whom mj- soul loveth, whore thou feedest, where thou makest tliy flock to rest at noon. Song of Solomon, 1. 7. INTRODUCTIOX I. LoNGUS Nothing is known of the author of the Pastoralia. He describes Mytilene as if he knew it well, and he mentions the peculiarities of the Lesbian vine. He may have been a Lesbian, but such local colouring need not have been gathered on the spot, nor if so, by a native. His style and language are Graeco- Roman rather .than Hellenistic ; he probably knew ^ Vergil's Bucolics ; like Strabo and Lucian he writes in Greek and yet bears a Roman name. -

Greek Mythology / Apollodorus; Translated by Robin Hard
Great Clarendon Street, Oxford 0X2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Athens Auckland Bangkok Bogotá Buenos Aires Calcutta Cape Town Chennai Dar es Salaam Delhi Florence Hong Kong Istanbul Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi Paris São Paulo Shanghai Singapore Taipei Tokyo Toronto Warsaw with associated companies in Berlin Ibadan Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © Robin Hard 1997 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published as a World’s Classics paperback 1997 Reissued as an Oxford World’s Classics paperback 1998 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organizations. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose this same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Apollodorus. [Bibliotheca. English] The library of Greek mythology / Apollodorus; translated by Robin Hard. -

Danaus Βουγενής: Greco-Egyptian Mythology and Ptolemaic Kingship Alexandros Kampakoglou
Danaus βουγενής: Greco-Egyptian Mythology and Ptolemaic Kingship Alexandros Kampakoglou HE THIRD BOOK of Callimachus’s Aetia opens with an elegy that celebrates the chariot victory of Queen Berenice II in the Nemean games (frr.54–60j).1 Accord- T 2 ing to the introductory couplet, the Victoria Berenices is offered by Callimachus to Zeus and Nemea as a gift on behalf of his patron, Berenice II: Ζηνί τε κα⸤ὶ Νεµέηι τι χαρίσιον ἕδνον ὀφείλω⸥, νύµφα, κα[σιγνή]τ̣ων ἱερὸν αἷµα θεῶν, ἡµ[ε]τ̣ερο.[......].εων ἐπινίκιον ἵππω̣[ν]. To Zeus and Nemea I owe a gift of gratitude, nymph, sacred blood of the sibling gods, our victory song […] of horses. Zeus and Nemea appear as the receivers of Callimachus’ gift because of their connection with the Nemean games: the myth of the Victoria Berenices narrates the killing of the Nemean lion but memorializes the creation by Heracles of the wreath that Nemean victors received as a prize. The mythic part of the poem concludes with a sacrifice to Zeus performed jointly by Heracles and Molorcus (fr.60c.8–10). The frame mirrors, in this regard, the actions of the myth: Heracles offers a sacrifice to his divine father with the assistance of his host, Molorcus; Berenice consecrates the elegy to Zeus, the divine progenitor of 1 I cite the edition of A. Harder, Callimachus. Aetia I–II (Oxford 2012); translations are my own. 2 This is the title given to the first elegy of Book 3 by P. J. Parsons, “Cal- limachus: Victoria Berenices,” ZPE 25 (1977) 1–51. -

Divine Riddles: a Sourcebook for Greek and Roman Mythology March, 2014
Divine Riddles: A Sourcebook for Greek and Roman Mythology March, 2014 E. Edward Garvin, Editor What follows is a collection of excerpts from Greek literary sources in translation. The intent is to give students an overview of Greek mythology as expressed by the Greeks themselves. But any such collection is inherently flawed: the process of selection and abridgement produces a falsehood because both the narrative and meta-narrative are destroyed when the continuity of the composition is interrupted. Nevertheless, this seems the most expedient way to expose students to a wide range of primary source information. I have tried to keep my voice out of it as much as possible and will intervene as editor (in this Times New Roman font) only to give background or exegesis to the text. All of the texts in Goudy Old Style are excerpts from Greek or Latin texts (primary sources) that have been translated into English. Ancient Texts In the field of Classics, we refer to texts by Author, name of the book, book number, chapter number and line number.1 Every text, regardless of language, uses the same numbering system. Homer’s Iliad, for example, is divided into 24 books and the lines in each book are numbered. Hesiod’s Theogony is much shorter so no book divisions are necessary but the lines are numbered. Below is an example from Homer’s Iliad, Book One, showing the English translation on the left and the Greek original on the right. When citing this text we might say that Achilles is first mentioned by Homer in Iliad 1.7 (i.7 is also acceptable). -
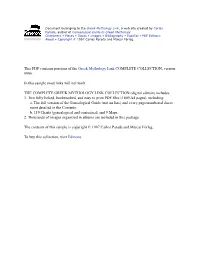
Greek Mythology Link (Complete Collection)
Document belonging to the Greek Mythology Link, a web site created by Carlos Parada, author of Genealogical Guide to Greek Mythology Characters • Places • Topics • Images • Bibliography • Español • PDF Editions About • Copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. This PDF contains portions of the Greek Mythology Link COMPLETE COLLECTION, version 0906. In this sample most links will not work. THE COMPLETE GREEK MYTHOLOGY LINK COLLECTION (digital edition) includes: 1. Two fully linked, bookmarked, and easy to print PDF files (1809 A4 pages), including: a. The full version of the Genealogical Guide (not on line) and every page-numbered docu- ment detailed in the Contents. b. 119 Charts (genealogical and contextual) and 5 Maps. 2. Thousands of images organized in albums are included in this package. The contents of this sample is copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. To buy this collection, visit Editions. Greek Mythology Link Contents The Greek Mythology Link is a collection of myths retold by Carlos Parada, author of Genealogical Guide to Greek Mythology, published in 1993 (available at Amazon). The mythical accounts are based exclusively on ancient sources. Address: www.maicar.com About, Email. Copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. ISBN 978-91-976473-9-7 Contents VIII Divinities 1476 Major Divinities 1477 Page Immortals 1480 I Abbreviations 2 Other deities 1486 II Dictionaries 4 IX Miscellanea Genealogical Guide (6520 entries) 5 Three Main Ancestors 1489 Geographical Reference (1184) 500 Robe & Necklace of -

War and the Warrior: Functions of Ares in Literature and Cult1
War and the Warrior: Functions of Ares in Literature and Cult Alexander T. Millington UCL Dissertation submitted for the degree of PhD in History 2013 1 I, Alexander Millington, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 Abstract This dissertation presents a new interpretative synthesis of the sources relating to the cults, identities, and functions of the god Ares, focusing on the Archaic and Classic periods. An apparent dichotomy is identified: in many respects, the evidence suggests that Ares must have been a very important god throughout much of the Greek world throughout the Archaic and Classic periods (and beyond), but in other respects the evidence suggests that he was not. I argue that this dichotomy does not derive from changes in the popularity, relevance, or nature of the god, as has been proposed. Instead, I argue that the elements of Ares’ cults and representations which suggest that Ares was unpopular or unimportant derive from those which made him important and continually relevant. I argue that because Ares was identified with war, attitudes towards the god directly reflect Greek attitudes towards war. War’s importance as an element of Greek life, and the god’s power as a causal force with it, led to deep respect for Ares, reflected by widespread cult, and a place among the great Olympians. But the wild, destructive, and unpredictable nature of war, which Ares represented, meant that he was not a regular recipient of large-scale celebratory cult. -
Final Thesis
Two Is Company, Three Is A Crowd: An analysis of the relationships between Herakles, Hera & Zeus in Apollodoros’ Bibliotheke Jessica Casbolt A thesis submitted to Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts in Classical Studies 2013 School of Art History, Classics and Religious Studies 1 Abstract This thesis examines the relationships between Herakles, Hera and Zeus in five mythic episodes in the Bibliotheke: the punishment of Hera; the Gigantomachy; Herakles’ birth and early life; the madness of Herakles; and his death, apotheosis and marriage to Hebe. These episodes display a variety of interactions between the figures across the life of Herakles. From his birth to his death and apotheosis, his relationship with Hera is of a contentious nature. Zeus’ involvement in the life of Herakles is often absent during crucial points. Apollodoros’ Bibliotheke is a survey of myth composed by an author who evidently had considerable literary resources to hand. What this means for the work is that the options available to Apollodoros were vast; thus we must attribute a great deal of choice to him in his compilations of the myths. As a result, when viewing the relationships between the three figures, we can investigate Apollodoros’ adjustments to the myths and attempt to uncover how he wished to portray the figures of Herakles, Hera and Zeus. As well as displaying information in the text, Apollodoros’ strict structuring method also presents us with more information. The genealogical structure forms the backbone of the work; it is in the deliberate placements of certain myths, however, such as the Punishment of Hera (Bib 1.3.5; 2.7.1) and the Gigantomachy (1.6.1; 2.7.1), that we see the effect of his conscious decisions in regard to the structure of the Bibliotheke. -
Virgil - Poems
Classic Poetry Series Virgil - poems - Publication Date: 2004 Publisher: Poemhunter.com - The World's Poetry Archive Virgil(70-19 BCE) Legend has it that Virgil was born in the village of Andes, near Mantua in Cisalpine Gaul. Scholars suggest Etruscan, Umbrian or even Celtic descent by examining the linguistic or ethnic markers of the region. Analysis of his name has led to beliefs that he descended from earlier Roman colonists. Modern speculation ultimately is not supported by narrative evidence either from his own writings or his later biographers. Etymological fancy has noted that his cognomen MARO shares its letters anagrammatically with the twin themes of his epic: AMOR (love) and ROMA (Rome). Legend also has it that Virgil received his first education when he was 5 years old and that he later went to Rome to study rhetoric, medicine, and astronomy, which he soon abandoned for philosophy; also that in this period, while in the school of Siro the Epicurean, he began to write poetry. A group of small works attributed to the youthful Virgil survive, but are largely considered spurious. One, the Catalepton, consists of fourteen short poems, some of which may be Virgil's, and another, a short narrative poem titled the Culex ("The Gnat"), was attributed to Virgil as early as the 1st century CE. These dubious poems are sometimes referred to as the Appendix Vergiliana. During the civil strife that killed the Roman Republic, when Julius Caesar had been assassinated in 44 BCE, the army led by his assassins Brutus and Cassius met defeat by Caesar's faction, including his chief lieutenant Mark Antony and his newly adopted son Octavian Caesar in 42 BCE in Greece near Philippi.