MONFERRATO ALESSANDRINO Piano Forestale Territoriale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anno Mese Giorno Specie Maschi Femmine Totale
COMUNE ANNO MESE GIORNO SPECIE MASCHI FEMMINE TOTALE Località esatta rilascio di rilascio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Altavilla Monferrato Franchini 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Alfiano Natta Borghi 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Balzola Santa Clotilde 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Borgo San Martino Fornace 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camagna Monferrato San Giorgio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camino Rocca delle Donne 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camino Castel San pietro 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Castelletto Merli Cosso 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cella Monte Varocara 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Popolo 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Rolasco 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione S. Germano 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Terranova 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Roncaglia 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione S. Maaria del Tempio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Oltreponte 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cerrina Monferrato Blengi 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cerrina Monferrato Montalero 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Coniolo Ornea 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Conzano Pracino 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassinello MonferratoColombara 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassineto Po Valmacchina 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassineto Po str. -

Pagina 1 Di 7 PROV ENTE BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO RIPRISTINO CEDIMENTO SEDE STRADALE PRESSO PONTE SU RIO AL MOLARE 40.000,00 GRANOZZA CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.C
PROV ENTE BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO AL ALBERA LIGURE SISTEMAZIONE S.C. CIMITERO DI VOLPARA 51.000,00 AL ALFIANO NATTA MESSA IN SICUREZZA S.C. CREALTO PER CADUTA MASSI. 23.000,00 AL ALICE BEL COLLE CONSOLIDAMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO 23.000,00 AL ALZANO SCRIVIA RIPRISTINO LOCULARI COMUNALI 50.000,00 INDAGINI E MONITORAGGIO PER DIFESA ABITATI DI VOCEMOLA E AL ARQUATA SCRIVIA 120.000,00 PESSINO AL BERZANO DI TORTONA SISTEMAZIONE DANNI STRUTTURALI AL CIMITERO 40.000,00 AL BERZANO DI TORTONA CONSOLIDAMENTO BANCHINA E DISSESTO SEDE STRADALE. 35.000,00 AL CAMAGNA MONFERRATO RIPRISTINO TRANSITABILITA' SU S.C. IMPRATO, BRELLA, GRANA 40.000,00 AL CAMINO RIPRISTINO STRADA COMUNALE BRUSASCHETTO-TRINO 50.000,00 CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA NORD-OVEST DEL CIMITERO DI AL CAMINO 60.000,00 BRUSASCHETTO AL CANTALUPO LIGURE SISTEMAZIONE MURO INTERNO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 25.000,00 CONSOLIDAMENTO STRUTTURA PORTANTE PONTICELLO S.C. DEI AL CAREZZANO 50.000,00 BOSCHI. AL CARROSIO CONSOLIDAMENTO MURO S.C. SOTTOVALLE 52.000,00 INDAGINI GEOGNOSTICHE PER CONSOLIDAMENTO S.C. PER AL CARROSIO 87.000,00 SOTTOVALLE SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL FINE DI RIPRISTINARE AL CASALE MONFERRATO 22.000,00 LE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ DI SALITA SANT'ANNA RIPRISTINO FOSSI LATERALI DELLE STRADE COLLINARI IN ZONA AL CASALE MONFERRATO 26.000,00 SALITA SANT'ANNA E POZZO SANT'EVASIO AL CASALE MONFERRATO RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI 22.000,00 AL CASSINE RIPRISTINO S.C. VIA BRICCO 50.000,00 AL CASTELLETTO D'ERRO MESSA IN SICUREZZA S.C.COTTI 55.000,00 AL CASTELLETTO D'ORBA RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO STRADALE IN VIA CAZZULI 70.000,00 AL CASTELLETTO MONFERRATO CONSOLIDAMENTO LOCULARI COMUNALI 30.000,00 RIFACIMENTO BRIGLIA DIFESA SPONDALE E PONTICELLO SU RIO AL CASTELNUOVO BORMIDA 30.000,00 SALSO AL CASTELNUOVO SCRIVIA RIPRISTINO LOCULARI COMUNALI 60.000,00 AL CAVATORE RIFACIMENTO MURO IN VIA MARCONI 40.000,00 AL CELLA MONTE SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PIZZARUOLO. -

Deliberazione Della Giunta Regionale 1 Marzo 2019, N. 26-8491
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 26-8491 Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL AL entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico di assistenza primaria. A relazione del Presidente Chiamparino: Visto l’art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria; visto l’art. 33, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; dato atto che attualmente l’ASL AL è articolata in 4 Distretti qui di seguito elencati: • Distretto di Acqui Terme-Ovada (risultante dalla fusione dell’ ex Distretto di Acqui -Terme con l’ ex Distretto di Ovada); • Distretto di Alessandria-Valenza (risultante dalla fusione dell’ ex Distretto di Alessandria con l’ ex Distretto di Valenza); • Distretto di Casale Monferrato; • Distretto di Novi Ligure- Tortona (risultante dalla fusione dell’ ex Distretto di Novi Ligure con l’ ex Distretto di Tortona); preso atto della deliberazione n. 782 del 28 novembre 2018, a firma del Direttore Generale dell'ASL AL (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale viene posto in evidenza che: a) con legge regionale n. 4 del 5 aprile 2017 è stato istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il Comune di Cassano Spinola , afferente il Distretto di Novi Ligure-Tortona, risultante dalla fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana; b) con legge regionale n. -

Sub Ambito 01 – Alessandrino Istat Comune 6003
SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO ISTAT COMUNE 6003 ALESSANDRIA 6007 ALTAVILLA MONFERRATO 6013 BASSIGNANA 6015 BERGAMASCO 6019 BORGORATTO ALESSANDRINO 6021 BOSCO MARENGO 6031 CARENTINO 6037 CASAL CERMELLI 6051 CASTELLETTO MONFERRATO 6052 CASTELNUOVO BORMIDA 6054 CASTELSPINA 6061 CONZANO 6068 FELIZZANO 6071 FRASCARO 6075 FRUGAROLO 6076 FUBINE 6078 GAMALERO 6193 LU E CUCCARO MONFERRATO 6091 MASIO 6105 MONTECASTELLO 6122 OVIGLIO 6128 PECETTO DI VALENZA 6129 PIETRA MARAZZI 6141 QUARGNENTO 6142 QUATTORDIO 6145 RIVARONE 6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 6161 SEZZADIO 6163 SOLERO 6177 VALENZA SUB AMBITO 02 – CASALESE ISTAT COMUNE 6004 ALFIANO NATTA 6011 BALZOLA 6020 BORGO SAN MARTINO 6023 BOZZOLE 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 6039 CASALE MONFERRATO 6050 CASTELLETTO MERLI 6056 CELLA MONTE 6057 CERESETO 6059 CERRINA MONFERRATO ISTAT COMUNE 6060 CONIOLO 6072 FRASSINELLO MONFERRATO 6073 FRASSINETO PO 6077 GABIANO 6082 GIAROLE 6094 MIRABELLO MONFERRATO 6097 MOMBELLO MONFERRATO 5069 MONCALVO 6099 MONCESTINO 6109 MORANO SUL PO 6113 MURISENGO 6115 OCCIMIANO 6116 ODALENGO GRANDE 6117 ODALENGO PICCOLO 6118 OLIVOLA 6120 OTTIGLIO 6123 OZZANO MONFERRATO 6131 POMARO MONFERRATO 6133 PONTESTURA 6135 PONZANO MONFERRATO 6149 ROSIGNANO MONFERRATO 6150 SALA MONFERRATO 6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 6159 SERRALUNGA DI CREA 6164 SOLONGHELLO 6171 TERRUGGIA 6173 TICINETO 6175 TREVILLE 6178 VALMACCA 6179 VIGNALE MONFERRATO 6182 VILLADEATI 6184 VILLAMIROGLIO 6185 VILLANOVA MONFERRATO SUB AMBITO 03 – NOVESE TORTONESE ACQUESE E OVADESE ISTAT COMUNE 6001 ACQUI TERME 6002 ALBERA LIGURE 6005 -

La Situazione Congiunturale in Provincia Di Alessandria L'inf0rmatore Economico N
1 05 LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA L'INF0RMATORE ECONOMICO N. 3/2005 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA Supplemento alla Rassegna Economica n. 3/2005 Autorizzazione Dir. Prov. P.T. Alessandria Pubblicità inferiore al 50% 1 3 05 Pubblicazione trimestrale edita a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria Direttore: Renato Viale Direttore responsabile: Severino Bruno Fara Redazione: Ufficio Studi C.C.I.A.A. Direzione ed Amministrazione: Via Vochieri. 58 - tel 03/33 Impaginazione: Lo studio Alessandria Supplemento alla Rassegna Economica n. 3/2005 Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c Legge 662/96 Aut. Ente Poste Filiale di Alessandria Autorizzazione n. 5 Decreto Tribunale di Alessandria del 0/0/948 e successive variazioni La presente pubblicazione è stata elaborata dall'ufficio studi della Camera di Commercio di Alessandria con le informazioni disponibili al 30 settembre 2005 Collaborano: Associazione Commercianti – Alessandria Collegio Costruttori Edili – Alessandria Federazione Coltivatori Diretti – Alessandria INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica Provincia di Alessandria – Direzione Economia e Sviluppo – Servizio Lavoro Provincia di Alessandria – Direzione Economia e Sviluppo – Servizio Turismo Regione Piemonte Tribunale di Alessandria Unioncamere Nazionale Unioncamere Piemonte Si ringraziano inoltre le aziende manifatturiere e commerciali che hanno contribuito alla -
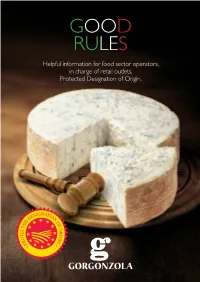
Good Rules Helpful Information for Food Sector Operators, in Charge of Retail Outlets
GOOD RULES Helpful information for food sector operators, in charge of retail outlets. Protected Designation of Origin. GNAT ESI IO D N D O E F T O C R E I G T I O N R • P • P. D.O. GORGONZOLA CHEESE With these brief notes we just wish to remind you of a few “important details” concerning the use of the Protected Designation of Origin for “Gorgonzola” cheese (upon slice sale, pre-packed sale, preparation of speciality food products, etc.), which, during our inspections of Retail Outlets, we have found to be inadequate, unconformable or even prosecutable. In line with the mutually beneficial relationship that exists among those involved in the “fieldwork”, we would like to thank you in advance for the time you may wish to devote to us. The Ispectors of the Consortium for the Protection of Gorgonzola Cheese THE PRODUCT SOFT TABLE CHEESE MADE FROM UNHEATED CURD, BELONGING TO THE CATEGORY OF MOULD-RIPENED CHEESES, (CHEESES FEATURING A RANGE OF VERTICAL BLUE AND GREEN VEINS, ALSO REFERRED TO IN ITALIAN AS “ERBORINATURA”). THERE ARE TWO VARIETIES ON SALE: SWEET SPICY GORGONZOLA GORGONZOLA CHEESE CHEESE Origin branding performed on both faces of thecheese wheel, bearing the initials CG, as well as the identification number of the of the applica- ble cheese factory. Branding upon placing on the market, by means of the second identification mark re- lated to P.D.O. Gorgonzola cheese: this consists in individual embossed aluminium sheets used to wrap the vari- ANDING ous portions of product. Upon placing the product on the market, it will al- R ways be necessary to trace back to the origin and to the specific batch of the product on display, marketed and/or used by the Retail Outlet. -

040607 Campanini Tabella Manutenzioni Aipo Piemonte 07
AIPO - PIANO DI MANUTENZIONE 2007 DEI CORSI D'ACQUA DEL PIEMONTE N. UFFICIO STIMA DEI COSTI DEL PROG. OPERATIVO DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO CORSO D'ACQUA PROGRAMMA PRIMO PROV. (1) AIPO ANNO 2007 Consolidamento briglia sul T,.te Gesso in comune di 1AL Torrente Gesso € 500.000,00 CN Cuneo Manutenzione alle opere di difesa del t.te Stura di 2AL Stura di Demonte € 150.000,00 CN Demonte in comune di Demonte,ponte Perdioni Manutenzione del t.te Rotaldo in comuni vari fino alla 3AL Torrente Rotaldo € 110.000,00 AL cofluenza con il f. Po Manutenzione dell'alveo e delle opere di difesa 4AL Sesia € 90.000,00 VC spondale del f. Sesia in comune di Serravalle Sesia Spese relative a convenzioni stipulate ai fini delle 5ALmanutenzioni delle opere idrauliche e per servizio di € 70.000,00 piena Lavori di sfalcio per inghiaiamento argini dal comune 6AL Po € 300.000,00 VC - AL di Crescentino a Casale M.to e Valenza Po Lavori di sfalcio per inghiaiamento argini maestri 7AL Po € 162.000,00 AL 2^cat. - II T.C. Lavori di manutenzione arginale f. Sesia in sx e in dx 8AL Sesia € 235.000,00 VC-NO da Romagnano Sesia a confluenza Po e affluenti Lavori di manutenzione argini in dx e Sx f. Tanaro 9ALda Castagnole Lanze sino alla confluenza Bormida- Tanaro € 230.000,00 AT-CN CN Manutenzione argine in dx f. Bormida ed in Dx Tanaro 10 AL Tanaro € 100.000,00 AL in comune di Alessandria fino confluenza Po Sfalcio argini del t.te Belbo da S. -

Il Turismo Nell'area Del Parco Di Crea
Il turismo nell’area del Parco di Crea. Ires Piemonte (Maurizio Maggi, Carlo Beltrame, Elena Ciarli, Emanuela Giorgini) marzo 2002 PARTE PRIMA: Il quadro territoriale di Crea e l’analisi dell’intorno 1. Il quadro territoriale allargato - Crea, il Santuario, il Parco - Il quadro europeo - Il quadro regionale 2. I Piani territoriali provinciali - Il PTP di Alessandria - Il PTP di Asti - Il PTP di Vercelli 3. Il quadro locale - Fra Basso Monferrato e risaie - La città di Casale - Il quadro occupazionale - Il quadro turistico PARTE SECONDA: Domanda e offerta turistica 1. Il contesto locale 2. La domanda turistica - Costi e benefici del turismo - Trend recenti e prospettive - L’indagine sul pubblico 3. L’offerta del territorio - Le strutture di accoglienza - Il turismo itinerante - Gli itinerari 4. Aspetti qualitativi 5. Proposte di intervento a livello locale 6. Conclusioni 7. Nota metodologica Il presente rapporto è opera di un gruppo di lavoro composto da Carlo Beltrame (autore del- la Parte prima), Elena Ciarli (autrice del capitolo 4 parte seconda), Emanuele Giorgini (autri- ce dei capitoli 2 e 7, parte seconda) e Maurizio Maggi (coordinatore). La responsabilità di quanto scritto è interamente da attribuirsi all’Ires Piemonte. Il turismo nell’area del Parco di Crea 1 PARTE PRIMA Il QUADRO TERRITORIALE DI CREA E L’ANALISI DELL’INTORNO Il turismo nell’area del Parco di Crea 2 1. IL QUADRO TERRITORIALE ALLARGATO Il turismo nell’area del Parco di Crea 3 CREA, IL SANTUARIO, IL PARCO Crea, il Santuario e l’area a parco naturale, sono certamente la località più “visitata” della provincia di Alessandria e tra le più “visitate” del Piemonte. -

Curriculum Ing. Sandiano 20151021
Sandiano ing. Stefano Curriculum professionale Sandiano ing. Stefano _______________________________________________________________________________________________________________________ 2__ CURRICULUM PROFESSIONALE Dati Anagrafici: Cognome : SANDIANO Nome: STEFANO Data e luogo di nascita: 13/11/1973 – TORINO Telefono: 0131/288369 Obblighi di leva: AUC corpo tecnico degli Ingegneri Incorporamento: 15/06/99 Congedo: 14/08/00 Attività svolta: ufficio gare pubblici incanti/economia (DPR 939) presso 5^ Direzione Genio Militare di Padova Studio Tecnico: Sede legale: 15020 CERESETO M.TO – AL – Via Cistilliano 19/A Tel: 0142/940129 Sede operativa: 15121 – ALESSANDRIA – Via Aspromonte, 16 Tel./fax.: 0131/288369 e-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Sede Operativa: Via Aspromonte, 16 – 15121 Alessandria – Tel/Fax 0131 288369 Sandiano ing. Stefano _______________________________________________________________________________________________________________________ 3__ Excursus scolastico: • Anno scolastico 1991/92: Diploma di maturità Scientifica: 48/60 - Liceo Scientifico Statale “Palli” – Casale M.to • Anno scolastico 1992/93: Diploma di Maturità Tecnica per Geometri: 45/60 – Ist. Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Leardi” - Casale M.to • Anno accademico 1998/99: Laurea in Ingegneria Civile 110/110 – Politecnico di Torino – II Facoltà di Ingegneria con sede in Vercelli Titolo della tesi: “Influenza delle tecniche di riconsolidazione sulla deformabilità delle argille naturali e ricostituite” -

Scarica Il Documento
Progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23.02.2010 Allegato 1 Schede descrittive delle mappe di pericolosità sul Reticolo Principale (fonti, criteri, livelli di confidenza) 22 DICEMBRE 2014 Indice Adda Sopralacuale 01 Nirone 83 Adda Sottolacuale 03 Nure 85 Agogna 05 Oglio Sopralacuale 87 Arda 07 Oglio Sottolacuale 89 Arno 09 Olona 91 Baganza 11 Olona Meridionale 93 Banna 13 Ongina 95 Belbo 15 Orba 97 Borbera 17 Orco 99 Bormida 19 Panaro 101 Bozzente 21 Parma 103 Brembo 23 Pellice 105 Casternone 25 Po 107 Ceronda 27 Po Delta 111 Cervo 29 Pudiga 113 Cherio 31 Rile 115 Chiavenna 33 Rotaldo 117 Chiese 35 Sangone 119 Chisola 37 Scrivia 121 Chisone 39 Secchia 123 Chiusella 41 Serio 125 Crostolo 43 Sesia 127 Dora Baltea 45 Seveso 129 Dora Ripara 47 Stirone 131 Elvo 49 Stura del Monferrato 133 Enza 51 Stura di Demonte 135 Garbogera 53 Stura di Lanzo 137 Garza 55 Stura di Ovada 139 Grana 57 Tanaro 141 Grana-Mellea 59 Taro 143 Guisa 61 Tenore 145 Lambro 63 Terdoppio 147 Lambro Meridionale 65 Ticino 149 Lemina 67 Tiepido 151 Lura 69 Toce 153 Maira 71 Trebbia 155 Malone 73 Tresinaro 157 Mella 75 Trobbia 159 Mera 77 Varaita 161 Mincio 79 Molgora 81 Corso d'acqua Adda sopralacuale da Crosio Bacino Adda a Lago di Como Bacino Valtellina Lunghezza Km 132 secondario Dati disponibili e fonti Scenari di alluvione Tempo di ritorno Alluvioni frequenti x 20 Limiti delle aree inondabili Alluvioni poco frequenti x 200 Alluvioni rare x 500 Portate e livelli di piena in Alluvioni frequenti x 20 corrispondenza delle sezioni del Alluvioni poco frequenti x 200 modello Alluvioni rare x 500 Alluvioni frequenti x 20 Velocità medie in corrispondenza Alluvioni poco frequenti x 200 delle sezioni del modello Alluvioni rare x 500 Studi Alluvioni frequenti Studio prov. -

Regione Piemonte
Regione Piemonte - Uffici postali abilitati Invio delle istanze di nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri relativamente al lavoro subordinato, domestico, stagionale Provincia Comune Località Denominazione Indirizzo ufficio postale ALESSANDRIA ACQUI TERME ACQUI TERME ACQUI TERME VIA E. TRUCCO, 27 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA CENTRO PIAZZA LIBERTA', 23/24 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 5 VIA TESTORE, 28/30/32 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 6 PIAZZA PEROSI, 10 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 3 VIA CAVOUR, 55 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA CURIEL PIAZZA CURIEL, 8 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 4 PIAZZA CERIANA, 6/A ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 7 VIA GALVANI, 18/B ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 9 PIAZZA TORRIANI, 10 ALESSANDRIA ALESSANDRIA SAN GIULIANO VECCHIO SAN GIULIANO VECCHIO PIAZZA C. BATTISTI, 5 ALESSANDRIA ALESSANDRIA VALLE SAN BARTOLOMEO VALLE SAN BARTOLOMEO VIA DAZIO, 2 ALESSANDRIA ALESSANDRIA VALMADONNA VALMADONNA VIA COMUNALE, 68 ALESSANDRIA ARQUATA SCRIVIA ARQUATA SCRIVIA ARQUATA SCRIVIA VIA LIBARNA, 201 ALESSANDRIA BASALUZZO BASALUZZO BASALUZZO VIA STAZIONE, S.N. ALESSANDRIA BERGAMASCO BERGAMASCO BERGAMASCO VIA F. CAVALLOTTI, 1 ALESSANDRIA BORGHETTO DI BORGHETTO BORBERA BORGHETTO BORBERA VIA ROMA, 63 BORBERA ALESSANDRIA BOSCO MARENGO BOSCO MARENGO BOSCO MARENGO PIAZZA BOGGIANI, 21 ALESSANDRIA BOSIO BOSIO BOSIO VIA UMBERTO I, 43 ALESSANDRIA CANTALUPO LIGURE CANTALUPO LIGURE CANTALUPO -

Deliberazione Del Direttore Generale N. Del 2019/183 15/03/2019
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 Deli bera zio ne del Direttore Generale n. d el OGGETTO: STRUTTURA PROPONENTE il Responsabile del Procedimento artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241 Il Responsabile Registrazione contabile Esercizio Conto Importo I l Dirigente R espon sabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Reg ion al e in data approvata in data______ ______ __ a Trasmessa al Collegio Sindacale in data __ _____ ______ _ Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali -Relazioni istituzionali- Tutele-Attività Ispettiva Azienda Sanitaria Locale AL . C.F./P.I. 02190140067 Pagina 1 di 6 Deliberazione n. 2019/183 OGGETTO: Deliberazione n. 632 del 17.09.2015 “D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015 - Ridefinizione degli ambiti territoriali distrettuali”: modifica della composizione del Distretto di Alessandria - Valenza a seguito di fusione di Comuni in Provincia di Alessandria. IL DIRETTORE GENERALE Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; Vista la D.G.R.