DOWNLOAD Relazione up 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Erg S.P.A. Annual Report As at 31 December 2018 2 Annual Report 2018
ERG S.P.A. ANNUAL REPORT AS AT 31 DECEMBER 2018 2 ANNUAL REPORT 2018 CONTENTS 1 DIRECTOR’S REPORT Statement of Financial position ............................... 103 Introduction ................................................................... 5 Alternative performance indicators ........................ 109 Corporate bodies ......................................................... 8 Financial Statements of ERG S.p.A. ........................ 115 Business description .................................................. 9 Treasury shares ........................................................... 125 Organisational model ................................................. 14 Branch offices .............................................................. 125 Strategy .......................................................................... 16 Transactions with related parties ............................ 125 Change in business scope in 2018 .......................... 19 Significant events after the balance ERG’s stock market performance ........................... 24 sheet date ...................................................................... 127 Significant events during the year ........................... 26 Business outlook ......................................................... 128 Performance highlights ............................................. 29 Performance by sector .............................................. 30 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE Comments on the year’s performance .................. 31 AND OWNERSHIP ............................................... -

Annual Report 2018
Annual Report 2018 @UPetrolifera unionepetrolifera.it 2018 06.542.3651 Piazzale Luigi Sturzo, 31 00144 Roma - Fax 06 596.029.25 [email protected] REPOT ANNUAL D D A A A A I I 7 L 7 L 0 A 0 A A IT A IT N Lʼ N Lʼ N E N E I F ER I F ER AC OV AC OV CIAMO MU CIAMO MU Annual Report 2018 D A A I 7 L 0 A A IT N Lʼ N E I F ER AC OV CIAMO MU ANNUAL REPORT 2018 ORGANIZATIONAL STRUCTURE (May 30, 2018) President Guido OTTOLENGHI Claudio SPINACI Giorgio PROFUMO Dario SCAFFARDI Vice Presidents Gian Luigi TRIBOLDI Daniele BANDIERA Alessandro GILOTTI Board of Auditors Paolo GROSSI Antonio PALUMBIERI (President) Gianni MURANO Giuseppe CEMBROLA Fabrizio GRANDINETTI General Council Orazio DRISALDI (Substitute) Italo BELLOTTO Emanuele MURIANNI (Substitute) Ugo BRACHETTI PERETTI Giuseppe BUONERBA Arbitrators Claudio COVINI Carlo CITTADINI Nello D’ALESIO Getulio CURZI Oleg DUROV Alessandro GARRONE Pio MIRGONE Antonio LAZZARINETTI Massimo QUADRELLI Luca LUTEROTTI Carlo RANESI Maurizio MIGLIAROTTI Piero NERI General Manager Alessandro ORSINI Marina BARBANTI ° D 70 A 7 0 A N IA N L I TA FA ʼI C L CI RE AMO MUOVE ANNUAL REPORT 2018 MEMBER COMPANIES (May 30, 2018) ALMA PETROLI LA PETROLIFERA ITALO-RUMENA API - ANONIMA PETROLI ITALIANA LUKOIL ITALIA API RAFFINERIA DI ANCONA NERI DEPOSITI COSTIERI ATTILIO CARMAGNANI “AC” PETRA BP ITALIA PETRONAS LUBRICANTS ITALY CARBOIL PETROVEN COSTIERI D’ALESIO RAFFINERIA DI GELA DECAL RAFFINERIA DI MILAZZO DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO RAFFINERIA DI ROMA DISMA SARAS ENI REFINING & MARKETING S.A.R.P.O.M. -

Obligationsliste Eng.Pdf
Corporate, financial and foreign government bonds, end-June 2021 Market value, million ISIN Issuer Security Description Country Sector EUR IE00BD6G9P01 BLK HY S COR-A USD FOUND Blackstone High Yield Systemat Multinational Funds 127.0 LU0772946512 NORDEA 1-EUROP FIN DEBT-XEUR Nordea 1 - European Financial Multinational Funds 69.5 XS1217882171 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA KOMLAN 4 1/4 06/10/45 Norway Financial 24.9 XS1117286580 DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 Denmark Financial 24.1 DK0030386610 DANSKE BANK A/S DANBNK Float PERP Denmark Financial 16.0 DK0030352471 NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 4 1/8 PERP Denmark Financial 15.2 CH0271428309 UBS GROUP AG UBS 5 3/4 PERP Switzerland Financial 14.7 XS1886605333 BENWB FINANCE SA BENWBF 2.092 11/19/30 Luxembourg Financial 14.4 BRSTNCLTN7S1 LETRA TESOURO NACIONAL BLTN 0 01/01/24 Brazil Sovereign 12.3 DK0030420492 VELLIV PENSION & LIV NLPNDK Float 06/08/28 Denmark Financial 12.3 XS1299724911 KUNTARAHOITUS OYJ KUNTA 4 1/2 PERP Finland Regional Agencies 11.7 BRSTNCNTF170 NOTA DO TESOURO NACIONAL BNTNF 10 01/01/25 Brazil Sovereign 11.6 BRSTNCNTF1P8 NOTA DO TESOURO NACIONAL BNTNF 10 01/01/27 Brazil Sovereign 11.3 ZAG000106998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 01/31/30 South Africa Sovereign 10.4 DK0030487996 NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 7/8 07/28/31 Denmark Financial 10.0 MX0MGO0000D8 MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 1/2 06/03/27 Mexico Sovereign 9.9 XS1591694481 TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP Netherlands Utilities 9.8 XS1190987427 DANSKE BANK A/S DANBNK 5 7/8 PERP Denmark Financial 8.9 IDG000010802 -
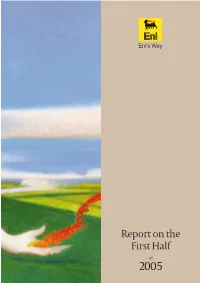
Report on the First Half
Report on the First Half of 2005 Mission Eni is one of the most important integrated energy companies in the world operating in the oil and gas, power generation, petrochemicals, oilfield services construction and engineering industries. In these businesses it has a strong edge and leading international market positions. Eni’s objective is to create new value to meet its shareholders expectations through the continuous improvement of cost efficiency and the quality of its products and services and through the attention to the needs of its employees and the commitment to a sustainable growth pattern also encompassing the careful assessment of the environmental impact of its activities and the development of innovative and efficient technologies. To achieve this objective Eni relies on the managerial and technical capabilities as well as the continuous development of its workforce, and on an increasingly lean and entrepreneurial organization. BOARD OF DIRECTORS (1) BOARD OF STATUTORY AUDITORS (7) Chairman Chairman Roberto Poli (2) Paolo Andrea Colombo Managing Director Statutory Auditors Paolo Scaroni (3) Filippo Duodo, Edoardo Grisolia, Riccardo Perotta, Directors Giorgio Silva Alberto Clô, Renzo Costi, Dario Fruscio, Alternate Auditors Marco Pinto, Marco Reboa, Francesco Bilotti, Massimo Gentile Mario Resca, Pierluigi Scibetta MAGISTRATE OF THE COURT OF ACCOUNTS DELEGATED TO THE CONTROL OF ENI SpA’S GENERAL MANAGERS FINANCE ACCOUNTING Exploration & Production Division Luigi Schiavello (8) (4) Stefano Cao Alternate Gas & Power Division Angelo Antonio Parente (9) Luciano Sgubini (5) Refining & Marketing Division External Auditors (10) Angelo Taraborelli (6) PricewaterhouseCoopers SpA The composition and powers of the Internal Control Committee, (5) Appointed by the Board of Directors on January 30, 2001 Compensation Committee and International Oil Committee are presented (6) Appointed by the Board of Directors on April 14, 2004 (7) Appointed by the Shareholders’ Meeting held on May 27, 2005 in the “Other Information” section of the Report of the Directors. -

Competition Law in Italy the First 20 Years of Law and Practice
Mario Siragusa – Matteo Beretta – Matteo Bay Competition Law in Italy The first 20 years of law and practice CONTENTS I. INTRODUCTION A. General Comparison of Italy’s Competition Laws, Enforcement, Procedures with Those of the United States B. Overview of Applicable Statutes 1. Main Legislative Reforms (a) Interim Measures (b) Commitments (c) Leniency Program 2. Relationship between EU and National Competition Rules C. Overview of Structure, Independence and Jurisdiction of Enforcement Agencies D. Overview of Structure, Independence, and Jurisdiction of Judicial Authorities E. Additional Policy & Practical Considerations 1. Costs and Time Considerations in Litigation 2. Costs and Time Considerations in Administrative Proceedings 3. Intervention of Agencies and Political Bodies in Litigation II. OVERVIEW A. General Policies Underlying Italy’s Competition Laws 1. Consumer Welfare 2. Protection of Smaller Enterprises Against Larger Enterprises 3. Protection of Domestic Enterprises Against Foreign Competition B. Role of Economic Doctrines and Analysis 1. Generally 2. Use of Specific Economic Analysis 3. Extent to Which Courts Have Embraced Economic Analysis III. SUBSTANTIVE LAW A. Horizontal Agreements and Practices 1. General Principles (a) Introduction (b) The Notion of “Undertaking” (c) Agreements, Decisions, and Concerted Practices (d) Restrictive Object or Effect (e) Appreciability of the Restriction (f) The Burden of Proof (g) Reliability of Documentary Evidence (h) Relevance of Criminal Findings in the Context of the Competition Authority’s -

RELAZIONE ANNUALE 2015 Gli Organi Sociali
RELAZIONE ANNUALE 2015 Gli organi sociali (30 Maggio 2015) Presidente Collegio dei Revisori Contabili Alessandro GILOTTI Lucia BORMIDA Antonio PALUMBIERI Vice Presidenti (Presidente) Daniele BANDIERA Fabrizio SCANU Angelo FANELLI Giuseppe CEMBROLA Gianni MURANO (Supplente) Claudio SPINACI Orazio DRISALDI Consiglio Direttivo (Supplente) Alessandro GARRONE Claudio GERACI Probiviri Luca LUTEROTTI Carlo CITTADINI Maurizio MIGLIAROTTI Getulio CURZI Guido OTTOLENGHI Pio MIRGONE Dario SCAFFARDI Massimo QUADRELLI Carlo RANESI Giunta Italo BELLOTTO Direttore Generale Ugo BRACHETTI PERETTI Pietro DE SIMONE Claudio COVINI Giuseppe D’ARRIGO Oleg DUROV Alessandro GARRONE Antonio LAZZARINETTI Luca LUTEROTTI Maurizio MIGLIAROTTI Edoardo MIRGONE Philippe NELIS Piero NERI Guido OTTOLENGHI Giorgio PROFUMO Dario SCAFFARDI Gian Luigi TRIBOLDI Relazione Annuale 2015 Le aziende associate (30 Maggio 2015) ALMA PETROLI NERI DEPOSITI COSTIERI API - ANONIMA PETROLI ITALIANA PETRA API RAFFINERIA DI ANCONA PETROLIG ATTILIO CARMAGNANI “AC” PETRONAS LUBRICANTS ITALY BP ITALIA PETROVEN COSTIERI D’ALESIO RAFFINERIA DI MILAZZO DECAL RAFFINERIA DI ROMA DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO SARAS DISMA S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata ENI REFINING & MARKETING Raffineria Padana Oli Minerali ERG SPA SERAM ESSO ITALIANA SHELL ITALIA OIL PRODUCTS GAZPROM NEFT LUBRICANTS SIGEMI IES- ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.I.O.T. Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino IPLOM SUPERBA ISAB TAMOIL ITALIA KRI TOSCOPETROL KUWAIT PETROLEUM ITALIA TOTALERG LA PETROLIFERA ITALO-RUMENA -

Annual Report 2005
Annual Report 2005 approved by Eni’s Board of Directors on 30 March 2006 MISSION We are a major integrated energy company, committed to growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas. Eni men and women have a passion for challenges, continuous improvement, excellence and particularly value people, the environment and integrity Countries of activity EUROPE Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, United Kingdom CIS Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Russia AFRICA Algeria, Angola, Cameroon, Chad, Congo, Egypt, Guinea Bissau, Libya, Morocco, Nigeria, Senegal, Somalia, South Africa, Sudan, Tunisia MIDDLE EAST Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates CENTRAL ASIA India, Pakistan SOUTH EAST ASIA AND OCEANIA Australia, China, Indonesia, Japan, Malaysia, Papua-New Guinea, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam AMERICAS Argentina, Brazil, Canada, Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad & Tobago, United States, Venezuela Annual Report 2005 This Annual Report includes the report of Eni’s Board of Directors and Eni’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2005, which have been prepared under the International Financial Reporting Standards (IFRS), as adopted by the European Union. 30 March 2006 Report of the Directors 4 Profile of the year 8 Letter -

View Annual Report
ERG S.P.A. ANNUAL REPORT AS AT 31 DECEMBER 2017 ANNUAL REPORT AS AT 31 DECEMBER 2017 2 ANNUAL REPORT AS AT 31ST DECEMBER 2017 TABLE OF CONTENTS Letter to Shareholders ................................................ 4 Financial Statements ........................................... 100 Alternative performance indicators ........................ 107 ERG S.p.A. Financial Statements ........................... 112 1 REPORT ON OPERATIONS Significant events after the reporting period ........ 120 Corporate Bodies ........................................................ 10 Business Outlook ......................................................... 122 Introduction .................................................................. 11 Business Description .................................................. 14 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE Strategy .......................................................................... 17 AND OWNERSHIP ................................................ 124 ERG’s Stock Market performance ........................... 19 Executive summary .................................................... 125 Performance highlights ............................................. 20 History of the governance structure ....................... 135 Performance highlights by sector ........................... 21 Information about the ownership structure as of Sales ............................................................................... 22 December 31, 2015 pursuant to art. 123-bis of Comments on the year’s performance ................. -

Energy and Utilities Sector Roundtable
REPRINT | FINANCIER WORLDWIDE MAGAZINE ROUNDTABLE ENERGY AND UTILITIES SECTOR ������������������������������������� �������������� ������������������ �������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� REPRINTED FROM: � � � �������������� DECEMBER 2010 ISSUE ����������������������������������������� � ���������� �������������������������������� � ���������� ������������������������� © 2010 Financier Worldwide Limited. ������������������������ �������������������������� Permission to use this reprint has been granted by the publisher. Magazine-Dec10.indd 1 16/11/10 15:16:25 www.financierworldwide.com FWMAGAZINE ENERGY AND UTILITIES SECTOR ROUNDTABLE ENERGY AND UTILITIES SECTOR The economic crisis has forced a new age of dynamism on the energy sector, framed by environmental issues and concerns about energy security. While renewables are starting to enter the mainstream, shale gas is becoming increasingly lucrative, however there is debate as to whether the ‘nuclear renaissance’ has, or will ever arrive. THE MODERATOR Jeffrey R. Holzschuh Jeffrey R. Holzschuh is vice chairman of Institutional Securities Group and chairman Chairman of the Global Power and Utility Group, of Morgan Stanley’s Global Power and Utility Group. He has been actively involved in Morgan Stanley many of the industry’s largest mergers and acquisitions and a wide variety of advisory T: +1 (212) 761 4711 and financing transactions. He also serves as the chairman of Morgan Stanley’s E: [email protected] Environmental Policy Committee, and has been appointed by the US Secretary of www.morganstanley.com Energy to serve on the US Electricity Advisory Board. 2 | FW December 2010 | www.financierworldwide.com ROUNDtable THE PANELLISTS Florian Haslauer Florian Haslauer is a partner at A.T. Kearney and leads the EMEA Utilities Practice. He Partner, A.T. Kearney has successfully led consulting projects for major European Utilities with a focus on +43 1 53 667 0 T: business strategy, organisational development and performance improvement. -

A Inserção Do Biodiesel Na Matriz Energética Nacional: Aspectos Socioeconômicos, Ambientais E Institucionais
A INSERÇÃO DO BIODIESEL NA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS Angela Oliveira da Costa Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Planejamento Energético, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Planejamento Energético. Orientador: Luiz Pinguelli Rosa Rio de Janeiro Abril de 2017 A INSERÇÃO DO BIODIESEL NA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS Angela Oliveira da Costa TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. Examinada por: ______________________________________________ Prof. Luiz Pinguelli Rosa, D.Sc. ______________________________________________ Prof. Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas, Ph.D. ______________________________________________ Prof. Neilton Fidélis da Silva, D. Sc. ______________________________________________ Dr. Luciano Basto Oliveira, D.Sc. ______________________________________________ Profª. Adriana Fiorotti Campos, D.Sc. RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL ABRIL DE 2017 Costa, Angela Oliveira da A Inserção do Biodiesel na Matriz Energética Nacional: Aspectos Socioeconômicos, Ambientais e Institucionais/ Angela Oliveira da Costa – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2017. XV, 248 p.: il.; 29,7 cm. Orientador: Luiz Pinguelli Rosa Tese (doutorado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de Planejamento Energético, 2017. Referências Bibliográficas: p. 217-248. 1. Biodiesel. 2. Energia. 3. Planejamento. I. Rosa, Luiz Pinguelli. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Planejamento Energético. III. Título. iii Dedicatória À minha filha Isabel, por tanto amor. À minha mãe Neuza e ao meu pai Adilson, pelo sonhar e por tudo que pude ser. -

Inter Vis Ta Camer Petroleum: Così Il Settore
21 DICEMBRE 2018 PERCHÉ LE FRODI CONTINUANO A DILAGARE Un fenomeno “dilagante”, “degenerativo”, che sta bero valere anche un quarto del mercato. “sfigurando” il settore, cambiandone letteralmente Il punto è che diversi operatori sono già arrivati a gettare la i connotati. Si fanno sempre più fosche e cruente le spugna, nonostante gli sforzi delle associazioni di settore descrizioni del fenomeno delle frodi nella distribu- per arginare la deriva. In una realtà economica in cui, oltre EDITORIALE zione carburanti. E mentre i toni si alzano, la realtà tutto, il tradizionale presidio delle grandi società petrolifere continua ad andare per i fatti propri, le transazioni è sostanzialmente venuto meno. La speranza di riportare il sospette si moltiplicano, il giro d’affari del circuito mercato su binari di legalità inizia ad affievolirsi. E tanti ini- parallelo continua ad aumentare. Una quantità di ziano a pensare che quello che manca sia la volontà politica denaro che viene in parte “reinvestita” nell’acquisto di affrontare il problema di petto. di punti vendita e depositi, alimentando la metamorfosi del Un problema che non riguarda solo i punti vendita carbu- settore, e in parte finisce probabilmente a quel “secondo ranti sulla rete stradale: c’è infatti l’aspetto dell’extrarete, livello” della criminalità organizzata che diverse inchieste ovvero delle forniture al di fuori delle stazioni di servizio, a della magistratura hanno individuato come punto di regia società di autotrasporto, a enti pubblici, e per tutti quegli e controllo del fenomeno. usi che non passano dai “benzinai”. Un comparto in cui la Al quadro normativo manca ancora una circolare interpre- degenerazione ha raggiunto livelli che in molti giudicano tativa, quella relativa al comma 943 della Legge di bilancio irreversibili. -

Il Caso Aziendale Api-IP-Total Erg ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Dipartimento di Impresa e Management Cattedra: Finanza Aziendale Le strategie di M&A: il caso aziendale api-IP-Total Erg RELATORE Prof. Arturo Capasso CANDIDATO Andrea Liberatori Matr.197891 ANNO ACCADEMICO 2017/2018 1 INDICE INTRODUZIONE ………………………………………………………………..3 CAPITOLO I: Le strategie di crescita aziendale: le operazioni di M&A …………4 1.1 Cosa si intende per acquisizioni aziendali?..............................................4 1.2 Motivazioni e finalità delle M&A………………………………………………5 1.3 Meccanismi di acquisizione e regolamentazione…………………………..7 1.4 Analisi storica: “le diverse ondate” …………………………………………10 1.5 Il ruolo del management………………………………………………………13 1.6 Il ruolo geografico nelle M&A: i cross-border……………………………….14 1.7 Mercati reali e finanziari e la creazione di valore economico nelle operazioni di acquisizione………………………………………………………………….15 CAPITOLO II: La storia dell’api nel contesto del mercato petrolifero………………………………………………………..…………………………18 2.1 Il mercato petrolifero downstream…………………………………………….18 2.2 Cenni sulla storia e sullo sviluppo della società api…………………………20 CAPITOLO III: Analisi del caso aziendale api-IP-Total Erg…………………………21 3.1 L’acquisizione della IP………………………………………………………….21 3.2 Descrizione dell’operazione e valutazione preliminare da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato………………………………………..22 3.3 Operazione societaria ed effetti conseguenti sulle voci di bilancio………..25 3.4 L’integrazione del personale delle due società………………………………27 3.5 Considerazioni finali sull’operazione e sugli anni successivi……………….28 3.6 L’acquisto del 100% delle azioni della società Total Erg…………………..29 CONCLUSIONI……………………………………………………………………………..31 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………….33 2 SITOGRAFIA……………………………………………………………………………….34 INTRODUZIONE Le acquisizioni rappresentano le diverse modalità attraverso cui è possibile ottenere il controllo di un’azienda, sia esso totale o parziale.